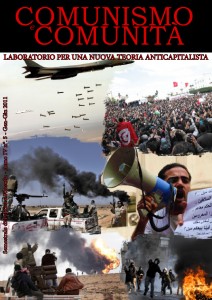Il materiale, l’immateriale e il conflitto
feb 21st, 2025 | Di Thomas Munzner | Categoria: StoriaIl materiale, l’immateriale e il conflitto
di Piero Pagliani
Andrei Martyanov è un ex ufficiale di marina russo che dissoltasi l’URSS si è trasferito negli Stati Uniti di cui è diventato cittadino. Pluridiplomato in prestigiose accademie militari sovietiche ha una solida formazione scientifica. Ritiene che la scarsa formazione nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) degli attuali ufficiali statunitensi e NATO sia una delle cause per cui l’Occidente non ha idea di come si conduca un grande conflitto continentale ad armi combinate come quello in Ucraina. A ciò si aggiunge una impossibilità materiale a combatterlo dovuta alla finanziarizzazione delle economie occidentali e alla loro deindustrializzazione. Non solo, ma proprio la finanziarizzazione secondo Martyanov ha portato a una diminuzione degli studi scientifici. A queste difficoltà se ne aggiunge una storica: gli Stati Uniti, l’unica vera potenza occidentale, non hanno mai combattuto per la propria difesa ma hanno condotto solo “expeditionary wars”.
La sfera di competenza delle analisi di Martyanov riguarda i rapporti di forza militari tra le grandi potenze – intesi nel senso ampio visto sopra – considerati fattori geopolitici dirimenti.
In questa sfera la sua critica è puntuale e informata, specialmente dal punto di vista della “operational art” nella guerra e dei suoi risvolti fisico-matematici.
Alle spalle dei rapporti di forza Martyanov vede dunque la potenza industriale delle nazioni. E la potenza industriale è valutata in base ai suoi “tangibles” in contrapposizione agli “intangibles” finanziari. Fin qui l’analisi è condivisibile, almeno parzialmente (vedremo nella nota [3] che non in tutti i contesti il livello di industrializzazione è un fattore sufficiente per vincere un conflitto tra stati – il Vietnam ne è una riprova; per le guerriglie e le insorgenze, come in Afghanistan, il discorso è ulteriormente diverso).
Tuttavia, oltre ad altri aspetti che però non rientrano nel discorso che intendo fare adesso, intravedo una limitazione nelle analisi di Martyanov in una sua riluttanza a vedere il “tangible” dietro gli “intangibles”. Che non è un paradosso se per “tangible” si intende la concretezza del rapporto sociale capitalistico e dei processi di accumulazione.
Analizzandola si scoprirebbe ad esempio che la finanziarizzazione è un evento ricorrente nella storia capitalistica, non è una sua aberrazione né il frutto di un golpe di banchieri e finanzieri o di qualche entità misteriosa che sovrasta i poteri nazionali, ma è conseguenza delle contraddizioni prodotte dall’accumulazione capitalistica. E che è in queste contraddizioni che va ricercata la radice della guerra.
In ciò Martyanov è contraddittorio. Si capisce qua e là che ha dovuto studiare Marx, che in qualche modo ne ha stima, ma avendo apertamente accettato il capitalismo ha un rifiuto esistenziale a servirsene.
Eppure se non si parte dai rapporti sociali che sottendono i processi capitalistici di accumulazione e se non se ne riconosce la natura reale, la dinamica profonda degli eventi sfugge anche se si è in grado di descrivere gli avvenimenti e il loro esito “tecnico-politico” di breve-medio periodo con un grado di risoluzione e precisione ben superiore a quanto riesca a fare la gran parte di politici ed “esperti”, veri e propri incapaci (o impediti) con le credenziali e il lauro in testa (che ad esempio sul conflitto in Ucraina non ne hanno azzeccata nemmeno una per sbaglio). Che un analista di alto livello incappi in questa limitazione induce a fare delle riflessioni che analisti di bassa lega non stimolerebbero.
È impossibile capire i conflitti militari da 500 anni a questa parte, e a maggior ragione quelli degli ultimi due secoli, se non si considerano le contraddizioni del processo di accumulazione capitalistico. Contraddizioni però da considerare nella loro complessità (anche inter-nazionale) e quindi non riducibili al solo rapporto capitale/lavoro. In particolare bisogna tener presente che il capitalismo nasce “imperiale” e l’imperialismo è una sua ricorrenza. Così come sono ricorrenti le modalità della “accumulazione originaria”. Dal marxismo classico l’accumulazione originaria e l’imperialismo sono stati relegati a due fasi specifiche dello sviluppo capitalistico. La prima al suo inizio e il secondo alla sua maturazione. In realtà l’imperialismo può essere considerato una “fase” matura del capitalismo solo in un’ottica storicista ortodossa. Ottica che è stata organica a una particolare stagione del movimento operaio di ispirazione marxista e fotografava un’effettiva fase di sviluppo delle società “termocapitalistiche” [1], ma che non è sostenibile alla luce delle analisi di Fernand Braudel, Karl Polanyi, Giovanni Arrighi, David Harvey, Marcello De Cecco, Jason Moore, Costanzo Preve e dello stesso Marx.
Excursus 1. Imperialismo, espropriazione e accumulazione originaria
Per quanto riguarda Marx faccio riferimento al fatto che ha individuato la sequenza delle potenze egemoni dell’economia-mondo capitalistica: Venezia, Stati Iberici, Province Unite d’Olanda e Inghilterra fino a presagire il ruolo degli Stati Uniti. Tutte queste potenze sono coloniali o imperiali (i padri degli Stati Uniti usavano intercambiabilmente i termini “confederazione” e “impero”, un impero che doveva contrastare quello britannico).
Arrighi, che riprende la sequenza di Marx, sottolinea l’importanza per i processi di accumulazione della battaglia di Plassey, del 1757 nel Bengala, che segnò l’inizio della dominazione inglese nel subcontinente indiano la quale insieme ai saccheggi e ai tributi permise di ripianare i debiti inglesi coi banchieri olandesi e mise le industrie inglesi, tessili e metallurgiche, nella condizione di «generare disponibilità liquide superiori a quelle che erano in grado di riassorbire vantaggiosamente» ponendo l’Inghilterra in una posizione finanziaria privilegiata per la lotta per il potere in Europa. De Cecco mette in luce l’importanza dell’impero inglese nei processi di accumulazione europei. Jason Moore fa la stessa cosa in relazione alla possibilità inglese e poi europea di rifornirsi di “natura a buon mercato” (le risorse, comprese le fonti di calorie per sostenere l’aumento della popolazione nell’Europa che si stava industrializzando e per mantenere basso il costo del capitale variabile). Fernand Braudel mette in evidenza l’importanza del commercio di lunga distanza per l’inizio dell’accumulazione capitalistica vera e propria in Europa. Bisogna notare che anche la famosa analisi di Marx della caduta tendenziale del saggio di profitto cita come controtendenza il commercio internazionale. Costanzo Preve critica lo storicismo marxista ortodosso ma ne descrive l’importanza come supporto ideologico alla politica socialista incentrata sui “colletti blu”.
Per quanto riguarda la tematica della ricorrenza delle pratiche di accumulazione “originaria”, si veda ad esempio Claudia von Werlhof: «l’accumulazione originaria non è solo cronologicamente ma anche logicamente una parte integrante dell’accumulazione e possiede un carattere capitalistico evidente e non “pre-capitalistico” o “non-capitalistico”». David Harvey mette in relazione la ricorrenza delle modalità dell’accumulazione “originaria” col concetto di “espropriazione” (dispossession) definita infatti come «la continuazione e la proliferazione delle pratiche di accumulazione che Marx aveva trattato come “primitive” o “originarie” durante l’ascesa del capitalismo». Daniel Egan, contrapponendosi parzialmente ad Harvey, rilegge Marx e la Luxemburg per «rendere adeguatamente conto del ruolo svolto dalla guerra e dal potere militare nell’accumulazione di capitale oggi», sottolineando che «[i]l ruolo svolto dalla guerra come una forma di accumulazione primitiva è una funzione di stadi specifici dello sviluppo capitalistico».
Per finire, sulla scorta dell’analisi di Giovanni Arrighi dei cicli sistemici sostenevo in “Alla conquista del cuore della terra” che «la guerra come forma organica di violenza plurilaterale legata all’accumulazione del capitale ha … un carattere più ampio che non la specifica violenza intra-moenia analizzata da Marx nell’accumulazione originaria, anche se, al pari di questa, crea le basi dei cicli di espansione materiale [e ne] occupa la stessa posizione logica».
In ogni caso le politiche imperialiste e le pratiche di espropriazione si sovrappongono [2].
Ritornando alla conquista del subcontinente indiano, possiamo notare che le capacità navali-militari della piccola Inghilterra sopperirono alla limitata estensione geografica dell’isola, alla sua ridotta capacità economica, alla sua scarsità di risorse e facendo pendere al momento opportuno l’ago della bilancia dalla parte dell’espansionismo del Potere del Territorio resero possibile all’Inghilterra, tramite l’impero, un prolungato predominio per quanto riguarda il Potere del Denaro. Un esempio del complesso intreccio tra queste due diverse forme di potere che formano l’ossatura della ricostruzione storico-logica di Giovanni Arrighi delle dinamiche capitalistiche [3].
Le differenti miscele di Potere del Territorio e Potere del Denaro sono implicitamente presenti nel contrasto tra economie finanziarizzate ed economie reali i cui effetti sulle capacità militari sono sullo sfondo delle analisi di Martyanov. Tuttavia, come si è detto, oltre agli effetti di tale contrasto occorre analizzare anche le sue cause. Esse riconducono al rapporto tra Potere del Territorio e Potere del Denaro in quanto condizione dei processi di accumulazione la cui analisi richiede che i rapporti sociali siano i parametri ultimi di riferimento, pena cadere in un errore “scientista”.
Questo tipo di errore si può ripercuotere anche nella percezione dei cambiamenti. Considero un caso molto specifico ma di attualità. Il pur intelligente e preparato analista russo-statunitense commette a mio avviso un errore quando critica il termine “Intelligenza Artificiale”, IA, sostenendo che si tratta solo di “algoritmi avanzati” e che l’intelligenza artificiale in realtà non esiste [4].
Che dietro l’IA ci siano algoritmi avanzati è indubbio. È indubbio anche che il termine “intelligenza” sia iperbolico. E’ più facile scrivere un “algoritmo”, cioè un programma, per calcolare una derivata che uno per mimare uno scarabeo che cerca di uscire da un elementare labirinto. E uno scarabeo non possiede l’intelligenza per calcolare una derivata, secondo una qualunque accezione condivisa del termine. Tuttavia un programma che calcola le derivate non è ritenuto parte dell’IA, mentre uno che mima uno scarabeo sì. Nel mio ambito di ricerca si è iniziato a usare la parola “intelligenza” quando si è capito che fruttava in termini di immagine, di prestigio, di popolarità e di finanziamenti. Prima, più dimessamente, si parlava di machine learning, data mining, knowledge discovery in database, pattern recognition, approximate reasoning et similia. E in realtà queste sono le tecniche alla base di ciò che, oggi, è considerata IA. Tecniche che sostanzialmente mettono in relazione dati generando regole.
Excursus 2: Big Data e IA.
Perché le suddette tecniche funzionino, i dati devono essere sufficientemente numerosi - Big Data - altrimenti le correlazioni non sono significative e possono essere fuorvianti. Nel caso limite di un database (relazionale) con una sola entrata (ad esempio la descrizione di un solo paziente), ogni parametro è in perfetta correlazione con ogni altro (ad esempio la temperatura con la patologia, ma persino la città di residenza con la patologia), fatto che non fornisce alcuna spiegazione. Che però una correlazione tra dati significativa, sia tout court designabile come “intelligenza” è questionabile. Si veda, di Giuseppe Longo, “Big Data e Intelligenza Artificiale: Che Futuro Ci Aspetta?” [5].
Lo stesso Longo in “ ‘Correlazioni artificiali‘ vs ‘conoscenza delle cause‘ ” (in “Matematica e senso”, Mimesis, 2021) nega che la manipolazione di dati di per sé porti a conoscenza senza aver dietro una teoria e fa l’esempio della rivoluzione copenicana:
«La fine del geocentrismo è, prima di tutto, un cambiamento metafisico e teorico, un cambiamento di “prospettiva” [...] le regolarità emergenti dai Big Data, così numerose già tra gli astronomi arabi, non avrebbero mai prodotto questo cambio di paradigma».
Infatti anche la mole di dati astronomici di Tycho Brahe (che nasce tre anni dopo la morte di Copernico) era compatibile con la visione tolemaica e non era né necessaria né sufficiente per cambiare prospettiva. Longo inoltre ricorda che il potere di interpolazione della matematica può sempre produrre “correlazioni spurie” e anche correlazioni pioltate: forzando “bias” (pregiudizi) nella scelta degli ossevabili e/o nella loro misurazione, si può sempre «leggere qualsiasi fenomeno a piacimento» [6].
E così conclude:
«Il mito di una IA onnipotente rivela così il suo vero volto: una visione e una prassi “istruttiva” della vita e della storia. Gli uomini devono seguire la “regola fomale”, priva di un senso: allora l’interazione uomo-macchina e le previsioni automatizzate saranno pienamente efficaci. E’ solo estraendoci da questa visione che subordina l’uomo a ciò che può essee meccanizzato che potremo sfuttare al meglio queste formidabili macchine digitali che stanno cambiando il nostro mondo: sta a noi inserirle nella storia per arricchire la nostra socialità, invece di ridurre la sua diversità e di forzarla in protocolli e istruzioni».
Altrove ho argomentato che persino la “scoperta matematica” coinvolge stati coscienziali che alterano la “prospettiva” e non è un puro frutto razionale [7]. Riuscirà l’IA a mimare anche stati coscienziali (ammesso che basti mimarli)?
Chiarito ciò, un programma che calcola le buste paga (o anche una derivata) e uno che mette in correlazione una quantità enorme ed eterogenea di dati per trarre delle conclusioni (o prendere decisioni), sulla base di un quesito posto in linguaggio naturale, hanno una natura radicalmente differente. Il secondo non è solamente “più avanzato” del primo, non solo le loro logiche e i loro ambiti applicativi sono totalmente differenti, ma il secondo programma ha tutte le caratteristiche, e in misura molto sviluppata, di quanto Derrik De Kerckhove chiama “psicotecnologia” [8].
In realtà se è già opinabile che l’IA possa essere considerata solo un insieme di “algoritmi avanzati” nelle applicazioni militari, ad esempio nell’ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance), nell’ambito del lavoro e dei rapporti umani si tratta indubbiamente di una rivoluzione.
Per quanto riguarda le applicazioni militari è sotto gli occhi di tutti il frenetico sforzo statunitense di avere il predominio nell’IA. Tuttavia questa esplicita insistenza competitiva è soprattutto americana, mentre la posizione delle altre grandi potenze appare più sfumata.
Chiaramente ci sono motivi commerciali e soprattutto finanziari che spingono gli Usa a dichiarare “Noi saremo i primi” a suon di investimenti stratosferici. E ci sono invece motivi pertinenti all’industria dei “tangibles” che suggeriscono ai concorrenti strategici degli Usa di frenarsi nei proclami oltre le righe riguardo l’IA, perché inutili. Motivi come ad esempio i motori ipersonici e, non meno importanti, i sistemi di controllo dei missili lanciati a velocità ipersonica. Settori in cui gli Usa difficilmente riusciranno a colmare il gap con la Russia o anche con la Cina [9]. Un sistema sofisticato di ISTAR basato sull’IA può identificare velocemente e precisamente un obiettivo (per l’attacco o la difesa) ma poi il compito passa a un sistema “materiale” (di attacco o difesa) come, appunto, un missile.
Ad ogni modo sono necessarie riflessioni serie sull’IA e sotto diverse angolature. Riflessioni avviate da tempo e da persone di ogni Paese. Ne faccio una rapidissima rassegna in base a ciò che so e alla mia esperienza sull’argomento.
Le questioni etiche che si possono applicare all’IA si sono poste fin dall’inizio dell’utilizzo delle armi un-manned dove riguardavano la reciprocità e la proporzionalità (un uomo da remoto può ucciderne molti altri senza rischiare) e la “neutralità emotiva” [10].
Anche il tema dell’errore si è posto fin dall’inizio dell’utilizzo militare di sistemi computerizzati. E’ un limite dimostrabilmente ineliminabile [11]. Il maggior rischio attuale, impossibile da sottovalutare, risiede nella maggiore pervasività dei sistemi informatici e nella maggior fiducia a essi accordata a fronte dei loro spettacolari avanzamenti [12]. In definitiva risiede nelle politiche del loro utilizzo, politiche che sono influenzate dall’innalzamento del livello delle funzioni cognitive umane di cui possono essere πρόϑεσις (protesi) avanzate. Che poi tali protesi siano prive di sentimenti o giudizi morali è un altra questione che in ultima istanza conduce a quella più ampia della moralità del Potere.
Per quanto riguarda le applicazioni riguardanti il sociale, il concreto rischio (ma forse ormai certezza) è che la collaborazione, tecnica ed economica, tra Big Tech e apparato industriale-militare-securitario dia vita a un ISTAR in ambito sociale. Le politiche di proprietà della IA ne sono già un segnale [13].
Per concludere, la necessità di espansione, di acquisire risorse e di scaricare all’esterno l’entropia generata e la necessità di controllo sociale, tutte connaturate ai processi di accumulazione infinita, concorrono alla spiegazione dei conflitti esterni e interni e li collegano. In questo quadro la questione del lavoro cognitivo entra nella materialità dei rapporti sociali ed esce dall’ideologia del “capitalismo immateriale”. Ideologia che ritengo fuorviante. E il conflitto tra l’Occidente finanziarizzato e in crisi sistemica e il resto “materialistico” del mondo credo che confermi questa critica [14].
Qui ritroviamo la correttezza delle analisi di Martyanov ma anche il loro limite.
L’analisi “oggettiva” storica e logica suggerisce che l’Occidente finanziarizzato perderà via via terreno nei confronti del resto del mondo “materialistico” fino all’instaurazione di un nuovo ordine multilaterale (o “polifonico” per usare il concetto proposto dal presidente della Federazione Russa). Ma l’analisi ispirata da Marx (e da Lenin) non garantisce questo happy ending.
Se infatti rintracciamo, come abbozzato sopra, l’eziologia del conflitto non possiamo sottrarci alla domanda chiave: “Tutti vogliamo un mondo più equo, libero dal dominio unipolare statunitense e dal suo privilège exorbitant (generale, non solo monetario). Ma è possibile un mondo multilaterale (polifonico) pacificato mosso dall’accumulazione capitalistica?”.
Io ho dei dubbi, ma ognuno dia la risposta che crede.
Note