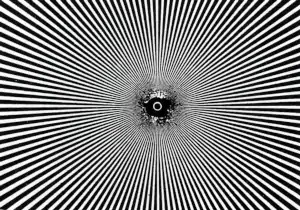Che cos’è la composizione di classe?
apr 12th, 2023 | Di Thomas Munzner | Categoria: ContributiChe cos’è la composizione di classe?
Sebbene il concetto di composizione di classe sia uno dei più importanti dell’armamentario operaista, sono pochissimi i testi in cui esso è stato formalizzato a scopo formativo. Il testo di archivio che proponiamo, che è la trascrizione dell’intervento che Salvatore Cominu ha tenuto in occasione di un seminario di autoformazione organizzato a Piacenza nel 2014, tenta di rimediare a questa lacuna ripercorrendo l’origine e lo sviluppo del concetto senza la pretesa di una formalizzazione definitiva ma con il pregio di una rara chiarezza espositiva. Come si leggerà, più che di un concetto si tratta di un metodo che va fatto funzionare tanto importante quanto, di fatto, dimenticato. La sua rilevanza deriva dalla sua capacità di offrire una lettura materialistica, ovvero calata all’interno dei rapporti sociali di produzione storicamente determinati, della produzione di soggettività, senza la quale non è possibile disporre alcun tipo di processo organizzativo. Detto in termini più semplici: senza l’uso di questo metodo difficilmente si potranno scoprire i nuovi soggetti delle lotte. A differenza del concetto di intersezionalità, oggi di moda e a cui il lettore più avveduto certamente avrà pensato, che con esso condivide l’esigenza di un’immagine disomogenea, articolata e stratificata al proprio interno della classe, il metodo operaista non è viziato da un materialismo determinista. Per esso infatti la sottomissione ad una qualche forma di dominio/sfruttamento non è una condizione sufficiente alla produzione di soggetti «rivoluzionari» perché «anche il Capitale soggettivizza». Come sostiene l’autore, all’interno della realtà capitalistica, i soggetti «subalterni» non esprimono alcuna coerenza progressiva, al contrario sono per lo più portatori di una forte «ambivalenza». La «contro-soggettivazione» antagonista non è quindi un processo necessario ma solo un esito possibile degli sforzi organizzativi. È questo realismo a rendere il metodo della composizione politica ancora indispensabile alla prassi militante che troppo spesso rimane incantata dall’idealizzazione dei soggetti delle lotte finendo per non vedere in alcuni casi le loro potenzialità, in altri i loro limiti.
Premessa
Prima di entrare nel merito del tema della serata mi sembrano doverose alcune brevi premesse.
La categoria di «composizione di classe» è fondativa, forse più di altre, di un filone del marxismo eterodosso che, per quanto abbia dato vita a differenti esiti teorici e traiettorie politiche anche personali, rimane nondimeno fortemente riconoscibile per metodo e categorie, parlo ovviamente di quello che a partire dagli anni Sessanta è stato definito operaismo, e poi post-operaismo o neo-operaismo.
Intorno alla definizione operativa – al suo essere un attrezzo utile per la lotta di classe – si sono misurati e divisi militanti e intellettuali con strumenti ben più solidi dei miei. La mia visione di questo e altri concetti è mediata da una certa frequentazione negli anni Ottanta e Novanta con Romano Alquati, sociologo militante a cui si deve peraltro il conio originario della categoria di composizione di classe, nonché (credo) gli spunti analitici più rilevanti nel definirne l’operatività. Dopodiché non sono uno specialista del pensiero di Alquati né un suo esegeta. Romano ci ha lasciati qualche anno fa, sarebbe stato importante avere le sue analisi sulla composizione di classe nella crisi; il riferimento alla sua figura penso sia necessario (anche perché molte ricostruzioni tendono a trascurare o sottovalutare il suo contributo), ma non lo faccio per dare maggiore credito a quanto, con tutti i limiti del caso, mi appresto a dire.
Infine, una ricostruzione sistematica della «carriera» del concetto di composizione di classe richiederebbe più tempo e capacità di quelle a mia disposizione. Per brevità, molti passaggi saranno accennati e soprattutto non mi dilungherò (come sarebbe invece necessario) sugli sviluppi successivi agli anni Sessanta del dibattito sulla composizione di classe, consapevole tuttavia che questa ellissi temporale tra gli anni Sessanta e i giorni nostri tagli fuori dalla riflessione contributi e innovazioni troppo importanti per essere poste tra parentesi.
Il contesto in cui si sviluppa il concetto di composizione di classe
Credo utile, per introdurre la discussione, partire dall’ultimo incontro, inerente i processi di soggettivazione, condotto da Federico Chicchi. Il nesso tra soggettività (e il suo essere processo, forma di produzione) e composizione di classe è infatti stretto.
Per cogliere la portata rivoluzionaria del concetto di (del metodo della) composizione di classe occorre situare la riflessione nel movimento operaio a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, in una fase di sostanziale assenza di lotte. Qual era il quadro?
La linea strategica del gruppo dirigente del Pci era da tempo volta a realizzare un’alleanza tra classe operaia e frazioni progressiste, o ritenute tali, del capitalismo italiano (questo era il togliattiano «patto tra produttori») che progressivamente avrebbe dovuto marginalizzare le componenti conservatrici del medesimo. Una strategia che subordinava le istanze di classe alla modernizzazione del capitalismo nazionale. Aggiungiamo che la sconfitta delle lotte operaie del dopoguerra, la marginalizzazione del sindacato nelle grandi fabbriche (la sconfitta della Fiom-Cgil nelle commissioni interne del 1953), aveva prodotto un disorientamento tra le stesse avanguardie comuniste. In ultimo prevaleva in numerosi ambienti l’idea, di derivazione francofortese, di una progressiva integrazione della classe operaia nella società opulenta e dei consumi di massa (erano gli anni del boom economico). Per farla breve e banalizzando: o la classe operaia era considerata persa per qualsiasi progetto di trasformazione radicale o era rappresentata in termini astorici, come un corpo privo di autonoma capacità di espressione politica, più iconizzata che conosciuta nei termini materiali.
Quella dei «Quaderni Rossi» fondati da Panzieri non fu certamente la sola esperienza di ripresa del marxismo, ma sicuramente gli spunti teorici del gruppo di militanti e intellettuali che vi aderirono influenzarono più in profondità il dibattito e le generazioni successive. L’elaborazione di Panzieri si concentrerà sull’analisi di quello che all’epoca era definito neocapitalismo, attraverso una rilettura dell’opera di Marx al fine di recuperarne il carattere di critica dell’economia politica (dei rapporti sociali di produzione). È questo, banalizzando al massimo, il senso ultimo della sfida operaista. Il marxismo ufficiale considerava la classe operaia perlopiù come forza-lavoro, pura variabile economica, il ciclo dell’accumulazione capitalistica governato da «oggettive» leggi economiche, lo sviluppo tecnologico «neutro». Gli operaisti posero al centro l’elemento soggettivo, leggendo lo stesso sviluppo capitalistico, la tecnologia, l’organizzazione del lavoro come esito perennemente in divenire dei rapporti di forza tra le classi. Dunque l’accumulazione non era governata da leggi oggettive, ma rifletteva il continuo gioco tra iniziativa del capitale e comportamenti del lavoro.
Entro queste coordinate va inquadrata la categoria di composizione di classe giustamente ritenuta fil rouge dell’operaismo dei «Quaderni Rossi» e poi del gruppo che se ne distacca per fondare nel 1964 la rivista «Classe Operaia». Il conio si deve appunto ad una rubrica inaugurata nel 1965 da «Classe Operaia» e curata da Romano Alquati, ma le premesse erano già contenute nel lavoro di ricerca militante dei «Quaderni Rossi». Ma cosa intendevano gli operaisti con composizione di classe? Per l’importanza che tale categoria ha ricoperto servirebbero definizioni più rigorose di quelle che il tempo a disposizione e le mie conoscenze consentono. Credo sia importante ricordare che l’approccio della composizione di classe si dette anzitutto come necessità pratica dei militanti che si affacciavano ai cancelli delle fabbriche. Cito la testimonianza di Sergio Bologna al precedente incontro di «Commonware», all’epoca giovane militante e in seguito promotore di una delle principali esperienze intellettuali del marxismo degli anni Settanta, la rivista «Primo Maggio». Composizione di classe, per Sergio Bologna, significava «capire» la classe per come si dà «nel processo produttivo e in rapporto con l’organizzazione tecnica, ma anche per cosa pensa, come vive, di quali valori, desideri, aspettative è portatrice». E certamente l’idea che l’operaio taylor-fordista fosse diverso, per valori, atteggiamento verso il lavoro, l’azienda, la professionalità, dalla vecchia generazione in possesso di un «mestiere», ha rappresentato la principale intuizione politica dei «Quaderni Rossi».
Perché composizione? Nonostante il termine «classe operaia» sembrasse in sé esplicativo nella realtà, la classe operaia era tutt’altro che omogenea. Era articolata, all’interno degli stessi stabilimenti della produzione di massa, come Lancia, Olivetti, Fiat, Marghera. Ad un primo livello, dunque, composizione esprime la consapevolezza dei differenziali (di professionalità, competenze, rapporto con la struttura tecnologica – ma soprattutto, ed è la cosa più importante – come percezione di sé, struttura soggettiva) presenti tra gli operai. La rivista «Classe Operaia», successiva ai «Quaderni Rossi», muoveva i suoi passi negando alla classe operaia il carattere di «compatta massa sociale». Semmai, l’omogeneità «era un obiettivo per cui lottare», come scriveva Alquati nel 1965. Rimando qui a due testi di Alquati per approfondire il concetto. Il primo pubblicato sul primo numero dei «Quaderni Rossi» intitolato «Relazione sulle forze nuove» (cui si deve forse la prima prefigurazione di quello che venne definito operaio massa), in cui la riflessione muove dal convergere nella lotta di tre figure diverse: a) la massa degli addetti macchina, sempre più spesso, a partire dal 1959, di origine meridionale; b) gli operai qualificati e c) gli operai polivalenti, con tre anni di «Scuola Allievi Fiat». Nel testo pubblicato sui «Quaderni Rossi» n. 2 e 3 intitolato «Composizione del capitale e forza-lavoro alla Olivetti» l’attenzione analitica a questa complessità è ancora più evidente.
Ai nostri fini, questo secondo testo è ancora più importante perché qui si trovano i principali spunti da cui discende l’idea di composizione di classe. Anche se nel testo questa categoria non è mai enunciata, è qui che inizia a delinearsi infatti la distinzione, ma sarebbe forse più corretto parlare di compresenza e articolazione, tra quelle che saranno definite composizione tecnica e composizione politica di classe. Al centro del lavoro di inchiesta alla Olivetti era la dimensione quotidiana del conflitto, spesso latente e invisibile, che opponeva operai – e non solo operai in senso stretto – e management. Le lotte, osservava Alquati, non nascevano dal niente, ma si nutrivano di un retroterra sociale, di una cooperazione operaia antagonista – o potenzialmente tale – a quella del ciclo produttivo. E ogni lotta sedimentava un residuo politico, che si cristallizzava nella struttura «soggettiva» della classe, costituendo il presupposto delle lotte che seguivano. Nel contempo, tali conflitti obbligavano il capitale a ristrutturare continuamente la propria organizzazione, la struttura tecnologica e i livelli gerarchici.
La formalizzazione della nozione di composizione di classe avvenne in seguito. Come dicevamo, nella proposta teorica convivevano due dimensioni. Una composizione tecnica, relativa cioè alla classe operaia intesa come forza-lavoro, definita dalla divisione capitalistica del lavoro, e quindi dalla struttura tecnologica della produzione, dal rapporto tra tecnologia e lavoro vivo, dai livelli gerarchici e via di seguito. In rapporto con questa, una dimensione soggettiva, inerente alla cultura, ai modi di pensare, ai bisogni e ai desideri, di percepirsi in rapporto agli altri, per giungere alla disposizione nei confronti della lotta. Quella che è stata chiamata composizione politica di classe.
Quanto detto, ci chiarisce anzitutto che riferirsi alla composizione di classe non significa parlare semplicemente di struttura della forza lavoro sociologicamente intesa. Mi preme richiamare il tema della struttura soggettiva dei bisogni, delle pratiche individuali e delle lotte collettive. È evidente che al centro di tutta la questione, già allora, era la soggettività, che lo stesso Alquati definiva come «il sistema di credenze, visioni e concezioni, rappresentazioni e saperi, conoscenze e cultura […] e dei desideri, di certi aspetti dell’immaginario e pure delle passioni e della volontà, delle opzioni, ecc.»
Vorrei sottolineare, di questa formulazione, il rapporto tra queste due dimensioni, la composizione tecnica e la composizione politica. La soggettività non poggiava nell’aria; culture, disposizioni soggettive, modi di pensare sono qui radicati in una precisa forma di organizzazione produttiva: la fabbrica taylor-fordista. Il cambiamento della struttura tecnica, l’innovazione tecnologica che scompaginava e ricostituiva continuamente l’articolazione dei ruoli e i modi della cooperazione sociale, erano letti, in qualche misura, come risposta all’autonomia della cooperazione operaia e alla sua capacità di rovesciare per i propri fini l’organizzazione data. Detto rozzamente, non era la composizione tecnica a determinare quella politica, semmai il discorso andava rovesciato, per quanto personalmente inviterei sempre a vedere il rapporto – situato e storicamente determinato, mai unidirezionale – e non la causalità deterministica tra queste due dimensioni.
Riepilogando, la categoria di composizione di classe consentiva di leggere nella soggettività operaia al medesimo tempo la base per la costruzione di un punto di vista politico di parte, e dei conseguenti livelli organizzativi, ma anche un fattore determinante della trasformazione capitalistica.
Alcuni approfondimenti e possibili derive
Per ragioni espositive e di tempo, non ci dilunghiamo nella ricostruzione della carriera successiva della nozione di composizione di classe.
Limitiamoci a dire che negli anni Settanta, con la ristrutturazione, la ritirata del fordismo, la ricerca da parte del Capitale di nuovi spazi di valorizzazione, si è aperta una questione, se vogliamo la stessa che continuiamo a porci anche oggi: l’approccio della composizione di classe ha avuto una valenza politica limitata a un determinato stadio di sviluppo del capitalismo, appunto quello fordista, oppure è appropriabile nel quadro delle trasformazioni successive del capitalismo? Detto chiaramente: è di qualche utilità se sottratto all’ambiente della fabbrica fordista, che ne costituì il bacino d’incubazione e verifica empirica? Non si trattava e non si tratta di pura curiosità intellettuale, poiché proprio negli anni Settanta partiva la lunga controffensiva del Capitale, che dapprima concentrò gli sforzi nella disarticolazione del punto di massimo accumulo di forza operaia, la fabbrica taylorizzata. Da qui il decentramento produttivo, l’automazione, la ricerca di nuovi campi di sfruttamento, e certamente da qui (e non dalla scoperta di Internet) presero le mosse le tendenze alla globalizzazione, alla finanziarizzazione, allo sfruttamento cognitivo del lavoro.
L’approccio originario, in questo quadro, venne arricchito, forzato e probabilmente talvolta anche banalizzato. È importante sottolineare però il tentativo di valicarne la dimensione fabbrichista, per superare quello che in fondo ne costituiva un limite. Ciò non derivava solo dall’evidenza dei processi di superamento del fordismo, ma dalla necessità di collocare in un contesto più ampio le stesse lotte dell’operaio massa negli anni Sessanta.
A questo arricchimento contribuirono certamente il lavoro di storia militante dell’altro movimento operaio condotto dalla rivista «Primo Maggio», nonché da intellettuali non italiani, che mostrarono come anche a monte delle lotte dell’operaio massa vi fossero reti sociali, esperienze politiche esterne ai luoghi della produzione, memorie di classe (e soprattutto in altri contesti nazionali) di razza e di genere.
Contribuirono alcune innovazioni teoriche degli anni Settanta, come la categoria negriana di operaio sociale e le analisi sulla proletarizzazione del lavoro intellettuale e sull’università di ceto medio di Alquati.
Queste innovazioni consentivano al metodo della composizione di classe di interpretare materialisticamente il ciclo di insubordinazione proletaria degli anni Settanta, esterno ai luoghi della produzione di massa (dove si dava ormai come conflitto di resistenza), coinvolgendo il territorio e consegnando di volta in volta il testimone a giovani proletari, donne, studenti universitari di tipo nuovo («uno strano movimento di strani studenti» si scrisse del movimento del Settantasette), spesso di origine operaia. Secondo l’impostazione di Alquati, ma anche di Negri, la socializzazione delle lotte dalla fabbrica al territorio (e all’Università) non era l’esito deterministico della ristrutturazione capitalistica, ma anche di un «autonomo» processo di socializzazione delle lotte entro le reti di comunicazione e socialità proletaria.
Non c’è dubbio, tuttavia, che la categoria di composizione di classe abbia dato vita anche a visioni schematiche del rapporto tra composizione tecnica e composizione politica, se non a vere e proprie trappole. Personalmente concordo con chi ha parlato di una trappola deterministica, consistente nell’idea per cui ad ogni specifica configurazione tecnica della classe corrispondesse automaticamente una struttura soggettiva – e una peculiare forma di lotta e di organizzazione. Ciò ha finito, da una parte, per rappresentare lo sviluppo storico (del capitalismo e della classe) come una sequenza di soggettività centrali, dall’altro per generare l’attesa messianica del prossimo soggetto ricompositivo, scambiando sovente estemporanee manifestazioni conflittuali per i primi vagiti del medesimo. Rientrano in questo campo, a mio modo di vedere, anche le ipotesi sull’ intellettualità di massa elaborate negli anni Novanta, nonché certe letture del lavoro digitale (della «rete») che recuperano da sinistra le teorie sulla classe creativa a suo tempo avanzate da Florida e oggi riproposte, in chiave ancor più marcatamente liberista, dal nuovo guru Enrico Moretti. Per altri versi, la composizione di classe è stata sottoposta ad una torsione idealistica, tendente a enfatizzare l’elemento di autonomia della classe (o della cooperazione sociale) dal comando capitalistico, finendo per sottovalutare le capacità di recupero e offensiva del capitale o per darne una lettura in chiave di puro adattamento. In questa visione il Capitale finisce per essere rappresentato – ovviamente banalizzo oltre misura – come realtà parassitaria, incapace di ripristinare il comando sulla cooperazione produttiva. Non penso che le cose stiano così.
Sul nuovo capitalismo, globale, finanziarizzato, cognitivo
Veniamo all’oggi. È ancora utile la categoria di composizione di classe?
Apro una parentesi. È discutibile – sul piano del metodo – pontificare eccessivamente ex post sugli esiti insoddisfacenti delle scommesse politiche. Quella degli operaisti degli anni Sessanta fu una «scommessa». Se si fossero limitati a registrare il presente non avrebbero trovato l’operaio massa a Mirafiori. Ciò non toglie che alcune ipotesi sul nuovo capitalismo finanziario, globale, cognitivo avanzate nei due passati decenni, anche utilizzando la griglia teorica della composizione di classe – ed elaborate da compagni con basi teoriche molto più solide delle mie – richiedano perlomeno una revisione critica (anche se forse non sempre un cestinamento).
Non ho la presunzione di dimostrare l’attualità dell’approccio della composizione di classe usandola come filtro analitico privilegiato per l’analisi dei processi di globalizzazione, finanziarizzazione, cognitivizzazione del capitalismo. Non ne sono in grado e penso che sarebbe una forzatura. Penso però che queste tre dimensioni costituiscano la cornice entro cui situare l’analisi ed eventualmente verificare l’utilità metodologica della composizione di classe.
Queste tre dimensioni sono anzitutto leggibili come diverse traiettorie (condizionate e in qualche modo orientate da resistenze, conflitti, rigidità, di lavoratori, società locali, ecc.) di una tendenza alla lavorizzazione – intesa come espansione o introduzione di rapporti di produzione capitalistici – di sempre nuovi settori, territori, ambiti della vita produttiva e riproduttiva (della vita in generale). Questa è una tendenza di lungo periodo del capitalismo che, al termine del ciclo fordista, ha assunto la forma della globalizzazione, della finanziarizzazione, dello sfruttamento cognitivo. Ovviamente ci sono altre dimensioni del capitalismo contemporaneo altrettanto importanti, ma credo che queste in particolare domandino una rivisitazione critica del modo in cui le abbiamo interpretate.
Globalizzazione
La nuova globalizzazione ha costituito l’apertura di inediti spazi in cui affermare rapporti di produzione capitalistici, dove ricostruire cioè forza-lavoro senza mezzi di produzione costretta a rapporti salariali. È quanto avvenuto tra gli anni Ottanta e Duemila e che prosegue anche oggi. Ma è un processo che va visto nella sua dinamica. Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila la rappresentazione prevalente della globalizzazione coincideva (all’ingrosso) in una divisione del lavoro tra il neofordismo dei Brics e la concentrazione di funzioni direzionali, creative, qualificate nelle metropoli occidentali. Oggi è evidente che non è più così. Il movimento dei capitali e delle persone, i conflitti operai nei Brics, hanno prodotto una geografia molto più articolata, con la risalita della catena tecnologica e cognitiva di diverse economie «emergenti», da una parte, il permanere o la proliferazione di produzioni dequalificate nelle metropoli occidentali, dall’altra. Entro questa cornice, una tendenza da osservare è costituita dal cosiddetto reshoring, ossia del ritorno delle industrie de-localizzate, in particolare dalla Cina. Mi interessa qui sottolineare due temi: i) la presenza di settori del capitalismo, nei paesi occidentali, che puntano esplicitamente ad un trade off tra costo del lavoro e (parziale) reindustrializzazione; ii) il legame tra dinamica dei salari e geografie del lavoro. L’intensità delle lotte costituisce tuttora una variabile rilevante per l’allocazione (dove e su cosa investire?) dei capitali.
Finanziarizzazione
Secondo polo del discorso, la finanziarizzazione. Premetto, ho serie difficoltà a entrare nei meccanismi di funzionamento dei mercati finanziari e non intendo addentrarmi su questo terreno. Accontentiamoci di dire che la finanza ha conquistato un carattere pervasivo nella riorganizzazione del capitalismo e che la stessa distinzione tra economia reale e finanziaria appare priva di fondamento, nel momento in cui la seconda diviene mezzo per l’accumulazione di capitale.
Non dimentichiamo che a monte della svolta finanziaria c’è stato uno «sciopero degli investimenti» messo in atto dai detentori di capitale a fronte delle ridotte capacità di estrarre profitti dalla cosiddetta «economia reale». E che spesso i protagonisti della svolta finanziaria erano soggetti industriali.
La finanziarizzazione dell’economia è stata rappresentata enfatizzando soprattutto l’autoreferenzialità dei mercati finanziari. Certo, l’eccezionale accumulo di liquidità e il potere discrezionale di cui alcuni player godono nell’allocarla, ha concesso loro un potere smisurato sulla produzione, sul lavoro e sulle vite. Ma il finanzcapitalismo va analizzato anche e soprattutto per le relazioni (di dominio e comando, ma forse anche di dipendenza) che intrattiene con la produzione di beni e servizi. Perché si dia accumulazione finanziaria si devono mobilitare aspettative di redditività che, in ultima istanza, richiedono l’esistenza di sottostanti materiali – non importa se siano mutui ipotecari e immobili (come negli anni Duemila), web companies (come negli anni Novanta), suoli, materie prime o titoli pubblici. È stato il venire meno delle condizioni di profittabilità dei sottostanti (profitti industriali, rendite, debiti cartolarizzati, ecc.) che nel 2008 ne ha causato il blocco – all ’epoca superato grazie agli interventi delle autorità politiche e delle banche centrali. Penso che nella crisi si sia affermata la necessità, anche tra gli operatori finanziari, di una almeno parziale ricostruzione dei presupposti «industriali» del valore. Dove sono ricercati? Ecco una bella domanda. L’indebitamento degli stati e degli enti pubblici costituisce terreno favorevole per la radicalizzazione dei processi di «mercatizzazione» della vita quotidiana, culturale, riproduttiva, dei suoli e dei metri cubi. I servizi collettivi (energia, acqua, trasporto, ecc.) sono indubbiamente terreno di conquista. È sotto questa luce che vanno lette anche le retoriche sulle smart cities e sulla green economy. La ripresa degli investimenti immobiliari, ma anche di quelli produttivi (ad es. nelle biotecnologie, nelle smart industries, nelle nuove IT), sono peraltro campi di costante monitoraggio dei grandi investitori.
Cognitivizzazione
In ultimo, e questo argomento ha un nesso diretto con la questione della composizione di classe, secondo la lettura che ne abbiamo dato è nel processo di sfruttamento del capitalismo cognitivo che si definisce il nuovo rapporto capitale-lavoro.
Io penso di avere letto la definizione migliore di lavoro cognitivo in un testo di qualche anno fa (di Federico Chicchi e Gigi Roggero) in cui si diceva, più o meno, che tale categoria è utile quanto più è utilizzata come «filigrana per osservare l’intero spettro delle forme di produzione e di lavoro nella loro compresenza […] e non tanto per individuare uno specifico settore di forza-lavoro, né per demarcare i lavori creativi dai mcjob». Credo che in questa definizione la demarcazione rispetto a visioni ottimistiche sul potenziale trasformativo di alcuni settori di knowledge worker sia netta. La messa al lavoro di prerogative mentali, affettive, relazionali: questo è in ultima istanza lavoro cognitivo, e coinvolge un gran numero di persone anche in attività ritenute poco qualificate, non solo designer e consulenti di marketing. Non casualmente è stato chiamato lavoro cognitivo, in aperta polemica con la retorica sulla classe creativa e sui lavoratori della conoscenza.
Tuttavia, occorre riconoscere che il nucleo della riflessione «da sinistra» sul lavoro cognitivo non è stato questo, bensì i) l’ipotesi che il salto qualitativo nel passaggio tra fordismo e nuova economia consistesse (per dirla rozzamente) nel farsi autonomo della cooperazione sociale (del lavoro sociale) rispetto al controllo capitalistico; ii) come conseguenza, nel primato delle conoscenze vive sulle altre forme di capitale. Confesso che questo è uno dei punti del pensiero post-operaista che ho qualche problema ad acquisire. Rigettarlo per intero condurrebbe a negare le trasformazioni (nelle forme di accumulazione e nell’organizzazione del produrre nel capitalismo) occorse negli ultimi quarant’ anni, a mio modo di vedere piuttosto evidenti. Assumerlo porta però a sottovalutare i processi già intervenuti e in corso di sottomissione e industrializzazione dell’umano e in ultima istanza dello stesso lavoro cognitivo. Su questo punto condivido l’opinione (ad esempio di Carlo Formenti) per la quale «solo un abbaglio potrebbe indurre a non vedere in che misura siano stati distrutti i rapporti di forza dei knowledge worker».
Tuttavia ci andrei cauto prima di considerare la composizione del lavoro cognitivo persa per ogni causa di trasformazione radicale. Questo, per due ordini di ragioni. La prima è che abbiamo avuto un ciclo di lotte su scala globale (dalla primavera araba ad Occupy Wall Street, da Istanbul a Rio de Janeiro) e molti conflitti sul territorio per il diritto alla città (all’abitare, alla mobilità, ai servizi, al sapere) che hanno visto per protagonisti, ancorché non esclusivi, soggetti socialmente collocabili nel campo che altri – con definizione inaccettabile – chiamano «lavoratori della conoscenza» – anche se precari o in formazione, vista la preponderanza degli studenti universitari in molte di queste mobilitazioni. E le lotte contro la riduzione del territorio e delle città a bacini di accumulazione per profitti e rendite capitalistiche è uno dei terreni della lotta di classe di oggi e del futuro. La seconda è che i processi vanno letti in termini dinamici. Oggi ci troviamo di fronte ad alcune tendenze tutte da interpretare. La prima attiene alla stratificazione del lavoro, in senso sociologico. In Italia, dal 2008 si è invertita la tendenza alla sostituzione di posti di lavoro dequalificati con occupazioni high skilled. Gli occupati nelle professioni più qualificate (professionisti e tecnici superiori) sono in calo. Il dato sembra correlato più a un declassamento italiano che a una inversione di tendenza, ma un paper di tre economisti della Columbia University ha evidenziato la medesima dinamica negli USA. La spiegazione fornita da questi autori è tecnologica. Le Ict, dopo aver favorito gli incrementi di produttività nel lavoro impiegatizio e nelle catene logistico distributive, starebbero «risalendo le gerarchie», aggredendo professionalità finora ritenute non «industrializzabili». Il capitale, per dirla banalmente, non è rimasto fermo, e proprio il controllo sul lavoro cognitivo – e il suo essere produttivo di valore – è terreno di scontro. Se questo è vero, o coglie almeno una parte dei processi in corso, occorre trarne alcune conseguenze:
1. La maggioranza dei lavoratori cognitivi non è sfruttata solo in quanto esposta alla precarietà, ma anche in quanto espropriata di capacità. Il rancore e il malessere di ampi strati di lavoratori cognitivi, per come la vedo, non deriva tanto (o almeno non solo) dalla percezione di una impossibilità a convertire «investimenti educativi» in posizioni sociali coerenti, ma anche dall’immiserimento o svalorizzazione del loro sapere.
2. Negli anni si è ampliata la distanza tra uno strato superiore (a sua volta disomogeneo per ricchezza, prestigio, potere) e un ampio strato inferiore di lavoratori cognitivi. I processi di proletarizzazione sono qui tangibili, ma (e a questo livello occorre recuperare l’analisi in termini di composizione di classe) ciò non implica che la percezione che hanno di sé sia conseguente. È proprio questa, se vogliamo, la questione. Tecnici, pseudo-creativi, consulenti serializzati, operatori sociali, traduttori, imputatori di dati, agenti di qualche cosa, anche quando sono brutalizzati e/o mal pagati, pensano (salvo alcune minoranze critiche) di appartenere ad una specie diversa da magazzinieri, commessi, banconisti, addetti alle pulizie, telefonisti. La composizione di interessi, immaginario, pratica politica, tra queste frazioni è in realtà molto difficile, proprio in virtù di processi di segmentazione e divisione perseguiti anche politicamente. E qui sta il dilemma. Trovare il piano comune, simbolico e politico, tra questi grandi agglomerati di classe, è una non eludibile priorità dell’agenda anticapitalista.
Riepilogando
L’ipotesi è che ci troviamo in presenza ad un tentativo – che a me pare «sistemico» – di riconfigurare l’articolazione del rapporto finanza-produzione in direzione di una parziale re-industrializzazione. Occorre però capirsi. Io credo che questo ipotetico e parziale rilancio dell’accumulazione a base industriale (dove industria non vuol dire manifattura, ma qualsiasi processo creatore di valore capitalistico organizzato con criteri industriali – anche politecnici, reti energetiche, ospedali, sono industrie!) passi per la definitiva dismissione dei residui di democrazia sociale imposti dalle lotte di classe del Novecento. L’esperienza della lunga crisi costituisce (e costituirà) un formidabile esperimento di rieducazione di massa. Credo che sia questa una delle poste in palio dei prossimi mesi e anni.
In ogni caso, la ricerca di nuove convergenze tra logiche industriali e finanziarie, tra profitto e rendita, non implica un ritorno al passato. Inoltre tale obiettivo non è in contraddizione con altre forme di sfruttamento e creazione del valore. Anzi! Nella crisi si radicalizzano i meccanismi estrattivi di plusvalore basati sulla mercatizzazione dei servizi collettivi (mobilità, infrastrutture, reti per il trasporto di dati, ambiente, produzione, trasformazione e distribuzione di energia, manutenzione urbana e dei territori, e poi formazione, salute, per finire ai servizi finanziari e assicurativi). Diamo infine per scontato, da queste trasformazioni non discendono meccaniche determinazioni della «composizione politica di classe», né la demarcazione su basi tecniche di soggettività «centrali».
Per chiudere il cerchio, e tornare al problema iniziale, credo che il punto non sia oggi pervenire ad una descrizione accurata e formalmente ineccepibile del capitalismo e della classe, quanto capire se nel ricco corpo teorico della composizione di classe vi siano tracce utili nel presente. E leggere nel vivo delle trasformazioni capitalistiche non già l’annuncio del prossimo soggetto ricompositivo, ma dove si può accumulare forza trasformativa e dove le lotte possono «dare crisi». Entro questo frame, credo che alcune tracce del metodo della composizione di classe siano pienamente attuali. Con tutta l’umiltà del caso e senza altro intento, in questa sede, che animare il dibattito, propongo tre o quattro spunti.
Anche nell’apparente venire meno della capacità delle lotte di affermare potere costituente (o imporre al capitale scelte «riformiste»), io ritengo che al centro della possibilità di invertire la rotta resti il lavoro (nell’accezione estesa e non aziendale che discende dall’espansione spaziale e dall’ intensificazione temporale dei meccanismi di estrazione del plusvalore).
Una lezione dell’approccio della composizione di classe è di metodo. Oggi chiunque può vedere che la società è complessa. A differenza degli anni Sessanta non c’è alcuna nozione teologica di classe da decostruire per ricomporla sul piano politico. Tuttavia, molte categorie utilizzate nel dibattito degli ultimi venti anni andrebbero approcciate con un metodo analogo a quello degli operaisti. Pensiamo alla questione del precariato, ad esempio, o dello stesso lavoro cognitivo. Non leggere le articolazioni e le gerarchie tecnicamente fondate, e contestualmente i diversi immaginari compresenti in queste categorie, porta a prendere degli abbagli.
Più in generale, nell’assumere la natura differenziale del capitalismo contemporaneo occorre però sviscerarne le gerarchie e coglierne le diversità qualitative. Affermare che tutto è lavoro (che tutto è estrazione di plusvalore) equivale in ultima istanza ad accreditare l’immagine di un capitalismo onnipotente – poiché effettivamente in grado di trasformare ogni impulso vitale in valore. Una lezione ancora attuale del metodo della composizione di classe consiste nell’acquisire la verticalità della realtà sociale del capitalismo, ma anche delle potenzialità di capovolgimento del sistema. Così come lo sfruttamento capitalistico non si dispiega su una superficie liscia, ma esistono per il capitale luoghi della creazione del valore più importanti di altri, anche dal punto di vista della lotta di classe vi sono luoghi più importanti (dove le lotte reali e – sottolineo – quelle possibili, da anticipare e organizzare, hanno un impatto vulnerante più forte, possono «dare» crisi, ma anche sedimentare forza organizzata). È importante aggiungere che queste due mappe gerarchiche (quella dello sfruttamento e quella della lotta di classe) non vanno concepite in termini simmetrici!
Alla luce di alcune derive deterministiche, le categorie di composizione tecnica e composizione politica a mio modo di vedere, e sono convinto che questo in fondo era anche il punto di vista di Alquati (che non può ovviamente avvallare) sono da intendere come dimensioni analitiche diverse che concorrono però a definire un oggetto «unitario». Composizione tecnica senza struttura soggettiva dei bisogni, senza espressione autonoma, diventa concetto troppo vicino alla descrizione sociologica della divisione del lavoro capitalisticamente determinata. Composizione politica senza ancoraggio all’organizzazione produttiva diventa troppo simile a comportamento di ceto, pratica culturale in senso debole.
Alla luce di ciò composizione politica non significa «classe per sé». Alquati non attribuiva alla soggettività un significato automaticamente liberatorio e antagonista. Anche il Capitale soggettivizza e usa per i propri scopi valori, culture, le stesse lotte una volta depotenziate della capacità di trasformazione radicale. La «composizione politica» non è qualcosa da analizzare solo quando i proletari si costituiscono come parte a sé (quando sono già disposti su un versante anticapitalistico). Per questo, sempre Alquati, parlava di contro-soggettivazione come possibilità sempre immanente, ma invero da costruire attraverso il lavoro politico. In altre parole, la composizione politica (la struttura dei bisogni, le forme di cooperazione, i valori condivisi) non sono necessariamente progressivi. È con questo quadro che oggi bisogna fare i conti. Ed è per questa ragione che personalmente non ho un atteggiamento di rifiuto aprioristico verso fenomeni politici come il M5S (ovviamente ciò non implica omettere o sottovalutare le controindicazioni del caso, il discorso sarebbe però lungo) o che, con molti altri compagni torinesi, nella settimana del #9D, abbiamo cercato di leggere questa mobilitazione in termini di classe, con tutte le ambiguità e i rischi del caso.
Lascio per ultimo la questione che mi sembra in realtà più importante. Credo che la struttura complessa e articolata del capitalismo contemporaneo, ci obblighi a considerare la composizione di classe come un qualcosa di intrinsecamente articolato in soggetti molteplici, non riducibili alla sfera del lavoro salariato e differenti anche all’interno del lavoro salariato – ad esempio, tra nuovo proletariato dei servizi urbani dequalificati e gli strati inferiori di lavoro cognitivo industrializzato e declassato, di cui prima. È evidente che ciò pone un problema, a mio modo di vedere non eludibile ma neanche risolvibile attraverso scorciatoie, di organizzazione politica. Qui però, dopo aver lanciato il sasso, vorrei fermarmi, non per ritirare la mano, ma perché credo che si entrerebbe in un altro campo di riflessione.
Salvatore Cominu svolge attività di ricerca, formazione e consulenza in collaborazione con centri di ricerca. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi progetti di livello locale, nazionale e internazionale su molteplici temi, dalle indagini sul mercato del lavoro allo sviluppo urbano e territoriale, dall’economia sociale ai problemi dell’azione collettiva e delle soggettività del lavoro, alla valutazione delle politiche pubbliche.
MachinaDeriveApprodi