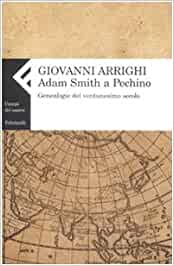Giovanni Arrighi oggi: una proposta di rilettura tra Gramsci e Schumpeter
dic 7th, 2022 | Di Thomas Munzner | Categoria: Teoria e criticaGiovanni Arrighi, professore di Sociologia alla John Hopkins University dal 1998 al 2009 (anno della sua morte), è un autore che ha goduto di ottima diffusione fino ai primi anni Duemila. Nell’ultimo decennio, tuttavia, i suoi scritti sono stati abbastanza trascurati, in particolare in Italia. Paradossalmente, è proprio in questo periodo che una buona parte delle sue previsioni si sono avverate, in particolare rispetto alla crisi finanziaria del 2008 e all’ascesa della Cina.
Nonostante sia stato un autore molto prolifico, è soprattutto noto grazie a una “trilogia”: Il lungo XX secolo [1] (pubblicato negli Stati Uniti nel 1994), Caos e governo del mondo [2] (1999) e Adam Smith a Pechino [3] (2007). Il primo e l’ultimo sono senza dubbio i suoi testi più celebri. Il lungo XX secolo è l’unico libro di un autore italiano suggerito nel seminario di Global History ad Harvard nel programma di studi sul capitalismo [4]. Adam Smith a Pechino, invece, sta godendo di una nuova giovinezza nel filone degli studi sul “capitalismo politico” [5]. In tutti e tre i libri Arrighi interpreta la società partendo da uno schema illustrato ne Il lungo XX secolo.
È convinzione di chi scrive che Arrighi sia rimasto “intrappolato” nel suo tempo. A causa degli anni in cui ha scritto, egli è diventato l’autore dell’espansione finanziaria, che mostrava come il boom iniziato negli anni Ottanta fosse un evento ciclico della storia. Questa lettura è stata in parte una conseguenza del lavoro di Arrighi stesso, che, in un’intervista fatta da David Harvey nel 2009 [6], notò come la sua opera fosse diventata una storia della finanza dal 1500 a oggi. Questa lettura “finanziaria” è però assai limitante. In sostanza, rischia di renderlo un autore muto rispetto al presente. Non a caso, le ultime letture del suo lavoro sono arrivate da chi trattava il capitalismo politico [7], ma poco è stato detto sulla sua analisi storica della società. Un’analisi che, ancorché da rinverdire, può certamente essere utile e stimolante tutt’oggi.
Nelle prossime pagine si riassumerà brevemente la struttura dei cicli egemonici-economici arrighiani e si riporteranno alcune proposte di chi scrive rispetto a una sua possibile rilettura. Per compiere questa seconda operazione ci si servirà di due figure chiave: Gramsci e Schumpeter.
I cicli egemonici di Arrighi
Arrighi studia gli ultimi 5 secoli concentrandosi su cicli che sono al contempo economici e politici. Riprende il concetto gramsciano di egemonia differenziandolo dal semplice dominio e notando come esso consista in leadership morale e intellettuale e costituisca dunque una sorta di “potere aggiuntivo” rispetto al dominio. Arrighi ritiene che questo potere generi anche una generale tendenza all’emulazione dell’egemone da parte delle altre potenze. Perché un Paese diventi egemone la sua classe dirigente deve mostrare al sistema internazionale di poter mitigare i danni causati dall’ “anarchia” internazionale e dall’assenza di un governo centrale. In altre parole, di poter riportare l’ordine nei momenti più complicati.
Per spiegare l’andamento dei suoi cicli, Arrighi riprende la formula generale del capitale di Marx, ossia Denaro-Merce-Denaro (D-M-D’), che indica un ciclo d’accumulazione il cui obiettivo finale è aumentare la quantità di denaro iniziale. Arrighi la rimodula però in maniera creativa. A suo parere, una potenza inizierebbe la sua ascesa “indebitandosi”, cioè ricevendo grandi quantità di investimenti stranieri (foreign direct investment – FDI), principalmente dall’egemone in declino. La potenza in ascesa, grazie a questa improvvisa crescita, inizierebbe a realizzare una generale riorganizzazione del sistema economico e politico mondiale e una nuova divisione del lavoro globale (fase D-M). Le classi dirigenti del nuovo egemone, così, affermerebbero sempre di più la loro leadership, mostrando al mondo come la guida del sistema sia passata nelle loro mani.
Questo processo andrebbe avanti fino alla crisi spia, ovvero una crisi derivata dall’eccesso di capitali. Fondamentalmente, la già citata egemonia della potenza principale spingerebbe gli altri Paesi a imitare l’egemone investendo negli stessi settori economici, fintanto che la crescente quantità di investimenti non generasse sempre più competizione facendo così ridurre i profitti, come mostrato da John R. Hicks [8]. A questa crisi economica corrisponderebbe una speculare crisi politica di delegittimazione dell’egemone. Passata questa crisi spia, investire in quei settori dell’economia reale che avevano generato l’espansione economica del sistema non sarebbe più vantaggioso.
Si passerebbe dunque alla nuova fase del ciclo, in cui il modo migliore per aumentare i profitti consisterebbe nel tenere denaro liquido e investire nella finanza (M-D’). Si entra così nella belle époque, ossia una fase di nuova ricchezza (per lo più finanziaria). Specularmente a ciò, l’egemone inizierebbe a sfruttare sempre di più la propria posizione di forza nel sistema per attrarre i capitali finanziari mobili a discapito degli altri attori economici e perseguendo obiettivi individuali sempre più lontani dagli interessi generali. Arrighi la definisce una belle époque poiché nel breve periodo questa strategia genererebbe non solo nuova ricchezza, ma anche un apparente rinvigorimento dell’egemone.
Sarebbe però solo il canto del cigno: presto le bolle finanziarie generate dall’espansione esploderebbero, facendo collassare definitivamente il Paese egemone e portando alla crisi terminale del ciclo, corrispondente da un punto di vista politico al caos sistemico. Il collasso del sistema porterebbe sempre maggiori tensioni sociali e mostrerebbe come la classe dirigente del Paese egemone non è più in grado di svolgere un ruolo di leadership. In contemporanea, però, durante la già citata fase di espansione finanziaria (ossia quella M-D’), gli investimenti dell’egemone in declino verso quello in ascesa crescerebbero esponenzialmente, stimolando così la comparsa di un nuovo egemone, chiamato poi a riorganizzare l’economia e la politica mondiale a seguito della crisi terminale del ciclo precedente.
Arrighi mostra come le varie potenze egemoniche (Spagna-Genova, Province Unite, Inghilterra, Stati Uniti) negli ultimi 5 secoli avrebbero seguito, a grandi linee, questa dinamica. Come si può vedere da questo breve riassunto, la finanza costituisce sia l’inizio che la conclusione del ciclo. Uno degli obiettivi di Arrighi era esattamente dimostrare come le espansioni finanziarie e le loro crisi non avessero una distribuzione casuale nel tempo, bensì fossero un costante e costitutivo aspetto dello sviluppo capitalistico. Tuttavia, come si è appena visto, quella finanziaria è solo una componente del ciclo arrighiano. Su di essa si sono però concentrate la gran parte delle attenzioni negli ultimi anni. Tuttavia, se la crisi del 2008 costituisse davvero la crisi terminale del ciclo americano (come Arrighi pensava), ciò significherebbe che ci troviamo in una fase di espansione dell’economia reale (D-M). Dovremmo dunque dare molta maggiore attenzione agli scritti arrighiani su quel tema piuttosto che quelli “finanziari”.
Nelle prossime due sezioni si suggeriranno due possibili temi da sviluppare e a cui dare una maggiore centralità nel provare ad applicare Arrighi alla nostra fase storica.
Antonio Gramsci, ovvero il conflitto sociale
Arrighi riprende il suo concetto di egemonia da Gramsci, applicandolo per la prima volta ai cicli egemonici. Questo lavoro è però solo parziale, poiché per esempio Arrighi ignora totalmente il ruolo dell’egemonia nelle istituzioni internazionali [9], né si concentra particolarmente su come la capacità culturale delle classi dominanti possa influenzare i cicli.
Vi è però un problema più grande. Nella struttura dei cicli di Arrighi sono assai trascurati i conflitti sociali, intesi, in senso ampio, come le tensioni derivate da tematiche di genere, razza e classe (sia orizzontalmente che verticalmente). Questa mancanza è stata riconosciuta dallo stesso Arrighi. Anche alcuni suoi importanti interpreti hanno sottolineato problematicità in questo senso. Questo non significa che di conflitti sociali non si parli, ma che non abbiano una portata strutturale nella dinamica del ciclo sottolineata nella trilogia. Per usare le parole di William Robinson, nello schema di Arrighi gli agenti dal basso non hanno fondamentalmente ruolo [10]. Questa mancanza non è secondaria, ma porta Arrighi a una serie di conseguenze notevoli. Per esempio, influenzato da Braudel, arriva a sostenere che un sistema possa definirsi capitalistico solamente quando lo Stato è asservito agli interessi economici e lavori per arricchire le classi dominanti (ragione per cui Arrighi non riteneva la Cina un Paese capitalista). Tale mancanza è ancora più sorprendente considerando gli studi giovanili marxiani di Arrighi. Gramsci ci giunge dunque in aiuto non solo per sottolineare temi come l’egemonia culturale e le organizzazioni internazionali (quanto mai importanti per studiare, per esempio, due potenze come Stati Uniti e Cina), ma anche in quanto leader rivoluzionario che ha rappresentato pienamente l’idea che i conflitti sociali fossero un fattore dirimente per comprendere le dinamiche storiche.
Se si ritiene necessario aggiungere i conflitti sociali all’analisi arrighiana non è (solo) per nostalgie novecentesche. A parere di chi scrive, i conflitti sociali hanno costituito un motore cruciale dell’espansione e riorganizzazione del sistema globale per mano dell’egemone. Un esempio può venire dal ciclo britannico. Come Sven Beckert [11] ha spiegato bene nella sua magistrale storia del cotone, non è un fattore casuale che l’incorporazione dell’India, per mano britannica, nell’economia mondiale sia avvenuta solamente negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento. Essa è una diretta conseguenza dei conflitti di classe, sia orizzontali che verticali. Furono le crescenti tensioni sociali negli Stati Uniti tra élite del Nord e del Sud (conflitto orizzontale) e le rivolte degli schiavi (conflitto verticale) a convincere i britannici che il sistema schiavistico americano alla base del cotone non era più stabile. Da qui gli investimenti pubblici e la costruzione di infrastrutture in India al fine di sviluppare un’alternativa al cotone americano. Questo caso è emblematico, ma tanti altri se ne potrebbero fare (la Rivoluzione Francese, le guerre di religione del Cinquecento, il ruolo degli operai di Birmingham nello smantellamento della Compagnia delle Indie Orientali, fino ad arrivare in anni più recenti al rapporto tra i moti del ’68 e lo sviluppo delle ICT). In maniera simile, la repressione, schiavizzazione ed eliminazione delle minoranze etniche e religiose (i neri e i nativi in America, la scientifica de-industrializzazione dell’India, i massacri degli olandesi nel Sud-Est asiatico) e la speculare “guerra” condotta a livello nazionale dallo Stato contro i lavoratori e gli emarginati (non solo le celebri enclosures, ma, per esempio il Frame-Breaking Act del 1812 che condannava a morte i lavoratori che sabotavano i macchinari in Inghilterra) [12], non sono stati un aspetto secondario e occasionale dei cicli egemonici, ma uno dei pilastri su cui essi si sono costruiti. In sostanza, per ritornare alle categorie di Beckert, il “capitalismo industriale” non avrebbe potuto sorgere senza il “capitalismo militare”.
La mancata trattazione dei conflitti sociali (almeno nella trilogia qui analizzata) costituisce dunque un limite all’attualizzazione dell’analisi arrighiana che va superato se si vuole usare la sua lente per leggere la contemporaneità. Non si può, per esempio, pensare di studiare le dinamiche tra Stati Uniti e Cina senza considerare la crescente radicalizzazione del Partito Repubblicano negli Stati Uniti o le condizioni della classe operaia in Cina. Arrighi mostra di cogliere la complessità delle dinamiche sociali e intra-statali [13] (un tema che, in altra sede, meriterebbe ulteriore approfondimento), ma non si addentra mai pienamente in esse. Per poterlo salvare dalla sua epoca, insomma, dobbiamo portare “Arrighi oltre Arrighi”. In questo senso, cruciale è rileggere quei testi in cui una simile operazione viene abbozzata da Arrighi stesso, come I movimenti antisistemici [14] e il poco noto articolo Marxist Century, American Century [15]. Sviluppare questi aspetti (molto marginali nella trilogia) è tanto più urgente se si pensa che le fasi di transizione egemonica portino alla delegittimazione delle classi dirigenti e che, dunque, questi fattori paiono destinati a diventare ancora più importanti nei prossimi anni.
Joseph Schumpeter, ovvero l’innovazione
Il rapporto tra Arrighi e l’innovazione non è semplice. L’autore milanese è stato fortemente influenzato da Schumpeter. Nella sua analisi, tuttavia, si tende a relativizzare l’impatto dell’innovazione tecnologica in sé e per sé. Per Arrighi, non è tanto l’innovazione a essere determinante ma ciò che le sta intorno, in primis il controllo delle rotte commerciali [16]. La sua visione potrebbe ricordare a tratti la teoria evolutiva dell’innovazione [17]. Tale teoria infatti dà un’interpretazione molto più ampia (e schumpeteriana) del concetto di innovazione rispetto al filone neoclassico, inglobando temi come la storia, le istituzioni, la path dependence e le dinamiche interne degli agenti politico-economici, dando importanza all’ambiente in cui tali innovazioni si realizzano.
Il rapporto tra innovazione e i cicli egemonici arrighiani, a sua volta, è rilevante ma complicato. In particolar modo, il già citato contesto storico in cui è emersa l’opera arrighiana ha rafforzato la tendenza a concentrarsi sulla finanza e a sminuire questo aspetto. Sciogliere questo nodo è tanto più urgente se si pensa che ci troveremo presto di fronte a una riorganizzazione del sistema economico e politico globale. La convinzione di chi scrive è che, per fare ciò, potrebbe essere interessante dare una “lettura schumpeteriana” del lavoro di Arrighi. Nello specifico, ciò che si suggerisce è di provare a interpretare le potenze egemoniche, così come descritte da Arrighi, come l’imprenditore schumpeteriano per eccellenza.
Questa lettura non solo potrebbe risolvere il rapporto complicato tra Arrighi e innovazione (tecnologica e non) e fornire spunti interessanti per guardare al presente, ma si ritiene che sia anche coerente con quanto scritto da Arrighi e con la descrizione che Schumpeter dà di imprenditore e innovazione. Per lo studioso di Harvard, l’imprenditore è prima di tutto un debitore [18], esattamente come la potenza egemonica arrighiana che inizia la sua ascesa indebitandosi con l’egemone in declino grazie ai FDI. Schumpeter dà poi una definizione larga di innovazione, che include tra le altre cose l’apertura di un nuovo mercato o la riorganizzazione dell’industria e che tende a concentrarsi molto più sulle “grandi innovazioni” rispetto all’economia neoclassica [19]. Questo tipo di innovazione è proprio ciò che viene fatto dall’egemone nella fase di riorganizzazione dell’economia globale (D-M). L’imprenditore schumpeteriano, poi, diventerebbe inevitabilmente nel lungo periodo un capitalista [20], che è simile a quanto accade alla potenza egemonica dopo la crisi spia del sistema, a seguito della quale l’egemone “vive di rendita” sfruttando i vantaggi della sua posizione.
Definendo la potenza egemonica arrighiana come l’imprenditore schumpeteriano per eccellenza non si intende sminuire il ruolo del settore privato nell’innovazione. Tuttavia, se accettiamo la larga definizione di innovazione data da Schumpeter, allora la riorganizzazione mondiale dell’economia compiuta dalla potenza egemonica nella fase D-M è certamente la maggiore delle innovazioni e la base su cui si poggiano tutte le successive del ciclo. Molti studi hanno recentemente rivalutato il ruolo dello Stato (e soprattutto del settore militare) nello sviluppo delle innovazioni, tecnologiche e non [21]. La “scoperta” dell’America spagnola e genovese, l’espansione economica olandese nel Sud-Est asiatico, la cooptazione britannica dell’India nel sistema economico mondiale, il Piano Marshall e la ricostruzione industriale dell’Occidente realizzata dagli Stati Uniti paiono a chi scrive tutte innovazioni assai maggiori di quante altre ve ne siano state negli ultimi 5 secoli. Soprattutto, tali riorganizzazioni hanno costituito un pilastro fondamentale su cui si sono poi innestate le innovazioni tecnologiche in senso stretto. Arrighi nota come il nascente settore industriale britannico fosse, in origine, poco più che un prolungamento del dipartimento militare. Solo la crisi di sovrapproduzione successiva alle guerre napoleoniche spinse a espandere il ruolo dell’industria nella costruzione di ferrovie e infrastrutture civili [22].
Molti altri esempi potrebbero essere presi dall’opera arrighiana, che ha trattato abbastanza diffusamente il ruolo dell’egemone come innovatore, seppur senza mai teorizzarlo. Rileggere le opere di Arrighi concentrandosi su quei passaggi in cui l’egemone si è comportato da imprenditore schumpeteriano permetterebbe di avere nuovi stimoli e di emancipare Arrighi da una lettura troppo finanziaria che limita le sue potenzialità e la sua diffusione. Un lavoro che sembra tanto più urgente se si guarda al presente. Il ruolo del governo cinese nella ristrutturazione dell’economia globale (soprattutto con i progetti della Belt and Road Initiative e con Made in China 2025) sembra confermare l’idea di un egemone in ascesa come imprenditore schumpeteriano. Sviluppare questa chiave di lettura permetterebbe di avere un punto di vista nuovo su un tema tanto centrale e sempre più rilevante nel panorama politico ed economico mondiale.
Conclusioni: i conflitti sociali e l’innovazione come fenomeni interconnessi
I due temi trattati, conflitti sociali e innovazione, non sono slegati tra loro. Se l’egemone in ascesa è soprattutto un imprenditore schumpeteriano e le dinamiche interne all’egemone sono il risultato di tensioni sociali da leggere tramite gli scritti gramsciani, allora ne consegue che il ruolo innovatore dell’egemone sarà fortemente influenzato dai conflitti sociali.
Nell’analisi marxiana, l’innovazione tecnologica viene principalmente studiata con la lente della ricerca del plusvalore relativo. Gli studi di Economia dell’Innovazione (anche quelli evolutivi) hanno trascurato il ruolo dei conflitti sociali e dell’egemonia culturale, quando questi temi sono, a parere di scrive, strettamente correlati con il processo innovativo. Come Jean Fallot [23] ha fatto notare, l’innovazione tecnologica non è mai neutrale, ma è sempre il risultato di un sistema economico-culturale che pone dei valori e degli obiettivi alla società. In altre parole, il fatto che si sia sviluppata la tecnologia necessaria a creare bombe atomiche ma non quella per risolvere altri problemi (ad esempio le malattie rare o le problematiche ambientali) non è frutto del caso, ma è il risultato dell’egemonia culturale esercitata da alcune classi sociali in un determinato sistema economico. Un pensiero quasi uguale lo troviamo in Schumpeter, che diceva che «Gli obiettivi della produzione tecnologica sono stabiliti dal sistema economico» [24]. Ugualmente, Gramsci notava che «L’esigenza tecnica può essere pensata concretamente separata dagli interessi della classe dominante, non solo, ma unita con gli interessi della classe ancora subalterna» [25].
Come si è sottolineato, i conflitti sociali non sono rilevanti solo per spiegare eventi interni ai cicli (conflitti tra classi dirigenti, tensioni sociali), ma anche per spiegare alcune loro dinamiche fondamentali, come le riorganizzazioni sistemiche. Si è già visto come i conflitti verticali e orizzontali spinsero l’Inghilterra a espandere il sistema economico riorganizzando l’India. Alla stessa maniera, un fattore rilevante (e sottolineato da Arrighi stesso) alla base del Piano Marshall fu la crescente organizzazione dei lavoratori e la paura del comunismo in Europa.
Tutti questi temi sono alla base della rilettura che si è provato qui solo a suggerire e che certamente andrebbe più dettagliata. È opinione di chi scrive che, dando più centralità a questi temi, si potrebbero trovare alcuni spunti interessanti da aggiungere alla fondamentale struttura arrighiana. Rileggere Arrighi, emancipandolo dalla sua interpretazione finanziaria potrebbe dunque restituirci un autore che tanto ha detto sul passato e tanto ha ancora da dire sul presente.
[1] Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of Our Times, Verso Books, Londra e New York 1994; trad. it. Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo, il Saggiatore, Milano 1996, 1999 e 2014.
[2] Giovanni Arrighi e Beverly J. Silver, Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, Bruno Mondadori, Milano 2003.
[3] Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing. Lineages of the XXI Century, Verso Book, Londra e New York 2007; trad. It. Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Feltrinelli, Milano 2008.
[4] Harvard University, Approaches to Global History: Seminar Professors Sven Beckert and Sugata Bose, Syllabus 2017-18.
[5] Alessandro Aresu, Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina, La Nave di Teseo, Milano 2020; Branko Milanović, Capitalism, Alone. The Future of the System That Rules the World, Harvard University Press, Cambridge 2019.
[6] David Harvey, The Winding Paths of Capital. Interview with Giovanni Arrighi, in «New Left Review», vol. 56 (2009), pp. 61-94.
[7] Prendendo spunto, peraltro, dai temi più azzardati dell’analisi arrighiana, come i suoi scritti sulla Cina.
[8] John R. Hicks, Una teoria della storia economica, UTET, Torino 1971.
[9] Per approfondire questi temi si veda: Robert W. Cox, Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method, in «Millenium – Journal of International Studies», Vol. 12 No. 2 (1983), pp. 162-175.
[10] «Apart from the one chapter in Chaos and Governance mentioned above and a couple of other essays, we find virtually no role of agency from below; labour movements, the exploited classes and the colonized played a minor role in the trilogy, and class analysis does not figure in Arrighi’s ontology of world capitalism or among his methodological arsenal», William I. Robinson, Giovanni Arrighi: Systemic Cycles of Accumulation, Hegemonic Transitions, and the Rise of China, in «New Political Economy», 16:2 (2010), pp. 267-280.
[11] Sven Beckert, L’impero del cotone. Una storia globale, Einaudi, Torino 2016.
[12] Sven Beckert, L’impero del cotone, op. cit., pp. 80-85.
[13] Per fare degli esempi, quando tratta l’ascesa della Spagna si dilunga a parlare del rapporto tra potenza territorialista (governo spagnolo) e classe capitalista mercantile (i genovesi). Lo stesso fa parlando di Elisabetta I e il suo rapporto con i mercanti di Anversa (in particolare, Thomas Gresham). In sostanza, lo Stato è sì una forza cruciale, ma se ne colgono le sue dinamiche interne e la sua commistione col mondo del privato e con gli interessi di classe (una delle ragioni per cui Arrighi tanto affascina chi parla di “capitalismo politico”).
[14] Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins e Immanuel Wallerstein, Antisystemic Movements, Verso Books, Londra e New York 1989; trad. it., I movimenti anti-sistemici, Manifestolibri, Roma 2000.
[15] Giovanni Arrighi, Marxist Century, American Century: The Making and Remaking of the World Labour Movement, in «New Left Review», 179 I (1990), pp. 29-63.
[16] Apice di questa visione è l’idea arrighiana che la Rivoluzione Industriale sia un mito da sfatare e che il successo della Gran Bretagna andrebbe fatta risalire a un processo molto più lungo (addirittura, a partire dalla conquista della Scozia e allo scisma anglicano del Cinquecento) delle semplici innovazioni ottocentesche. Ciò nonostante, il tema dell’innovazione è ben presente in Arrighi.
[17] Una serie di studi sull’economia dell’innovazione i cui padri fondatori sono, tra gli altri, Freeman, Dosi e Nelson.
[18] «He can only become an entrepreneur by previously becoming a debtor. […] He [the entrepreneur] is the typical debtor in capitalist society», Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Routledge, New York 2017, p. 102.
[19] Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, op. cit., p. 66; Adelino Zanini, Joseph A. Schumpeter. Teoria dello sviluppo e capitalismo, Bruno Mondadori, Milano 2000, p. 90.
[20] Schumpeter, citando Weber e Lenin, parla di “imprenditore di professione”, ovvero di imprenditore come colui che continua a innovare. Quando un industriale cessa questa attività e inizia semplicemente ad accumulare ricchezze tramite ciò che ha fatto in passato, diventa un capitalista
[21] Philippe Aghion, Céline Antonin e Simon Bunel, Le Pouvoir de la destruction créatrice, Odile Jacob, Parigi 2020; Alessandro Aresu, Le potenze del capitalismo politico, op. cit.; Patrizia Fariselli, Economia dell’innovazione, Giappichelli, Torino 2014; Mariana Mazzucato, Lo Stato innovatore, Laterza, Roma-Bari 2014.
[22] «Il fulcro e la spina dorsale dell’industria britannica di beni capitali nel XIX secolo – ferro e industria collegate – erano nulla più che una branca subordinata dell’esercito e della marina britannici. […] Quando, alla vigilia e nel corso delle guerre napoleoniche, le spese governative aumentarono e il livello della produzione e il ritmo dell’innovazione di prodotto e di processo dell’industria del ferro aumentarono nettamente e l’industria dei beni capitali divenne un “dipartimento” dell’economia britannica di gran lunga più autonomo […]. Le esigenze militari imposte all’economia britannica furono quindi determinanti per l’avvio delle successive fasi della rivoluzione industriale […]», Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, op. cit., 2014, p. 210.
[23] Jean Fallot, Marx e la questione delle macchine, La Nuova Italia, Firenze 1971.
[24] Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, op. cit., p. 14.
[25] Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino 1975, Q 9, § 67, p. 1138.