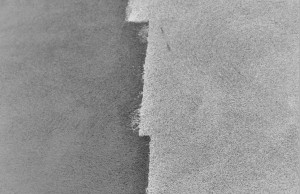L’umano fuori-uso Antropologia e tecnica in Günther Anders
set 14th, 2021 | Di Thomas Munzner | Categoria: Teoria e critica
Antropologia e tecnica in Günther Anders
Ci sono delle formule come quelle della «estraneità dell’uomo al mondo», della «non-appartenenza al mondo», della «vergogna prometeica» che ben raffigurano un percorso di ricerca pluridecennale, quello delineato da Günther Anders. Le sue riflessioni, nella critica dei processi di tecnicizzazione della realtà, sono condensate nella sua straordinaria opera L’uomo è antiquato. Rileggendo il percorso e i problemi posti dal filosofo di origine tedesca, Ubaldo Fadini ci guida nelle terre dell’antropologia negativa, affronta le patologie della libertà, offre spunti di analisi sull’era della tecnocrazia.
* * *
Ci sono delle formule come quelle della «estraneità dell’uomo al mondo», della «non-appartenenza al mondo», della «vergogna prometeica» che ben raffigurano un percorso di ricerca pluridecennale, quello delineato da Günther Anders. Un percorso che appunto si presenta sotto diverse vesti, come indicano le formule riportate, tra le quali spicca per la sua adattabilità a situazioni anche assai distanti tra loro quella di segno più propriamente «filosofico-sociale» e «filosofico-politica». È nota la riflessione di Anders – condensata in Die Antiquiertheit des Menschen (1956-80) – sulla perdita di esperienza e l’irrigidirsi della dinamica temporale nei processi complessivi di tecnicizzazione della realtà, rispetto ai quali si concretizza appunto quel sentimento di «vergogna prometeica» che deriva dalla consapevolezza, minore o maggiore, del dislivello sempre più marcato tra l’essere umano e il mondo artificiale dei prodotti. Anders fa sempre valere un ragionamento assai sofisticato, da un punto di vista filosofico, sul motivo della contingenza dell’umano, sulla sua estraneità di fondo nei confronti del mondo, su una indeterminatezza di base di tutto quello che lo concerne. I suoi primi scritti sono effettivamente da comprendersi come una raffigurazione originale dell’antropologia filosofica, di effettuazione squisitamente «moderna» e di valore comunque sempre «metafisico», per riprendere Max Horkheimer[1]. In Uomo senza mondo, Anders legge così la stagione della sua riflessione che si colloca appunto negli anni Venti, in modalità che si presentano anche con tonalità autocritiche: «L’uomo mi sembrava essere “senza mondo” da una prospettiva puramente ontologica: durante un intermezzo della mia vita – tra il 1920 e il 1927 circa – caratterizzato da un totale disinteresse politico, e oggi non più ripercorribile, intendevo con il termine “uomo senza mondo” un fatto esclusivamente antropologico-filosofico, ovvero che noi uomini (forse i soli tra le specie a noi note) non siamo predisposti a nessun mondo e a nessuno stile di vita specifici, ma piuttosto siamo costretti – in ogni epoca, in ogni luogo, se non addirittura quotidianamente – a procurarci o a crearci un mondo e uno stile di vita nuovi; e non facciamo altro che rendere positivo questo difetto antropologico della “non-predisposizione” quando ci autodefiniamo “storici” e “liberi” […]. È senz’altro concepibile che questa caratterizzazione […] riguardi solo l’uomo delle epoche recenti, soggetto a rapidi mutamenti. Comunque sia, allora vedevo “l’uomo” come non predisposto a un mondo specifico, e in questa aspecificità intravvedevo proprio la sua specificità. Quanto fu grande la mia sorpresa quando – vent’anni dopo aver definito filosoficamente questa “antropologia negativa” – al mio rientro dall’esilio, nel 1950, venni a sapere che un certo Arnold Gehlen era diventato famoso per aver elaborato questo concetto della “non-predisposizione” (rifacendosi a Nietzsche e alla sua idea del “Superuomo”), e questo molti anni dopo che io avevo esposto in una relazione tenuta nel 1929, ma pubblicata in francese, solo durante il mio esilio parigino»[2].
Prima di Gehlen, quindi, e in contemporanea (quasi) con i contributi di Max Scheler e di Helmuth Plessner. E indubbiamente la pubblicazione in francese ebbe un effetto importante anche su Jean-Paul Sartre e non soltanto su di lui (sia sufficiente rinviare ad alcuni autori, tra gli innumerevoli altri, presenti nelle «Recherches Philosophiques», laddove appunto i testi di Anders vennero tradotti: Sartre, Emmanuel Lévinas e il giovane Jacques Lacan, responsabile, con lo stesso Anders, delle recensioni di Psicologia ed estetica del volume V – 1935-36). In L’uomo è antiquato, Anders ritorna sul rapporto con l’antropologia filosofica, sottolineando anche la sua originale elaborazione di tematiche che in un qualche modo anticipano l’esistenzialismo: ad esempio, la particolare declinazione del concetto di «libertà». In questo testo, nel secondo volume, si legge: «Si capisce come di L’uomo è antiquato faccia parte una teoria sull’antiquatezza dell’antropologia filosofica: che il lamento sulla “fine dell’uomo” debba basarsi su un’idea ben determinata dell’uomo. Formalmente, quest’argomento non è errato. Se io sono rimasto debitore di questa “antropologia positiva”, non è stato solo perché, simile a un medico, non ho mai trovato tempo per teorizzare l’uomo sano, dunque per una mia preoccupazione; ma anche perché, da mezzo secolo a questa parte, ho visto nell’uomo l’essere che fondamentalmente non può essere sano e non vuole essere sano, insomma l’essere che non può essere determinato, l’essere indefinito, che sarebbe un paradosso voler definire. Nell’anno 1929 ho ampiamente abbozzato una tale “antropologia negativa”, in una conferenza intitolata Die Weltfremdheit des Menschen che tenni presso la Kantgesellschaft di Francoforte e nella quale, anni prima di Sartre, trattai la libertà dell’uomo come affermazione in positivo del suo non potersi stabilire in alcun luogo»[3].
Alle radici dell’antropologia negativa
Se si vuole dare un po’ di contenuto a queste riflessioni sull’esistenza umana, allora si deve gettare lo sguardo sulle prime espressioni di tale antropologia «negativa», in particolare proprio sulla relazione francofortese, tradotta in francese (Une interprétation de l’aposteriori) e il contributo, che vale come prosieguo del testo della relazione, intitolato Pathologie de la liberté, entrambi pubblicati nelle «Recerches Philosophiques» tra il 1934 e il 1936. La premessa del ragionamento di Anders, in prima battuta di carattere antropologico-filosofico, è la specificità della situazione dell’uomo nel mondo. L’uomo viene al mondo, il che significa un essere già presente del mondo, un suo «anticipo» che corrisponde al ritardo dell’essere umano, il quale ha come suo compito quello, mai pienamente risolvibile, di recuperare il suo ritardo, il suo venire «dopo». È a questo punto che si impone un confronto con l’animale, che non viene al mondo: anzi, il suo mondo, che si rivela essere una Umwelt, un ambiente, viene «con» lui. Da qui deriva un complesso di osservazioni, nel quale spicca la messa in evidenza di una sostanziale «estraneità dell’uomo al mondo», di una sua «insufficiente integrazione».
L’essere distaccato dalla natura stimola il rinnovamento di una prospettiva metafisica che «spiritualmente» ridisegna l’umano cogliendone l’«essenza» nell’azione, si potrebbe sempre dire sulla scia delle considerazioni di Horkheimer: ritorna così la figura dell’homo faber, di colui che interviene sulla realtà modellandola, modificandola, «trasportando» in essa «il suo divenire». È esplicito in tutto questo una idea dell’uomo come essere comunque distaccato dalla natura, un essere che «non è solo natura», che vive dell’/nell’incontro con «una natura». C’è una libertà essenziale, quella della prassi, che è da riferire proprio a quell’essere che sa compensare la sua estraneità di fondo, la sua distanza, che viene ad essere in qualche modo gestita attraverso la tessitura incessante di relazioni. A questo proposito ci sono delle pagine di Anders di grande risalto, soprattutto nel momento in cui sottolinea come in tale divenire l’uomo sia capace di creare «nuove e imprevedibili specie», di costruire un «suo» mondo, una sua «sovrastruttura», grazie all’applicazione di «categorie pratiche» che trasformano gli «eventi» in «fatti»: «L’uomo, dunque, è ben integrato nella sua situazione: per vivere, ha bisogno di un altro mondo, e deve, tramite l’invenzione, oltrepassare il mondo che gli si offre: ma è libero proprio per questo motivo. Il mondo, la cui offerta corrispondeva alla domanda dell’animale e in cui l’animale si trovava perfettamente in equilibrio, è al di sotto della domanda e delle impossibili pretese dell’uomo: ma l’uomo è capace di colmare questa insufficienza après coup (un “après-coup” condizionato a priori). L’uomo è tagliato per un mondo che non esiste; ma è anche capace di recuperarlo, di realizzarlo après coup»[4]. La lunga nota di accompagnamento a queste osservazioni rappresenta, ai miei occhi, un piccolo e straordinario saggio sull’essere costitutivamente disadattato dell’uomo, sul fatto che questo essere naturalmente non del tutto naturale (e quindi, in una certa misura, artificiale…) «non è tagliato per questo mondo; ma non è tagliato a vivere neppure per un altro mondo». La sua determinazione è quella espressiva dell’indeterminato, il suo non essere mai completamente fissabile è ciò che si traduce nella molteplicità delle vicende che costellano il suo esistere: è questa, la «mancanza di fissità», a presentarsi come la condizione necessaria «della sua libertà per una storia».
Non mi interessa ritornare in maniera dettagliata, in questa sede, sulla matrice fenomenologica del ragionamento complessivo andersiano, soprattutto in relazione ai testi più propriamente antropologici in senso filosofico. Voglio semplicemente ricordare come Anders sia un pensatore del carattere finito della libertà, intesa però antropologicamente e poi articolata in termini sociali e infine etico-politici: ciò che non lo convince affatto della riproposizione heideggeriana della classica questione ontologica è il fatto che il «mondo» del filosofo di Essere e tempo non è per niente il mondo reale, visto che lo si può inquadrare nella formula del «mondo-bottega», in un’ottica ontologica «da calzolaio», dato che in tale «mondo» «non ci sono ancora fabbriche» e le sue analisi rimandano così a un tempo prima di Marx. La pretesa di «concretezza», tipica di qualsiasi retaggio fenomenologico, non appare in grado di favorire il passaggio dal piano dell’analisi della «coscienza pura» a quello dei bisogni materiali. Heidegger è in breve responsabile, come il suo «maestro» Husserl, di una sorta di perdita della «realtà reale», di sparizione del «mondo», dato che delinea un’immagine dell’umano che non è capace di rilevarne la «fame» fondamentale, nella veste di «bisogno». Anders piega dunque la struttura unitaria dell’essere dell’esserci in una duplice direzione; la prima è quella che vede la struttura unitaria stessa collocarsi idealmente come presupposto di analisi critica di una condizione di decisiva incompletezza dello specifico umano (ed è qui che ha un ruolo essenziale la risoluzione dell’ontologia su un piano ancora fenomenologico), che viene poi colta – ed è questa la seconda direzione – in un’ottica d’inquadramento di segno storico e materialista delle lacerazioni e delle scissioni che la caratterizzano.
Patologia della libertà
Tornando però ai testi riferibili alla conferenza francofortese del ’29, va ribadito come il tentativo di individuare la singolare posizione dell’uomo nel mondo si accompagni all’indicazione del suo decisivo differire da quella degli altri esseri viventi, in primo luogo dell’animale. Il modo del confronto è quello privilegiato da Anders e verrà di nuovo riproposto nelle ricerche sulla Antiquiertheit des Menschen, con le considerazioni sull’anima «nell’epoca della seconda rivoluzione industriale» e sulla distruzione della vita «nell’epoca della terza rivoluzione industriale», con la variabile fornita dalla scelta di un altro termine di paragone: non più l’animale, bensì la «macchina». Ma anche in questo senso va tenuta presente l’apertura di Patologia della libertà, che risulta riassuntiva di buona parte del complesso delle analisi di Anders, sottolineando soprattutto il fatto che l’uomo, «a differenza dell’animale che conosce d’istinto il mondo materiale che gli appartiene e gli è necessario», «non prevede il proprio mondo», «ne possiede solo un a priori formale. L’uomo non è fatto per nessun mondo materiale, non può anticiparlo nella sua determinazione, deve piuttosto imparare a conoscerlo “après coup”, a posteriori, ha bisogno dell’esperienza. […] Nessun mondo gli è effettivamente imposto (come, viceversa, a qualsiasi animale è imposto un ambiente specifico), al contrario, egli trasforma il mondo e, con mille varianti storiche e come una sorta di sovrastruttura, vi edifica ora un “secondo mondo”, ora un altro. […] L’artificialità è la natura dell’uomo e la sua essenza è l’instabilità»[5].
È su questa base che Anders insiste sul fondamento antropologico della qualifica umana del saper astrarre, dello stesso fare astrazione, espresso dalla decisiva libertà di fronte al mondo che appunto restituisce l’uomo come un essere «astratto», contraddistinto da quella «condizione metafisica», dal non essere completamente «di questo mondo», che gli consente l’apertura e la produttività, in termini anche storici, della sua sensibilità e della sua intelligenza. Proprio su tale «condizione metafisica», Anders andrà a sviluppare, pure (auto)criticamente, la sua ricerca, nel senso di individuare anche le motivazioni assai concrete di un tradursi del non essere fino in fondo «di questo mondo» in direzione di un approfondimento e di una strumentalizzazione, storicamente data, del carattere patologico dell’essere umano, nella crescita di un pericolo che consiste nel rendere così astratto (oppure troppo poco: nei confronti del nuovo protagonismo delle «macchine») l’essere umano da allontanarlo definitivamente dal mondo stesso.
Ed è soprattutto il primo volume della Antiquiertheit des Menschen a presentarsi come una riflessione accurata – a partire dall’individuazione delle conseguenze dell’originaria «libertà prometeica» propria appunto dell’homo faber – sulla «metamorfosi dell’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale», la quale si concretizza in un contesto segnato da bisogni e desideri artificiali che orienta il vivere umano, a livello individuale e collettivo, in un modo tale che restituisce la nostra «anima» come decisamente attardata, laddove questo restare indietro rappresenta sempre più chiaramente lo scarto esistente, la differenza destinata ad allargarsi, tra l’imperfezione tipicamente umana e la precisione/perfezione crescente dei «suoi» oggetti, dei prodotti. Ci vergogniamo appunto di fronte alla superiorità, all’altezza a cui sono pervenuti i costrutti realizzati inizialmente con l’idea che potessero costituire tutt’al più dei buoni strumenti, dei mezzi efficaci per il perseguimento dei nostri obiettivi. È la vergogna la tonalità emotiva che si afferma come centrale in un mondo delineato da processi di tecnicizzazione talmente spinta che impediscono alla maggior parte di noi, esseri umani, di rivendicare con orgoglio la primazia ideativa, progettuale di quella loro realtà che si qualifica oggi come sovrana. A ciò concorre anche il fatto che i prodotti ci sono, materializzano un loro Dasein sotto veste soprattutto di merci, da quelle in fondo indispensabili a quelle superflue: ma in ogni modo desiderabili. Di fatto, le merci evidenziano una loro autonomia, una loro precedenza: soltanto comprandole diventano «nostre».
La fenomenologia andersiana di una vita emotiva fondamentalmente stressata, corrispondente all’affermarsi di una tecnocrazia all’altezza degli sviluppi del capitalismo contemporaneo, punta in definitiva a sottolineare come la vergogna di fronte al protagonismo marcato delle macchine si manifesti nel rapporto tra gli esseri umani e le cose. Non è sufficiente in tale ottica il rinvio al motivo «classico» della reificazione perché si ha ormai a che fare non soltanto con una possibile consapevolezza – «vergognosa» – dell’essere ridotti a oggetti: ciò che conta, per il concretizzarsi di questo stato emotivo, è che non si può superare la propria imperfezione e arrivare a essere perfetti come gli oggetti.
Dentro l’era della tecnocrazia
Per cogliere meglio questo passaggio dell’indagine, è opportuno riprendere il filo antropologico (in senso filosofico) che ben restituisce un quadro dell’umano contraddistinto da carenze e ritardi, disadattamenti vari, imprecisioni che colpiscono negativamente a confronto con il punto di vista delle macchine sempre più acuto, chiaro, certo. D’altra parte, queste ultime si presentano come effettivamente e vantaggiosamente fungibili, utilizzabili, rivelano quella serialità che assicura loro un più di perfezione, quello incessantemente e vanamente perseguito dagli esseri umani. Incessantemente perseguito, però: da qui deriva il complesso dei tentativi di individuare e correggere le nostre imperfezioni nel senso di consentire una vera e propria metamorfosi corporea, un miglioramento netto dei nostri assetti e delle nostre configurazioni, una trasformazione radicale della nostra sensibilità e intelligenza per modellarci diversamente ed entrare così in vera sintonia con il funzionamento delle macchine. Dato il quadro d’epoca del capitalismo novecentesco, con quei suoi sviluppi che ancora contano nel presente, tale metamorfosi corporea pretende di essere la risposta indispensabile, se si vuole: necessaria, per risolvere il carattere «antiquato» dell’umano, così come è conosciuto. Il compito è quello di acquisire progressivamente quelle caratteristiche dei prodotti (utilizzabilità, fungibilità, serialità) che l’imperfezione di base rende difficilmente realizzabili. Insomma, si tratta di operare al fine di correggere quelle mancanze naturali che ancora di più risaltano nel confronto con prodotti via via sempre più sofisticati e precisi, «perfetti».
Particolarmente interessante è allora l’indicazione andersiana del fatto che la «vergogna prometeica» deriva da un modellarsi comunque insufficiente dell’umano – difettivo, erroneo – rispetto alla progressione tecnologica e commerciale. Quest’ultima rivela un tendere verso l’immortalità che trova soddisfazione, sia pure concretamente parziale, nell’affermazione del principio di prestazione, di funzionalità meccanica: i prodotti, le merci, nel loro dovuto variare, durano in ogni modo più di noi. Si può anche dire che noi siamo e, insieme, non siamo come i prodotti, al di là di un modellarsi che non ha soste, il che vale a sottolineare la presenza in Anders di una sofisticata e preziosa fenomenologia delle modalità di assoggettamento proprie della soggettività contemporanea. Prendendo in considerazione, esemplificativamente, la condizione dell’operaio nel rapporto con le macchine, il punto indicato è quello dell’adattarsi, dell’entrare a far parte di un ingranaggio e quando questo non riesce e l’«io» fuori-esce dai ruoli assegnati, allora l’etichetta che gli viene socialmente appiccicata è quella del buono a nulla, dell’«inetto». Paradossalmente si può dire che da tale condizione non se ne esce: nel momento in cui sono le «cose» a essere libere, per via del protagonismo dilagante delle macchine, indispensabile per lo sviluppo capitalistico, il singolo si ritrova totalmente coinvolto nelle meccaniche produttive e di consumo oppure – e per caso e dunque raramente – si ritrova velocemente collocato in mezzo a coloro che sono privi di senno, stolti e deliranti, ovvero inutili. Nel processo di liberazione delle «cose», la libertà manca agli uomini.
Si ritorna così sul piano proprio di una fenomenologia della mancanza di libertà, accompagnata dalla rilevazione dell’approfondirsi della condizione di ottusità nella quale ci ritroviamo. L’estraneità di base, individuata antropologicamente, nei confronti del mondo, il nostro costitutivo scartare da esso, si trasforma quindi storicamente nell’essere incessantemente scartati, ridotti a scarto in uno scenario costruito sempre più mediaticamente e pubblicizzato come un vero e proprio a priori determinante, da considerarsi come la matrice dei nostri comportamenti e pensieri privati e pubblici. Il soggetto andersiano è fondamentalmente assoggettato: come figli di Prometeo non siamo più capaci di porci all’altezza del «padre». Perdiamo progressivamente il controllo delle nostre facoltà, l’agire e il conoscere si dissociano in modo tale da restituire lo scarto che aumenta tra il fare e il sentire. Certamente fa ancora capolino nelle pagine andersiane il motivo marxiano del «feticismo delle merci» (motore di gran parte del migliore pensiero critico-radicale novecentesco) e questo è da tenere presente soprattutto nel momento in cui si consideri il dislivello prometeico in termini storicamente determinati, attenti ai processi odierni di automazione delle attività produttive e, in definitiva, alle trasformazioni delle forze e dei rapporti produttivi (e delle stesse «condizioni di produzione», aggiungerebbe James O’Connor)[6].
L’acquisizione di una vita propria da parte dei prodotti assume la forma di un gigantesco processo di personalizzazione, al quale corrisponde un assoggettamento pieno degli esseri umani, un loro snaturamento, che li fa sentire meno in grado di far fronte ai compiti imprescindibili di una fase nuova della storia del mondo comprensiva della possibilità concreta che il pianeta possa essere distrutto (si pensi all’impegno di Anders contro il nucleare e alla sensibilità dimostrata nei confronti della questione ecologica). Impoverimento complessivo del sentire, affievolimento delle facoltà, inadeguatezza dilagante: tutto ciò trova espressione nel secondo volume di L’uomo è antiquato (con il suo sottotitolo particolarmente incisivo: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale), che vede il delinearsi ancora una volta di una antropologia filosofica considerata però all’interno di quell’«era della tecnocrazia», che sarebbe propriamente la nostra, caratterizzata da una riduzione della natura a oggetto di sfruttamento, a materia prima per la realizzazione del maggior numero possibile di prodotti e della maggiore energia spendibile possibile. Anche in tale prospettiva, l’indagine andersiana è ricca di elementi e ancora oggi estremamente stimolante – molto si potrebbe allora aggiungere ma quello che vorrei rimarcare infine è l’idea che l’essere umano sia in grado di scartare dalla stessa sua riduzione a residuo da gettare una volta spremuto – a livello cognitivo, emotivo e pratico – nei servizi di assoggettamento al «platonismo industriale», al tecno-capitalismo trionfante. C’è in Anders la convinzione che si possa ancora dare lettura e interpretazione critica di ciò che accade nel senso di una ri/animazione dell’umano. Si tratta indubbiamente di una piega essenziale del suo ragionamento che si qualifica sotto veste morale, meglio: etico-politica, considerato l’impegno, la militanza pacifista e antinucleare dello studioso: una presa di posizione a favore della vita contro la sua messa al servizio.
Note [1] Cfr. M. Horkheimer, Considerazioni sull’antropologia filosofica, in Teoria critica. Scritti 1932-1941, volume primo, a cura di Alfred Schmidt, trad. it. G. Backhaus – A. Solmi, Einaudi, Torino 1974. [2] G. Anders, Uomo senza mondo. Scritti sull’arte e la letteratura, trad. it. A. Aranyossy – P. P. Portinaro, a cura di Stefano Velotti, Spazio Libri, Ferrara 1991, pp. 33-34. [3] G. Anders, L’uomo è antiquato. 2. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, trad. it. M.A. Mori, Bollati Boringhieri, Torino 1992-2003, pp. 117-118. Approfitto di questa nota per richiamare alcuni studiosi che si sono proficuamente occupati di Anders: innanzitutto Pier Paolo Portinaro e, tra i più recenti, Natascia Mattucci e Devis Colombo. [4] Ivi, pp. 57-58. [5] G. Anders, Patologia della libertà. Saggio sulla non-identificazione, trad. it L.F. Clemente, a cura di L.F. Clemente – F. Lolli, introduzione di F. Lolli, Orthotes, Napoli-Salerno 2015, pp. 73-74. [6] Cfr. J. O’Connor, La seconda contraddizione del capitalismo. Introduzione a una teoria e storia dell’ecologia, prefazione di J.N. Bergamo – E. Leonardi, trad. it. G. Roggero, ombre corte, Verona, 2021.