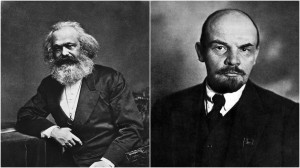Ancora sulla genialità rivoluzionaria di Lenin
nov 8th, 2020 | Di Thomas Munzner | Categoria: Primo Piano
GIANCARLO PACIELLO
Ancora sulla
genialità rivoluzionaria
di Lenin
Una premessa necessaria
Scrivo queste considerazioni nel settembre 2020. E, più avanti ne preciserò le ragioni.
Nel lontano 2004, a ottant’anni dalla morte di Lenin, il ricordo di questo gigante del XX secolo non ebbe, diciamo così, buona stampa. Mi fu chiesto, non certo per contrastare la marea degli insulti, di fornire la mia opinione “equilibrata” sul personaggio, partendo dalla storia e dai fatti che lo avevano visto coinvolto come uno dei protagonisti della prima Rivoluzione Proletaria, nota come la Rivoluzione d’Ottobre. Sapendo di poter contare su materiali storici importanti, accettai.
Il mio scritto di allora “Lenin, un genio rivoluzionario”, cominciava così:
“Se è scontato (ed opportuno) che si discuta il pensiero e l’operato dei grandi del passato, non dovrebbe essere altrettanto scontato (ed opportuno) che ci si accanisca contro di loro, criminalizzandoli, quando il loro pensiero e la loro azione sono in contrasto con il nostro modo di vedere di oggi o, peggio ancora, per pura strumentalità. Succede soprattutto ai rivoluzionari, in verità, ma anche a filosofi eccezionali, come Hegel ad esempio. E così, nell’ottantesimo anniversario della morte, è toccato a Lenin, un genio della politica come vedremo, essere vilipeso e caricato di una montagna di responsabilità da coloro che, sotto la sapiente (!?) guida di Silvio Berlusconi o forse sarebbe meglio dire del mondo del politicamente corretto, operano con tenacia alla criminalizzazione del comunismo. Operazione, a dire il vero, cominciata ben prima dell’arrivo del cavaliere alla ricerca del comunismo inesistente.
Eppure l’esperienza storica del comunismo (1917-1991), consumatasi nell’arco del secolo breve, secondo la felice definizione di Hobsbawm, ha inizio sette anni prima della morte di Lenin, che dunque ha potuto poco, quale che fosse la sua diabolica influenza, sulla evoluzione complessiva dell’esperienza comunista. Certamente Lenin contribuì, con la sua genialità, a trasformare una guerra imperialista, un massacro immondo, che rimane ancora privo di diaboliche responsabilità, in una rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, contro un potere oppressivo, quello degli zar, in una Russia dalla quale, chi poteva, fuggiva. Tanto per fare un esempio scelto a caso, più di un milione di ebrei emigrò dalla Russia, negli anni che vanno appunto dal 1882 al 1914, per la quasi totalità negli Stati Uniti, oltre che, in minima parte, in Palestina.
Non è mia intenzione polemizzare con i ‘maestri’ di storia dei nostri quotidiani, che si sono accaniti con Lenin, né con le assai prudenti e ahimè modeste risposte che a costoro sono state date sulle pagine di Liberazione, quanto piuttosto ripercorrere, da ammirato estimatore, il percorso seguito da Vladimir Iljic Uljanov nella sua breve quanto emozionante vita di rivoluzionario. Ripeto, del riferimento a questa criminalizzazione mi sono servito soltanto per un incipit di totale presa di distanza dal modo di concepire una rievocazione e soprattutto la Storia.
E, visto che mi è scappata la maiuscola, è opportuno indicare a chi mi sono ispirato, derubandolo spesso anche nella formulazione del testo. Si tratta dello storico e filosofo Massimo Bontempelli, del quale non mi stancherò mai di elogiare le capacità, anche narrative. In particolare, mi riferisco a quel prezioso libro “Il respiro del Novecento, Percorso di storia del XX secolo” uscito nel 2003 per i tipi della C.R.T. di Pistoia. Un libro scritto per coloro che amano la storia, per coloro che si occupano di politica e vogliono farlo in modo storicamente consapevole e soprattutto per gli studenti.
La società in cui viviamo è una società interamente dominata dal mercato e continuamente riplasmata dai suoi automatismi, e non ha più riferimenti che la preservino da mutamenti umanamente devastanti. Perciò la nostra società, i giovani soprattutto, hanno bisogno di un’educazione all’autonomia di pensiero e al valore della personalità spirituale dell’uomo. Ed è proprio la conoscenza storica, in quanto conoscenza particolarmente in grado di far emergere possibilità antropologiche cancellate dall’attuale sviluppo sociale, ma custodite nella memoria del passato, che può favorire tutto questo. Riconciliatomi con un orizzonte di senso molto significativo, affronto questo lavoro che, da solo, non avrei nemmeno osato pensare di cominciare, e del quale però mi assumo totalmente la responsabilità”.
E veniamo alle ragioni.
Se, nel 2004, era stata una sollecitazione esterna a spingermi a realizzare lo studio su Lenin che ho realizzato prescindendo da quanto di lui si dicesse a proposito e a sproposito, ora invece, intendo completare quello studio, rimasto un po’ appeso, partendo da una polemica non evitabile con la trasmissione “Passato e Presente” diretta da Paolo Mieli su Rai3, in particolare quella in cui si analizzava la figura di Trotzkij.
La trasmissione, per parlare di Trotzkij, doveva ovviamente parlare della Rivoluzione d’Ottobre, che viene presentata da un inserto cinematografico d’epoca con un commento sonoro decisamente più recente. Bene, il commento sonoro la definisce un colpo di stato! Un bell’esordio. Lo storico Lucio Villari, alla fine del filmato trova un po’ forte la definizione, pur sostenendo che la vera rivoluzione è quella di febbraio, e Mieli non trova di meglio che definirla un colpo di mano. Geniale! Ha conservato la parola “colpo” presente nel filmato, ha accontentato Villari che non trovava opportuno accoppiare a detta parola la specificazione “di stato” e alla stessa parola, da storico di vaglia, accoppia la specificazione “di mano”. Spettatore silente e sbigottito, non ho potuto che applaudire.
E ho deciso, fortunato come sono per il fatto di disporre, all’età di ottantatré anni, ancora di buone energie, di completare il mio lavoro del 2004 che era stato pubblicato, sulla rivista Comunismo e Comunità, in due puntate (Parte prima e Parte seconda). Mi accingo perciò a riprendere il filo di un discorso “sospeso” sedici anni fa, con una Parte terza e le necessarie conclusioni che, sia pure en passant, non potranno non evidenziare il degrado raggiunto anche dalla divulgazione. Qui di seguito il testo del 2004, comprensivo delle due parti. La Parte terza la troverete al posto che le compete. Buona lettura!
Lenin: un genio rivoluzionario
di Giancarlo Paciello
Parte prima
…
Ho paura che una corona sulla sua testa
possa nascondere la sua fronte
così umana e geniale,
così vera. Sì, io temo
che processioni e mausolei,
con la regola fissa dell’ammirazione,
offuschino d’aciduli incensi
la semplicità di Lenin; io temo,
come si teme per la pupilla degli occhi,
ch’egli venga falsato
dalle soavi bellezze dell’ideale.
…
V. Maiakovsky
1. Il destino dei grandi
Se è scontato (ed opportuno) che si discuta il pensiero e l’operato dei grandi del passato, non dovrebbe essere altrettanto scontato (ed opportuno) che ci si accanisca contro di loro, criminalizzandoli, quando il loro pensiero e la loro azione sono in contrasto con il nostro modo di vedere di oggi o, peggio ancora, per pura strumentalità. Succede soprattutto ai rivoluzionari, in verità, ma anche a filosofi eccezionali, come Hegel ad esempio. E così, nell’ottantesimo anniversario della morte, è toccato a Lenin, un genio della politica come vedremo, essere vilipeso e caricato di una montagna di responsabilità da coloro che, sotto la sapiente (!?) guida di Silvio Berlusconi o forse sarebbe meglio dire del mondo del politicamente corretto, operano con tenacia alla criminalizzazione del comunismo. Operazione, a dire il vero, cominciata ben prima dell’arrivo del cavaliere alla ricerca del comunismo inesistente.
Eppure l’esperienza storica del comunismo (1917-1991), consumatasi nell’arco del secolo breve, secondo la felice definizione di Hobsbawm, ha inizio a sette anni dalla morte di Lenin, che dunque ha potuto poco, quale che fosse la sua diabolica influenza, sulla evoluzione complessiva dell’esperienza comunista. Certamente Lenin contribuì, con la sua genialità, a trasformare una guerra imperialista, un massacro immondo, che rimane ancora privo di diaboliche responsabilità, in una rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, contro un potere oppressivo, quello degli zar, in una Russia dalla quale, chi poteva, fuggiva. Tanto per fare un esempio scelto a caso, più di un milione di ebrei emigrò dalla Russia, negli anni che vanno appunto dal 1882 al 1914, per la quasi totalità negli Stati Uniti, oltre che, in minima parte, in Palestina.
Non è mia intenzione polemizzare con i “maestri” di storia dei nostri quotidiani, che si sono accaniti con Lenin, né con le assai prudenti e ahimè modeste risposte che a costoro sono state date sulle pagine di Liberazione, quanto piuttosto ripercorrere, da ammirato estimatore, il percorso seguito da Vladimir Iljic Uljanov nella sua breve quanto emozionante vita di rivoluzionario. Ripeto, del riferimento a questa criminalizzazione mi sono servito soltanto per un incipit di totale presa di distanza dal modo di concepire una rievocazione e soprattutto la Storia.
E, visto che mi è scappata la maiuscola, è opportuno indicare a chi mi sono ispirato, derubandolo spesso anche nella formulazione del testo. Si tratta dello storico e filosofo Massimo Bontempelli, del quale non mi stancherò mai di elogiare le capacità, anche narrative. In particolare, mi riferisco a quel prezioso libro “Il respiro del Novecento, Percorso di storia del XX secolo” uscito nel 2003 per i tipi della C.R.T. di Pistoia. Un libro scritto per coloro che amano la storia, per coloro che si occupano di politica e vogliono farlo in modo storicamente consapevole e soprattutto per gli studenti. La società in cui viviamo è una società interamente dominata dal mercato e continuamente riplasmata dai suoi automatismi, e non ha più riferimenti che la preservino da mutamenti umanamente devastanti. Perciò la nostra società, i giovani soprattutto, hanno bisogno di un’educazione all’autonomia di pensiero e al valore della personalità spirituale dell’uomo. Ed è proprio la conoscenza storica, in quanto conoscenza particolarmente in grado di far emergere possibilità antropologiche cancellate dall’attuale sviluppo sociale, ma custodite nella memoria del passato, che può favorire tutto questo. Riconciliatomi con un orizzonte di senso molto significativo, affronto questo lavoro che, da solo, non avrei nemmeno osato pensare di cominciare, e del quale però mi assumo totalmente la responsabilità.
2. Ma chi era Lenin?
…
Ma chi è dunque?
Quali gesta ha compiuto?
Di dove viene quest’uomo
di ogni uomo più umano?
Vladimir Uljanov nacque a Simbirsk, cittadina sul Volga, il 10 aprile 1870. Il padre, Ilja Uljanov, si era laureato e, dopo una brillante carriera, era diventato ispettore scolastico regionale ottenendo la nobiltà per meriti di servizio. La madre, Maria Blank, aveva rinunciato all’insegnamento per il matrimonio, seguendo però attivamente l’impegno del marito, che proprio a Simbirsk era stato inviato a sovrintendere a quattrocento scuole della regione circostante.
Vladimir Uljanov visse perciò un’infanzia tranquilla, in una casa circondata dal verde, in una famiglia numerosa, di rango sociale elevato e molto stimolante intellettualmente. Nel 1879, all’esame d’ammissione al ginnasio-liceo, una scuola esclusiva, risulta primo. Negli anni seguenti, ha sempre il voto più alto in tutte le materie, sulle orme del fratello maggiore Aleksandr, studente di matematica all’università di Pietroburgo. Vladimir Uljanov vive felicemente, la facilità di studio è per lui gratificante, i viaggi d’estate nelle diverse zone del Volga lo entusiasmano.
Ma, purtroppo, di colpo, il periodo spensierato finisce.
Il 12 gennaio 1886, muore improvvisamente il padre. Non ancora sedicenne, Vladimir Uljanov non regge psicologicamente e reagisce con aggressività nei confronti della madre, che accusa inconsciamente della morte del padre. Per fortuna, il fratello Aleksandr torna da Pietroburgo e si fa carico della famiglia. Ma, soltanto un anno dopo, Aleksandr che, all’insaputa di tutti, militava tra i narodniki, viene arrestato con l’accusa di aver partecipato a un piano per assassinare Alessandro III, mai attuato. All’alba dell’8 maggio 1887, Aleksandr viene impiccato.
Questa volta la reazione di Vladimir è del tutto diversa. Consola la madre, aiuta il fratello e la sorella più piccoli, studia superando la maturità con il massimo dei voti in tutte le materie. Ma la tragedia della sua famiglia continua. Proprio ad un anno di distanza dalla morte del fratello, muore Olga, sua sorella maggiore. L’evento porta la madre sulla soglia del suicidio. L’isolamento della famiglia è fortissimo, in quanto imparentata con un terrorista regicida. Vladimir convince allora la madre a vendere la casa e a trasferirsi a Kazan, dove frequenta la facoltà di giurisprudenza.
Gli eventi drammatici hanno segnato sicuramente Vladimir Uljanov. In particolare, un’identificazione con il fratello ucciso, lo riempie di odio per i Romanov e lo spinge a conoscere la galassia dei gruppi ostili al regime zarista. Mentre studia a Kazan, milita tra i narodniki ma resta colpito dagli scritti, trovati tra le carte di suo fratello, di Nikolay Cernysevskij che, senza fare alcuna concessione all’ideologia dei narodniki, considerava la monarchia zarista barbara e parassitaria, auspicava una rivoluzione popolare che la travolgesse, sostenendo invece la necessità dell’industrializzazione, attuata in un quadro democratico caratterizzato dal governo parlamentare, dal suffragio universale, dal voto alle donne e da una scuola moderna.
Come se non bastasse, Vladimir Uljanov viene espulso dall’università di Kazan per aver partecipato ad una manifestazione studentesca. Riesce ad ottenere l’autorizzazione ad iscriversi a quella di Pietroburgo (a 3000 chilometri da casa!). Anche la famiglia lascia Kazan, trasferendosi in una tenuta presso Samara, più a sud, sempre sul Volga. Nei cinque anni (1888-1893) trascorsi tra Pietroburgo e Samara, fa le letture decisive per la sua formazione ideologica: Socialismo e lotta politica di Plekanov che lo orienta decisamente verso il marxismo, il primo libro de Il Capitale e Per la critica dell’economia politica di Marx.
Laureatosi nel 1893, si trasferisce a Pietroburgo per fare l’avvocato. In maggio è in Svizzera, dove conosce i membri del gruppo Emancipazione dal lavoro, in particolare Plekanov, e con essi prende accordi per stabilire legami permanenti. Alla fine di giugno è a Parigi, dove conosce Paul Lafargue. Segue un soggiorno a Berlino di più di un mese, dove studia la letteratura marxista. A settembre torna in Russia dove con altri giovani intellettuali divenuti marxisti dà vita, nel 1895, all’Unione per la liberazione della classe operaia. E la polizia politica zarista, l’Ochrana, li arresta tutti. Vladimir Uljanov, arrestato il 9 dicembre 1895, resta in carcere per un anno.
Il procuratore dello zar non trova nessun reato specifico di cui accusarli e non li rinvia ad un processo, ma considerandoli rivoluzionari chiede per loro l’esilio amministrativo interno, che comporta l’obbligo a risiedere per tre anni in sperduti villaggi della Siberia. Vladimir Uljanov deportato in Siberia, nel villaggio di Sciscenkoje vi resta dal 1897 al 1900, e si sposa con Nadezda Krupskaja, una giovane e colta rivoluzionaria, figlia di un ufficiale, un refusnik ante litteram, destituito per essersi rifiutato di agire crudelmente contro i ribelli polacchi. Pur deportato, Vladimir Uljanov continua ad avere contatti con i centri dirigenti del movimento operaio in Russia e con il gruppo Emancipazione dal lavoro all’estero, è in corrispondenza con i socialdemocratici deportati in altre località, oltre che lavorare a Lo sviluppo del capitalismo in Russia.
Berlusconi, consultato sull’autocrazia russa, da noto esperto, direbbe che in realtà anch’essa, come il regime fascista poi, mandava i suoi oppositori politici in villeggiatura!
Alla fine del maggio 1900, termina l’esilio siberiano e Vladimir Uljanov, prima di andarsene in esilio volontario in Svizzera, dove pensa di poter lavorare a fianco dell’idolatrato maestro di marxismo, Plechanov, viaggia per tutta la Russia, per incontrare i socialdemocratici di diverse località e concordare con loro la collaborazione ad un giornale che intende creare. Il 16 giugno parte per Zurigo, per poi spostarsi a Ginevra e a Monaco di Baviera. Il rapporto con Plekanov però lo delude, per la scarsa inclinazione all’azione politica del maestro e la “gelosia” nei confronti di chi voglia agire in nome del marxismo. In particolare, Plechanov ostacola l’idea di Vladimir Uljanov di rivitalizzare, potenziandone le possibilità di proselitismo, il partito operaio socialdemocratico russo fondato formalmente nel 1898, con la creazione di un giornale clandestino.
Ma Vladimir Uljanov non desiste. Nel dicembre del 1900, esce il primo numero del giornale. Nel corso del 1901 trova una stamperia, alcuni redattori colti marxisti, capaci di scrivere in modo comprensibile per un vasto pubblico, corrieri da inviare in Russia e, in Russia, diffusori clandestini. Riesce così nella straordinaria impresa di far uscire e far circolare dodici numeri dell’Iskra (scintilla, capace di far divampare il fuoco della rivoluzione, questo è il senso attribuito al titolo).
Con l’Iskra Vladimir Uljanov si consacra come capo rivoluzionario. E dunque è già conosciuto quando nel 1902 espone in un libretto, Che fare?, le sue idee sulla rivoluzione. Proprio questo libretto, che fa di lui il dirigente più famoso e discusso negli ambienti rivoluzionari marxisti, è firmato con lo pseudonimo di Lenin, uomo della Lena. La Lena è il maggior fiume della Siberia dove, prima di Vladimir Uljanov, era stato deportato più a lungo e più brutalmente Cernysevskij, colpevole soltanto di aver scritto romanzi sgraditi al regime zarista. Dunque, in omaggio a Cernysevskij, Lenin sceglie il titolo del suo libretto del tutto identico a quello di un romanzo di Cernysevskij. Il nome di Lenin evoca ad un tempo la deportazione siberiana e l’oppressione del potere dei Romanov.
3. La Russia prima di Lenin
…
Sua Altezza il Capitale,
senza corona e diadema,
piegava in schiavitù la forza contadina;
la città derubava e saccheggiava
e impinguava l’obesa pancia
delle sue casseforti.
Come si è visto non doveva essere facile, per un democratico, figuriamoci per un rivoluzionario, vivere nella Russia dei Romanov. A questo punto è però necessario, per non confinare su di un piano puramente astratto Lenin, sempre teso, al contrario, a misurare la teoria con la realtà circostante (l‘analisi concreta della situazione concreta), fornire un quadro della società russa con la quale Lenin si misurerà.
Ricostruiremo perciò, con la brevità che un articolo di una rivista impone, il contesto storico che va dal 1825 al 1914, dividendolo in due parti, una che va dal 1825 al 1870, e l’altra che va dal 1871 al 1914. Non c’è un particolare motivo per questa suddivisione salvo che, nel primo periodo, arriveranno al pettine per l’autocrazia russa, nodi che essa punterà a risolvere proprio nel periodo che comprende la quasi totalità della vita di Lenin, vita dedicata a dare una soluzione del tutto opposta ai nodi di cui si diceva, oltre naturalmente al fatto che il 1870 è anche l’anno della nascita di Lenin.
Lo zar Nicola I (1825-1855) sale al trono proprio in coincidenza con la repressione del moto insurrezionale di alcuni ufficiali dell’esercito favorevoli all’instaurazione di un regime costituzionale (detto decabrista per essere avvenuto nel dicembre 1825), che segna l’inizio di una profonda involuzione reazionaria della Russia, con la celebrazione del processo ai decabristi secondo le più barbariche tradizioni russe, che fa largo uso di torture come mezzi di inquisizione e di condanne a morte eseguite mediante squartamento (1826). Il settore più colto e occidentalizzato della nobiltà russa ne rimane tanto spaventato da smettere totalmente di occuparsi della vita pubblica. Proprio lo scopo che intendeva raggiungere lo zar, per instaurare una autocrazia totale, il cui strumento esecutivo è costituito da un apparato burocratico sempre più numeroso, gerarchizzato, disciplinato, e dotato di poteri illimitati, purché ubbidisca alle direttive dello zar.
Allo scopo di appoggiare questo apparato burocratico nel suo compito di subordinare tutte le sfere della vita sociale allo Stato autocratico, viene creata una polizia segreta, l’Ochrana (1827), che si serve di spie infiltrate dappertutto, dalle osterie ai salotti della nobiltà, dagli alberghi alle università. Ma, per tenere sotto controllo la formazione culturale dei giovani ed in genere ogni manifestazione di pensiero, per impedire sia l’infiltrazione di idee occidentali negli strati superiori della società, sia la possibilità che dalle scuole escano burocrati anche soltanto dubbiosi della necessità di una ubbidienza totale allo Stato autocratico e della piena validità delle tradizioni, Lo zar crea la cosiddetta Terza Sezione dello Stato, un organo di inquisizione sui sistemi di istruzione e sulle manifestazioni di pensiero (1828). Questa istituzione promuove una censura sulla stampa così rigida che i giornali si limitano a riprodurre i decreti ufficiali e non vengono più pubblicate traduzioni di libri occidentali. Riorganizza in senso reazionario il sistema scolastico (1828), che porta all’esclusione di tutti coloro che non siano nobili, dal diritto di frequentare lezioni universitarie al divieto per i giovani anche nobili di frequentare università straniere, alla sostituzione, nelle facoltà giuridiche, dell’insegnamento del diritto bizantino al posto del diritto romano e moderno, alla soppressione dell’insegnamento della filosofia, all’obbligo per gli studenti di tutte le scuole di portare speciali uniformi e all’introduzione di una disciplina scolastica di stampo militare che prevede la fustigazione come punizione per infrazioni anche minime.
3.1 L’autocrazia russa: crepe nel sistema del mir e nella servitù della gleba
Nel 1849, con la seconda Restaurazione, non sembra esserci alternativa tra un prossimo divampare della rivoluzione borghese in Europa e un definitivo consolidamento dei regimi reazionari in tutto il continente. Alla base di questa seconda possibilità sembra esserci, ancora una volta, la potenza della Russia zarista, che appare la potenza continentale egemone come dopo le sue campagne vittoriose contro Napoleone. In realtà, la potenza russa è più apparente che reale. Infatti, la forza dell’autocrazia russa, era nata tra il XVIII e il XIX secolo, da un mondo contadino più vasto e popoloso di quello di qualsiasi altro paese europeo, capace di fornire quindi un numero di soldati molto maggiore, e organizzato secondo il sistema del mir, cioè della comunità di villaggio dotata di una certa autonomia ed economicamente autosufficiente. Il mir garantiva ai contadini russi la possibilità di autodeterminare diversi aspetti della loro vita quotidiana e offriva a ciascun individuo una certa protezione comunitaria contro gli arbitrii dei nobili e degli stessi funzionari dello Stato, oltre che contro le difficoltà individuali. Questi contadini, anche per la loro ignoranza, finché il mir ha funzionato come involucro protettivo, hanno preferito sopportare la loro condizione senza ribellarsi. E sulle loro spalle è stata costruita la potenza della Russia.
Ma questa situazione va gradualmente modificandosi nel corso del XIX secolo. Si è infatti accentuata la tendenza, già assai forte, della nobiltà ad acquistare beni di lusso all’estero che richiedono pagamenti di grosse quantità di denaro, in nessun modo ottenibili dalle prestazioni in lavoro o in natura dovute dai servi della gleba. Per ottenere il denaro necessario, i nobili allora danno impulso a forme di attività economica che cominciano a disgregare il mir e ad indebolire le fondamenta della servitù della gleba. Per prima cosa i nobili aumentano le esportazioni di cereali e di cotone. Espandono perciò i latifondi nobiliari a scapito della terra tradizionalmente lasciata al mir, e intensificano progressivamente il lavoro contadino sul latifondo. Si avvalgono in certi casi delle fabbriche di possessione, che altro non sono che fabbriche in cui fanno lavorare senza altro compenso che non sia quello del puro mantenimento, i loro servi della gleba.
Ma comunque il più diffuso metodo dei nobili è quello di sottrarre al mir una parte dei suoi contadini, non per sottoporli ancor più pesantemente alla servitù della gleba, ma al contrario per esonerarli da ogni altro onere derivante dalla loro servitù in cambio di un pagamento di un periodico tributo in denaro, detto obrok. I contadini soggetti all’obrok sono perciò autorizzati a disporre liberamente del loro tempo e del loro lavoro, anche abbandonando il villaggio e contraendo autonomamente contratti con estranei proprio per procurarsi di che pagare l’obrok. I contadini lo preferiscono infatti, ma sarà proprio l’obrok a disgregare la comunità di villaggio e a corrodere le fondamenta della servitù della gleba. Il mir infatti sentirà sempre meno tollerabili gli obblighi feudali per coloro che rimangono, senza poter offrire nessuna garanzia ai contadini soggetti all’obrok. Questi, risultano a tutti gli effetti, compresi quelli giuridici, servi della gleba e quindi tutte le concessioni fatte loro sono sempre revocabili. In definitiva, l’istituto della servitù della gleba finisce per apparire sempre più ingiusto ed assurdo anche agli occhi di chi ne è stato esonerato, per l’incertezza che fa gravare sulla loro sorte.
3.2 L’autocrazia russa: perdita dell’egemonia in Europa
A questi fattori interni d’indebolimento del potere zarista, i cui effetti si faranno sentire progressivamente nel tempo, c’è da aggiungere un altro fattore le cui conseguenze sono pronte a manifestarsi in maniera dirompente. Si tratta del divario crescente tra lo sviluppo produttivo della Russia e quello dei principali paesi europei che hanno conosciuto l’industrializzazione capitalistica. Dalle loro industrie escono non soltanto beni di consumo e di investimento ma anche fucili, polvere da sparo, cannoni e altre attrezzature di tipo militare, mentre in Russia non c’è nessuna forma di industria moderna.
Il controllo turco sugli Stretti (Bosforo e Dardanelli) soffoca sempre più le esportazioni russe verso l’Occidente proprio mentre l’aristocrazia russa ha sempre più bisogno di accrescere le esportazioni per poter pagare i costi sempre più elevati delle sue importazioni. La Turchia non si limita a pretendere tangenti sulle merci russe, ma vende in misura crescente merci che fanno concorrenza a quelle russe. Alla metà del secolo, il grano ed il cotone turchi venduti sul mercato inglese superano in quantità quelli russi. Nel 1853 lo zar Nicola I, per evitare il consolidamento di una situazione disastrosa per l’economia russa, si intromette nella contesa sorta tra ecclesiastici di diverse confessioni cristiane sul diritto di disporre di alcune chiese di Gerusalemme (che Henry Laurens chiamerà giustamente L’invention de la Terre sainte) e chiede al sultano di riconoscerlo come protettore della Chiesa greco-ortodossa dell’Impero turco, con il diritto di amministrazione dei suoi luoghi di culto in Palestina. Un tale riconoscimento implicherebbe il libero transito delle navi russe attraverso gli Stretti, necessario per garantire il collegamento tra Russia e Palestina, e creerebbe perciò i presupposti di una crescente influenza russa in Turchia. Il sultano non risponde e lo zar fa occupare militarmente, a scopo intimidatorio verso la Turchia, i principati di Moldavia e Valacchia.
A questo punto, l’Inghilterra appoggia apertamente la Turchia, sia per conservare il diretto controllo del proprio commercio con il Vicino Oriente, che sarebbe minacciato da un’eventuale presenza della flotta russa nel Mediterraneo, sia per il crescente fabbisogno di cereali della sua popolazione e di cotone greggio della sua industria che la orientano a non dipendere soltanto dalla Russia per l’importazione di queste merci, ma anzi di comprare in quantità maggiore quelle meno costose prodotte dall’impero ottomano. Incoraggiato dall’appoggio inglese, il sultano si fa audace e invia un ultimatum allo zar nell’ottobre del 1853, intimandogli di sgombrare i principati danubiani entro quindici giorni, passati i quali la Turchia sarebbe entrata in guerra. E lo zar inizia la guerra contro la Turchia, prima ancora della scadenza dell’ultimatum. Certamente sa di dover affrontare non solo la debole Turchia ma anche la forte Inghilterra. Ma conta anche sull’alleanza dell’Austria, aiutata dalla Russia pochi anni prima nella riconquista dell’Ungheria, e sulla neutralità della Francia.
Non è dunque preoccupato, se fiancheggiato dall’Austria, di dover lottare contro Turchia ed Inghilterra, sia per la grande debolezza della Turchia sia per la difficoltà dell’Inghilterra a tradurre il suo potenziale industriale in forza militare, sprovvista com’è di un esercito di leva. Ma i calcoli dello zar risultano completamente sbagliati: la Francia entra in guerra con l’Inghilterra a fianco della Turchia, e l’Austria alla gratitudine contrappone il proprio interesse. Non vale la pena di rischiare una guerra contro la Francia e l’Inghilterra soltanto per favorire l’espansione russa nei Balcani, e rimane neutrale.
La guerra, dunque, iniziata tra Russia e Turchia nell’ottobre 1853, vede la dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra alla Russia nell’aprile del 1854, subito dopo le prime sconfitte turche. L’attacco franco-inglese punta a colpire la Russia là dove trova riparo la sua flotta da guerra del Mar Nero e da cui viene smistata la maggior parte delle armi in dotazione al suo esercito, e cioè nel porto e nella fortezza di Sebastopoli, in Crimea. E con il nome di guerra di Crimea, questo conflitto è passato alla storia. Come base per raggiungere la Crimea, le forze franco-inglesi occupano, con un clamoroso gesto di prepotenza internazionale, il porto del Pireo in Grecia (maggio 1854), anche allo scopo di paralizzare la tendenza filo-russa del re, reazionario, Ottone di Grecia. La Grecia subisce così un’umiliazione nazionale, e re Ottone rimane sul trono soltanto perché accetta di rendere il paese, di fatto, un protettorato dell’Inghilterra. In Crimea risulta chiaramente la superiorità militare delle forze franco-inglesi su quelle russe, per il fatto di avere alle spalle un’industria degli armamenti, anche se la loro esiguità numerica, accresciuta dalle vittime di una spaventosa epidemia di colera, le mette inizialmente in difficoltà.
L’esigenza di fare affluire in Crimea soldati di rinforzo, spinge i franco-inglesi a fare il tentativo di ottenerli dall’Austria, facendola entrare in guerra contro la Russia in cambio di compensi nei Balcani a danno della Russia stessa. Nel corso della prima metà del 1855 rimane aperta la possibilità di un intervento dell’Austria, che però preferisce confermare la propria neutralità, anche perché, nel frattempo, 15 mila soldati di rinforzo sono stati inviati dal regno di Sardegna, entrato in guerra (aprile 1855) senza alcun preciso interesse, in séguito ad una forte pressione diplomatica francese, allo scopo di evitare di essere assoggettato ad un’umiliazione nazionale simile a quella subita dalla Grecia. Le forze anglo-franco-piemontesi, vinta una decisiva battaglia sul fiume Cernaia (agosto 1855), riescono poi ad espugnare Sebastopoli (settembre 1855).
Il nuovo zar Alessandro II (1855-1881), nel frattempo successo a Nicola I, è allora costretto alla resa. Il trattato di pace che pone termine alla guerra di Crimea, stipulato a Parigi nell’aprile 1856, prevede che la Russia rinunci agli Stretti, ceda alla Turchia la sovranità sulla Moldavia, sulla Valacchia e su una piccola parte della Bessarabia alle foci del Danubio, oltre a smilitarizzare il Mar Nero. La perdita della foce del Danubio significa la perdita del controllo russo sulla locale navigazione fluviale e quindi sull’esportazione granaria della zona. La smilitarizzazione del Mar Nero significa poi che la Russia non può tenere lungo le sue coste né navi da guerra, né porti militari, né arsenali. La guerra di Crimea segna un brusco arresto nella secolare tendenza espansionistica dell’Impero russo, contribuendo in maniera decisiva ad incrinarne la potenza.
3.3 L’autocrazia russa: il ricorso alle riforme
L’esito rovinoso della guerra in Crimea e le successive esplosioni di malcontento contadino in alcune zone della Russia convincono Alessandro II della necessità di compiere importanti riforme nella società russa, perché l’autocrazia zarista possa sopravvivere. Egli si rende conto, cioè, che la superiorità militare delle potenze occidentali è ormai diventata tale che il potere zarista è esposto ad ogni umiliazione sul piano internazionale, e che questa situazione è destinata a durare e ad aggravarsi progressivamente, ponendo in crescente pericolo l’integrità stessa dell’Impero russo, fino a quando anche l’esercito zarista non sarà armato e addestrato come gli eserciti occidentali.
Ma ciò non sarà possibile senza dotare la Russia di una moderna industria degli armamenti, senza una riforma dell’istruzione pubblica, che renda possibile la formazione di tecnici adeguati alle necessità dell’industria e dell’esercito, e senza una riforma della vita civile, che crei il clima adatto per la diffusione delle scoperte tecniche e scientifiche avvenute in Occidente e per una migliore preparazione degli ufficiali e dei funzionari. È anche evidente, però, che tutto ciò sarà inutile se rimarrà in vigore la servitù della gleba.
Soltanto l’abolizione di questa istituzione, che assicura mano d’opera gratuita alle forme più arcaiche di conduzione agricola, potrà decidere i grandi proprietari a compiere nelle proprie terre quegli investimenti economici senza i quali la Russia non è in grado di accrescere in misura sufficiente le sue esportazioni e, di conseguenza, la sua capacità di importazione, in maniera tale da poter acquistare dall’estero le attrezzature necessarie all’industrializzazione. Soltanto l’abolizione della servitù della gleba, inoltre, liberando i contadini dall’obbligo di risiedere permanentemente nei villaggi in cui sono nati, per essere sempre a disposizione dei loro signori, potrebbe fornire all’industria la mano d’opera necessaria al suo sviluppo.
Alessandro II vede anche più lontano. Dal momento che la servitù della gleba, è diventata un fattore di disgregazione del sistema del mir e non è più tollerata da larghi strati del mondo contadino, essa rischia ormai di creare nelle campagne russe una nuova ondata di quei disordini che nei secoli passati hanno talvolta portato il potere zarista sull’orlo della dissoluzione. Quanto ciò sia chiaro per lui è dimostrato da una frase da lui pronunciata nel 1856 in un discorso tenuto ai nobili della città di Mosca: “Ricordatevi che è meglio per voi che la servitù della gleba sia soppressa ora dall’alto anziché aspettare che tra qualche tempo venga distrutta dal basso“.
Tutte queste ragioni spiegano perché Alessandro II cominci la sua opera riformatrice con l’editto del 19 febbraio 1861 (ovverosia del 4 marzo 1861, secondo il nostro calendario, essendo il calendario russo dell’epoca anticipato di tredici giorni rispetto a quello occidentale: cosa che ricordiamo qui una volta per tutte, limitandoci d’ora in poi a riportare tutte le date secondo il calendario russo), Questo editto decreta l’abolizione della servitù della gleba. Una storica riforma, destinata tuttavia a provocare effetti economici, sociali e politici certamente di grande portata, ma di natura assai diversa da quella voluta.
Lo zar e i suoi consiglieri promotori della riforma si sono infatti prefissi di conseguire scopi contraddittori con i valori sociali e politici ai quali la loro azione di governo rimane ancorata, e dunque di impossibile realizzazione. Aboliscono la servitù della gleba non perché si preoccupano del benessere dei contadini ma perché vogliono salvaguardare il potere dell’autocrazia zarista e il dominio di classe dell’aristocrazia feudale, facendo a meno di un’istituzione diventata controproducente per i suoi stessi beneficiari. Ciò spiega, tra l’altro, i cinque anni trascorsi tra il primo annuncio della riforma e la sua effettiva attuazione, che sono stati dedicati a continui contatti e consultazioni con i nobili, per tenere conto dei loro interessi irrinunciabili e per ottenere il loro consenso.
Né gli investimenti nell’agricoltura e l’avvio dell’industrializzazione sono assunti come fini prioritari ai quali subordinare ogni altra considerazione, ma, come novità di cui sarebbe stato meglio fare a meno, ma che occorre realizzare in quanto rappresentano gli unici mezzi possibili per consolidare il potere dell’autocrazia zarista e dell’aristocrazia feudale. Gli interessi di quest’ultima rimangono un punto di riferimento dal quale l’azione governativa non si discosta mai, come è inevitabile che sia in uno Stato feudale, sino al punto da progettare una riforma destinata a non essere in grado né di promuovere gli investimenti nell’agricoltura, né, tanto meno, di dare avvio ad un processo industrializzazione.
L’editto del 19 febbraio 1861 concede certamente ad ogni contadino la libertà personale, nel senso che lo libera da qualsiasi obbligo di prestazione gratuita di lavoro e gli dà il diritto di compiere per proprio conto atti (quali ad esempio il trasferimento di residenza, il matrimonio con persona di altro villaggio, la vendita della propria forza-lavoro al miglior offerente, la stipula di contratti a proprio nome, ecc.), per i quali in precedenza era necessario il consenso dei signore di cui il contadino era servo. Il contadino russo diventa perciò, per la prima volta dopo diversi secoli, soggetto di diritto. Ma non riceve, per il proprio sostentamento, la stessa terra fino ad allora tenuta come servo.
La legge prescrive infatti che i signori lascino ai contadini i due terzi, e non la totalità, degli arativi precedentemente loro assegnati come servi, ad esclusione completa, di prati e boschi, considerati d’ora in poi non più oggetto di diritti comuni ma proprietà private dei signori. Ai contadini, dunque, la riforma lascia poca terra, e la peggiore, visto che i signori, che hanno il diritto di riprendere loro, a propria scelta, un terzo degli arativi, si riprendono i più fertili e per giunta, impedisce loro, con la sottrazione di tutti i pascoli, di allevare bestiame. Lo scopo di queste disposizioni è non solo quello di lasciare più terre ai signori, ma anche quello di impedire che i contadini possano diventare economicamente autosufficienti, perché in questo caso i signori non potrebbero disporre di mano d’opera a buon mercato. L’abolizione della servitù della gleba punta a sostituire la necessità economica alla costrizione giuridica come ragione per la quale i contadini debbano lavorare per i signori, mettendo a disposizione di costoro braccia in grande quantità, facilmente acquistabili in cambio di bassi salari.
Ma in tal maniera, tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei signori, il mondo contadino viene mantenuto in una condizione di miseria tale da non essere in grado di offrire un mercato di sbocco alla produzione manifatturiera, che così, in assenza di un mercato interno (la popolazione urbana russa è numericamente troppo insignificante per costituirlo), non ha la possibilità di svilupparsi su scala industriale. E non basta! Neppure la poca terra concessa ai contadini dalla legge di riforma, viene assegnata ai contadini in proprietà piena, in quanto è giuridicamente considerata proprietà signorile che essi ricevono in usufrutto con facoltà di riscatto. Viene così prevista dall’editto dello zar una complicata operazione di riscatto per la quale il contadino è chiamato a rimborsare in cinque anni il 20% del valore delle terre concessegli, mentre il rimanente 80% sarà corrisposto ai signori direttamente dallo Stato in obbligazioni fruttifere, e il contadino sarà considerato debitore dello Stato della somma che esso ha anticipato per lui, accresciuta di esorbitanti interessi, tanto da doverne pagare per ben quarantanove anni rate annuali corrispondenti al 6% del valore dell’anticipazione fatta dallo Stato.
Lo scopo di queste vessatorie disposizioni è quello di assicurare per mezzo secolo all’autocrazia zarista un tributo straordinario gravante sui contadini, con cui far fronte ad ampie spese per l’ammodernamento dell’esercito, e di fornire ai signori, sempre facendone gravare il peso sui contadini, il denaro liquido necessario per gli auspicati investimenti agricoli. Ma quest’ultimo obiettivo viene del tutto mancato, in quanto il denaro viene dato ad un’aristocrazia i cui caratteri arcaicamente feudali sono consolidati proprio dal modo incondizionato in cui i suoi interessi trovano tutela. Succede così che l’aristocrazia russa spende le grosse somme che le sono devolute a titolo di riscatto per pagare i propri debiti, per moltiplicare i propri consumi di lusso, per darsi a costosissimi viaggi nell’Europa occidentale, e solo raramente e in minima parte per compiere investimenti economici. E poi, disponendo di nuove somme da sperperare, essa avverte ancora meno la necessità di occuparsi della gestione delle proprie terre. Di conseguenza, anche se la riforma è stata concepita, come si è visto, per mettere a disposizione dei signori mano d’opera salariata a buon mercato, essi nella maggior parte dei casi rinunciano all’assunzione di braccianti salariati, che comporterebbe il proprio impegno diretto nella gestione agricola, e preferiscono dare in affitto ai contadini affamati di terra lotti arabili, bestiame e pascoli, in cambio di prestazioni lavorative che solitamente non si distinguono da quelle un tempo loro dovute come servi se non per il fatto di essere ora assunte per contratto.
L’abolizione della servitù della gleba, inoltre, per il modo in cui avviene, all’inizio accresce anziché ridurre il malcontento di gran parte della popolazione rurale, che aveva creduto, divenuta libera, di poter continuare a tenere a propria disposizione la solita terra, e soprattutto di averla senza dover pagare alcunché, e che si sente perciò crudelmente beffata. In molte tra le assemblee dei mir, convocate per dare comunicazione della riforma, la lettura dell’editto dello zar dà luogo ad interruzioni e lagnanze, soprattutto nella parte riguardante gli oneri di riscatto, che terrorizza i contadini per la pesantezza e la lunghissima durata degli oneri stessi, facendo loro prevedere la fame ad ogni cattivo raccolto. Frequentemente, alla lettura dell’editto dello zar, viene espresso dai contadini il desiderio che tutto rimanga come prima, apparendo quasi preferibile l’antica servitù alle pesanti condizioni della nuova libertà, e in qualche caso si hanno persino vere e proprie sommosse. L’asprezza dell’opposizione contadina viene poi però riassorbita dalla rinnovata vitalità del sistema del mir. La riforma prevede infatti che le terre siano lasciate non ai contadini singoli ma alle loro comunità di villaggio, che assumono il compito di ridistribuirle periodicamente in usufrutto alle varie famiglie in proporzione del numero dei loro componenti, e che diventano responsabili collettivamente del pagamento delle tasse e degli oneri di riscatto. In questo modo, la comunità viene ad essere direttamente interessata al lavoro di tutti i suoi membri, e lo Stato riconosce questo suo interesse delegando ad essa il diritto di concedere o negare ad ogni suo membro un passaporto interno necessario per andare a risiedere e a lavorare altrove.
Persino alcuni poteri giurisdizionali prima esercitati dai signori sui contadini, ed ora venuti meno in conseguenza della soppressione della servitù della gleba, sono trasferiti alla comunità di villaggio. Il mir insomma, eredita alcune funzioni prima esercitate dai signori, e vede consolidato il suo ruolo economico e amministrativo, di modo che i contadini, nonostante la loro miseria, finiscono per accettare le loro condizioni di vita, perché le comunità in cui vivono offrono loro qualche tutela e li integrano molto strettamente in collettività omogenee, anche se li isolano sempre più dalla società esistente al di fuori del villaggio, accentuando la loro ignoranza. Ma il costo pagato per una simile stabilizzazione sociale è costituito non soltanto dalla creazione di un ulteriore elemento di intralcio per lo sviluppo economico, ma anche da una tale separazione e chiusura dei villaggi contadini da recidere le basi dellatradizionale influenza dell’aristocrazia sui contadini stessi.
Alessandro Il prosegue la sua opera riformatrice in Russia con una serie di provvedimenti che, uniti all’abolizione della servitù della gleba, dovrebbero, secondo lui, fondare su nuove e più solide basi il suo regime autocratico. Così, con l’editto del primo gennaio 1864 istituisce in ogni distretto e in ogni provincia della Russia una assemblea rappresentativa della popolazione locale (i suoi membri devono infatti essere eletti per il 40% dai nobili, per il 40% dai contadini, per il 15% dagli ecclesiastici e per il 5% dai borghesi). Tale assemblea, chiamata zemstvo, ha come propri compiti quelli di provvedere alla manutenzione delle strade e al miglioramento delle comunicazioni, di combattere le epidemie e la moria del bestiame, di promuovere lo sviluppo agricolo, di curare l’istruzione pubblica e di compiere opere assistenziali, con facoltà, a tutti questi scopi, di assumere ingegneri, agronomi, medici ed insegnanti. Con l’editto del 14 luglio 1864 tutte le scuole (elementari o superiori, gestite da organi dello Stato oppure da enti ecclesiastici o comunque privati) vengono aperte ai sudditi di ogni classe sociale e rinnovate nei contenuti dell’insegnamento, attraverso l’introduzione dello studio delle scienze naturali e delle lingue straniere, e attraverso la soppressione della censura preventiva sulle opere di argomento scientifico e una migliore qualificazione degli insegnanti. Infine, con l’editto del 19 novembre 1864 lo zar compie la più profonda tra le sue riforme, quella cioè dell’ordinamento giudiziario, che garantisce l’indipendenza dei tribunali nei confronti degli organi di governo attraverso l’inamovibilità dei giudici e l’abolizione di ogni loro subordinazione agli alti funzionari di Stato, e che sancisce la pubblicità dei processi e norme procedurali tali da assicurare il rispetto del diritto alla difesa dell’imputato e la rapidità del giudizio.
Benché in parte contraddetta da altre disposizioni che consentono al governo di imporre il domicilio coatto e persino l’arresto e la condanna al. lavoro forzato per via amministrativa (senza, cioè, un processo e una sentenza giudiziaria) in caso di reati contro lo Stato, che introducono per i contadini tribunali speciali abilitati ad emettere sentenze anche senza rispettare alcune garanzie degli imputati, e che sottraggono ai tribunali ordinari la competenza per i reati del clero e dell’alta nobiltà, tuttavia questa riforma cambia effettivamente il volto della vita civile russa. Diventa addirittura un luogo comune dire che le aule dei tribunali siano, in occasione dei dibattimenti processuali, gli unici luoghi in Russia dove esista effettiva libertà di parola. E la categoria sociale degli avvocati comincia ad esistere, in Russia, in séguito alla riforma giudiziaria del 1864. Tuttavia l’insieme di queste riforme, per il modo con cui esse sono attuate, e soprattutto in conseguenza del modo in cui è stata abolita la servitù della gleba, non produce l’auspicata modernizzazione della Russia, ma accresce la frustrazione e la rabbia degli esigui strati della borghesia e della nobiltà dedita ad attività commerciali.
3.4 Nascita dell’opposizione all’autocrazia
Negli anni Sessanta sorgono così in Russia i primi gruppi rivoluzionari, a composizione quasi esclusivamente giovanile e intellettuale. Essi si dividono in due tendenze fondamentali, e cioè quella dei bakunisti o insurrezionalisti e quella dei lavrovisti o propagandisti. I primi si richiamano al rivoluzionario Michail Bakunin, e propugnano la formazione di una setta segreta a carattere cospirativo che sia in grado di compiere, nel più breve tempo possibile, un colpo di Stato per abbattere lo zarismo e restituire il potere al popolo. I secondi sono invece seguaci del filosofo Pétr Lávrov, proveniente dalla ricca nobiltà, dotato di vastissima cultura, il quale, nelle sue Lettere storiche, stampate clandestinamente nel 1866, sostiene che la rivoluzione potrà diventare possibile solo dopo che il popolo sarà uscito dalla sua attuale condizione di ignoranza e di oscurità mentale, per cui il compito più urgente è quello di illuminare il popolo stesso con un’attiva propaganda fatta soprattutto attraverso opuscoli clandestini. Comune ad entrambe le tendenze è il fine ultimo dell’abolizione dello Stato e dell’autogoverno del popolo, una volta che nel popolo siano state eliminate tutte le disuguaglianze sociali. In Russia, cioè, non si sviluppa per il momento alcuna tendenza rivoluzionaria di tipo liberal-borghese, volta a trasformare l’autocrazia zarista in una monarchia costituzionale, a causa della quasi totale mancanza di una vera e propria società civile e di una borghesia i cui affari siano indipendenti dallo Stato.
I rivoluzionari russi dell’epoca, infatti, non sono specificamente borghesi ma giovani intellettuali con difficoltà di inserimento sociale, provenienti un po’ da tutti i ceti superiori, ad eccezione di quelli strettamente legati allo zarismo come la nobiltà feudale e l’alta burocrazia. Sui rivoluzionari russi, e soprattutto sui lavrovisti, esercita larga influenza lo scrittore russo Aleksandr Herzen, esule a Londra, inizialmente fautore di una rivoluzione liberaldemocratica e di una occidentalizzazione della Russia, ma poi deluso dal 1848 europeo (vissuto in prima persona), è passato all’idea che la Russia debba evitare l’avvento della borghesia, del capitalismo e dello Stato liberale, e realizzare una rivoluzione basata sui principi comunitari del suo mondo contadino.
4. La Russia di Lenin
…
Ma intanto,
gobba sui torni e macilenta
nasceva la classe operaia
e già come una minaccia
alzava nel cielo le ciminiere.
Nel corso degli anni Settanta dell’Ottocento, Marx si convince che i presupposti di una futura rivoluzione stiano maturando in Russia. Quindi non si limita a raccogliere e a leggere saggi di autori russi ma stabilisce anche un contatto epistolare con alcuni tra i più noti oppositori rivoluzionari del regime zarista, informandosi sulle condizioni in cui operano, rispondendo alle loro domande, dando loro preziosi suggerimenti. Da questo momento perciò, cioè mentre è ancora vivo, la figura ed il pensiero di Marx entrano a far parte della storia della Russia. Tutto ciò corrisponde ad una crescita effettiva del movimento rivoluzionario.
4.1 La repressione autocratica e l’evoluzione dell’opposizione
Dopo il 1870 i lavrovisti cominciano a fare rapidamente nuovi proseliti, in alcuni settori professionali del ceto medio, al punto da arrivare a contare circa una decina di migliaia dì aderenti. Benché scompaginati, nell’autunno 1873, da un’ondata di arresti effettuati dalla polizia zarista di duemila di loro, traducono in pratica con appassionato entusiasmo, nella primavera 1874, l’appello, a suo tempo lanciato ai giovani rivoluzionari da Herzen, di “andare al popolo“, recandosi a lavorare e a vivere tra i contadini in diversi villaggi del bacino del Volga e di quello del Dnjepr.
Partendo dalla convinzione, come lavrovisti, della necessità di preparare la futura rivoluzione con un lungo periodo di pacifica attività di propaganda volta a liberare il popolo dalla sua ignoranza, hanno poi maturato l’idea dell’impossibilità di compiere efficacemente un’attività senza condividere vita, fatiche e dolori del popolo lavoratore, mescolandosi con esso per identificarsi con ciò che esso sente e pensa, e poterne così influenzare lo sviluppo. Questa nuova idea li trasforma in qualcosa di più e di diverso da semplici lavrovisti. Essi cominciano allora a definirsi “narodniki“, cioè “amici del popolo” (dal termine russo “narod” che vuol dire appunto “popolo“), tanto che vengono conosciuti in Occidente come “populisti“.
Spesso i contadini reagiscono con diffidenza e fastidio nei confronti di questi intellettuali rivoluzionari venuti improvvisamente in mezzo a loro con la pretesa di aiutarli e di educarli, ma senza riuscire a dissimulare che non hanno né conoscenze agricole, né familiarità con i costumi rurali, né fisico adatto a sopportare le fatiche dei campi. In qualche caso succede persino che i contadini, irritati nel sentir fare discorsi contro lo zar, perché ne idealizzano ancora la figura di “padre del popolo“, o perché temono di trovarsi di fronte ad agenti provocatori, consegnino i giovani venuti tra di loro alla polizia zarista.
Ci sono però anche casi di contadini che diventano amici dei rivoluzionari e persino rivoluzionari essi stessi. È perciò indubbio che negli anni Settanta quello dei narodniki è un movimento rivoluzionario che cresce, facendo proseliti nel ceto medio intellettuale e mettendo anche le prime radici in qualche zona del mondo rurale, dove cominciano infatti a circolare le loro parole d’ordine sul ritorno ai mír delle terre usurpate dai nobili al tempo dell’abolizione della servitù della gleba, sulla soppressione della tassa straordinaria di riscatto, allora dovuta dai contadini allo Stato, e sulla lotta accanita alla piaga dell’usura, praticata nelle campagne da affaristi senza scrupoli, che sfruttano la necessità che i contadini hanno di ottenere anticipi di denaro nelle stagioni morte dell’anno agricolo, per non morire di fame. Accanto al vero e proprio movimento rivoluzionario costituito dai narodniki si sviluppa, nello stesso periodo, anche una tendenza vagamente rivoluzionaria, e comunque di aspra ostilità al regime zarista, tra gli studenti dei ginnasi e delle università, e si forma inoltre, presso l’esigua borghesia russa, un moto di opinione antizarista, che trova espressione nell’attività della componente borghese degli zemstvo, e degli avvocati e dei giudici popolari nelle aule giudiziarie.
Di fronte al crescere di tali tendenze, la risposta della monarchia zarista è quella di annientare i fermenti esistenti con la pura e semplice violenza repressiva, tornando agli sperimentati principi dell’autocrazia tradizionale. In questo modo, però, come Marx subito lucidamente intuisce, il regime zarista si pone, costrettovi dagli interessi feudali che deve tutelare, in una strada senza sbocco, perché le vaste repressioni che comincia ora ad alimentare sono destinate, in un paese rimasto estraneo allo sviluppo economico moderno, a moltiplicare per il futuro le tensioni sociali, indebolendo nello stesso tempo la forza dello Stato, a causa dell’abbandono completo di ogni impegno a modernizzarne le istituzioni e le basi economiche. Di qui, secondo Marx, il graduale accumularsi, in Russia, dei presupposti di una futura rivoluzione, sia pure entro tempi imprecisabili.
Questa reazione autocratica si manifesta, prima di tutto, nella seconda metà degli anni Settanta, sotto forma di violenza poliziesca, che viene indirizzata principalmente contro la pacifica propaganda dei narodniki, ritenuta pericolosissima in quanto rivolta ai contadini. Diventa allora tristemente famoso il capo della polizia di Pietroburgo generale Fedor Trepov, che fa incarcerare centinaia di narodniki anche soltanto per aver pronunciato in pubblico frasi di condanna del regime zarista, e li trattiene in carcere per mesi, prima di consegnarli ai giudici, in modo da poterli umiliare e maltrattare durante gli estenuanti interrogatori ai quali li fa sottoporre.
I narodniki sono così spinti ad abbandonare il terreno della propaganda e delle agitazioni pacifiche in cui si sono finora mossi. Due episodi in particolare, che si verificano nel 1877, li inducono a mutare il loro modo di agire. Un primo episodio è costituito dalla denuncia fatta da uno studente di Pietroburgo, incarcerato per errore e quindi rilasciato pochi giorni dopo, di essere stato denudato e frustato da Trepov in persona, venuto proprio in quei giorni ad ispezionare le carceri della città. Il secondo episodio è costituito dalla denuncia, fatta in un’aula di un tribunale da circa duecento narodniki processati per propaganda contro il regime zarista, di avere subito vere e proprie torture, che hanno portato alla morte di dieci loro compagni.
Di fronte a questi episodi la maggior parte dei narodniki ancora liberi fondano l’organizzazione “Zemlja i Volja” (cioè “Terra e Libertà“), che mantiene gli obiettivi di fondo propri di tutti i narodniki (terra ai mir e libertà dei contadini dall’usura e dalle tasse straordinarie di riscatto), ma che decide di perseguirli agendo clandestinamente e usando la violenza armata sia per cercare di liberare i propri compagni arrestati sia per colpire a morte i funzionari colpevoli di maltrattamenti nei loro confronti. Nei suoi soli due anni di esistenza – dal 1877 al 1879 – questa organizzazione di narodniki porta a compimento audaci imprese, di liberazione a mano armata di prigionieri politici e di attentati a sanguinari sgherri del regime zarista, che attirano su di loro vaste simpatie nell’opinione pubblica borghese, e che gettano nella costernazione e nello sgomento diversi funzionari incaricati della repressione, che si sentono ora in pericolo di vita
Il successo più clamoroso viene conseguito da Zemlja i Volja nel 1878, allorché una sua aderente appena diciottenne Vera Zasulic, riesce dapprima a ferire gravemente in un attentato il generale Trepov, eludendo l’eccezionale sorveglianza da cui il capo della polizia si fa proteggere, quindi a farsi assolvere al processo da coraggiosi giudici borghesi, convincendoli di aver agito per legittima difesa dei suoi compagni illegalmente arrestati e maltrattati, ed infine a sfuggire, con l’aiuto di una folla solidale, alla polizia venuta ad arrestarla nuovamente, all’uscita dal tribunale, nonostante l’assoluzione dei giudici.
Questi successi inducono una parte degli aderenti a Zemlja i Volja a proporre l’uso della violenza armata non più soltanto per difendere l’organizzazione dagli arbìtri e dalle crudeltà dei funzionari di polizia, ma anche e soprattutto per scardinare l’apparato dello Stato seminando il terrore tra i suoi membri, e dare così al popolo il coraggio di fare la rivoluzione. I sostenitori di questa tesi vengono subito denominati terroristi, e trovano una fortissima opposizione in altri narodniki detti antiterroristi e decisi a rimanere fedeli ai metodi tradizionali di lotta. Allo scopo di trovare una soluzione ai laceranti contrasti emersi a proposito della proposta, avanzata nelle sue file, di passare alla lotta terroristica Zemlja i Volja tiene a Voronez un congresso clandestino, nell’estate del 1879, che approda, dopo quattro giorni di accanite discussioni, allo scioglimento dell’organizzazione, incapace di una qualsiasi mediazione tra le opposte tesi che si agitano al suo interno.
La tesi contraria al terrorismo è sostenuta con particolare vigore da Georgij Plechanov, un intellettuale di straordinaria erudizione, il quale, citando numerose fonti, tra cui Marx, cerca di convincere i congressisti che è ormai scientificamente dimostrato che l’evoluzione dei popoli dipende da leggi precise, immutabili come quelle naturali e determinate dai rapporti economici, e non può quindi venire abbreviata da interventi violenti della volontà umana come l’uccisione di singoli esponenti del regime dominante.
La tesi favorevole al terrorismo è invece sostenuta da un ex servo della gleba, Andrej Zeliabov, il quale si dice convinto che se i narodniki, condannato a morte lo zar, e resi pubblici i motivi della condanna, fossero poi riusciti ad eseguirla, avrebbero facilmente spinto il popolo alla rivoluzione. Perciò, sciolta Zemlja i Volja, tutti i narodniki fautori del terrorismo, unitisi sotto la guida di Zeliabov, danno vita ad una nuova organizzazione (ottobre 1879), denominata “Narodnaja volja“ (Libertà del popolo), che fa subito conoscere il proprio obiettivo di attentare alla vita dei più alti funzionari dello Stato e prima di tutto a quella dello zar, per scardinare l’apparato dello Stato e suscitare la rivoluzione.
Comincia allora un’impressionante serie di tentativi, falliti, per un soffio, di uccidere lo zar (1879-’80), che, per il fatto stesso di ripetersi implacabilmente a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro nonostante l’eccezionale sforzo compiuto dall’intero apparato poliziesco, dimostrano che i terroristi sono numerosi e ben organizzati, e godono di vaste simpatie e conseguenti complicità. Oltre a questo, giuoca a favore dei terroristi l’avere un capo come Zeliabov, che rivela subito una straordinaria abilità nel predisporre organizzativamente gli attentati, destreggiandosi tra le maglie della sorveglianza poliziesca e sapendo sempre dove trovare complicità e come procurarsi armi, tanto che il saperlo in libertà finisce per portare Alessandro II ad un crollo nervoso. La lotta a morte ingaggiata tra la polizia e i terroristi, pur portando alla cattura e all’impiccagione di molti di questi ultimi, vede anche l’uccisione, in micidiali agguati di ritorsione, di diversi alti funzionari di polizia, e soprattutto, dimostra ogni volta che l’organizzazione terroristica continua a funzionare anche dopo la cattura di folti gruppi di suoi aderenti.
Nel gennaio 1881, la polizia zarista giunge però, dopo complesse indagini e continui pedinamenti, a catturare un gruppo più numeroso del solito di terroristi, e attraverso le confessioni loro estorte con la tortura, riesce, il mese dopo, ad arrestare anche quasi tutti i membri del loro comitato esecutivo, Zeliabov compreso. Alessandro II si crede allora salvo. Invece gli unici due membri del comitato esecutivo di Narodnaja volja rimasti in libertà, che sono due audacissime donne, e cioè Sofja Perovskaja e Vera Figner, si assumono subito tutti i compiti prima svolti da Zeliabov, ritenuto insostituibile, e si impegnano ad organizzare un nuovo attentato allo zar.
Un attentato da compiersi alla disperata, cioè con l’impiego di tutte le forze ancora disponibili in azioni anche eventualmente suicide, e nel più breve tempo possibile, prima cioè che la polizia arrivi anche agli ultimi capi di Narodnaja volja. Così, in occasione di una parata militare a Pietroburgo cui deve partecipare lo zar, molti terroristi armati di bombe si mescolano alla folla che vi assiste, dislocati nei più diversi punti della città e pronti ad agire agli ordini delle due donne, trasmessi attraverso un complicato sistema di segnalazioni a distanza da esse stesse ideato, e che all’atto pratico funziona perfettamente. Molti di loro, come è stato previsto nella logica di un’azione organizzata in maniera suicida pur di raggiungere l’obiettivo, sono scoperti e disarmati dalla polizia. Ma, essendo in tanti, succede che uno di loro scaglia alcune bombe contro lo zar mancandolo e uccidendo due uomini del suo seguito, e un altro, infine, poco dopo, lo colpisce in pieno. Entrambi sono catturati, ed è catturata anche Sofja Perovskaja. Ma Alessandro II cade sotto i loro colpi, il primo marzo 1881 secondo il calendario russo.
L’uccisione dello zar Alessandro II costituisce il momento culminante di un periodo di tensione rivoluzionaria, caratterizzato, oltre che dalla lotta terroristica condotta dalla Narodnaja volja, anche da continue agitazioni studentesche e persino da sommosse contadine, sia pure episodiche e circoscritte. Quanti riflettono sulla prospettiva della rivoluzione in Russia cominciano perciò ad interrogarsi sui suoi prevedibili protagonisti ed esiti sociali, per ricavarne le indicazioni di strategia rivoluzionaria meglio adeguate alle condizioni del paese. Si tratta in particolare di capire se la Russia è destinata, attraverso una rivoluzione, a superare la sua arretratezza orientale per imboccare la via dello sviluppo capitalistico proprio come l’Europa occidentale, con il conseguente emergere di un proletariato di fabbrica cui sia possibile propagandare le idee socialiste già circolanti in Occidente, o invece a percorrere una sua specifica via basata sullo sviluppo di un suo comunitarismo agricolo, e di cui siano protagonisti, quindi, i villaggi contadini.
4.2 Contrattacco dell’autocrazia e riforme
Nel febbraio 1881 la rivoluzionaria Vera Zasulic, esule a Ginevra, scrive una lettera a Marx che si trova a Londra, e gli chiede il suo parere, ponendogli la questione in questi termini: “Vi sono soltanto due possibilità. O la comunità di villaggio, una volta liberata con una rivoluzione dalle smodate esigenze del fisco zarista, dagli obblighi di ogni genere nei confronti dei proprietari nobili ed ecclesiastici, e dagli arbìtri polizieschi è capace di svilupparsi in senso comunista, vale a dire di ordinare su base collettivistica la produzione agricola e poi anche manifatturiera, ed in questo caso il socialista rivoluzionario è tenuto a consacrare tutte le sue forze alla liberazione ed allo sviluppo delle comunità contadine. Oppure, al contrario, la comunità di villaggio è destinata a scomparire per effetto di un ineluttabile sviluppo capitalistico, ed in questo caso al socialista rivoluzionario non resta che la propaganda tra i primi operai di città“.
La risposta che Marx invia a Vera Zasulic è complessa e problematica. Egli rivela che il processo di dissoluzione del mir russo è già cominciato, per cui la Russia, a suo avviso, può evitare di entrare irreversibilmente in una fase capitalistica del suo sviluppo storico soltanto a condizione che una rivoluzione vi si verifichi entro un breve periodo di tempo. Egli si attende inoltre dalla rivoluzione in Russia – con lo squilibrio del sistema politico europeo che comporterebbe, e con il messaggio liberatorio che trasmetterebbe – un impulso decisivo per spingere alla rivoluzione socialista il proletariato occidentale. Ma avverte anche Vera Zasulic che se ciò non si verificasse, se cioè il proletariato occidentale rimanesse politicamente passivo anche dopo una rivoluzione in Russia, la rivoluzione russa non avrebbe la minima possibilità di approdare al comunismo, ed il capitalismo rimarrebbe pur sempre l’unica via possibile di modernizzazione del paese. Egli ritiene infatti che il comunismo, irrealizzabile su basi soltanto agrarie, abbia bisogno di uno sviluppo della produzione industriale di cui nessuna comunità contadina sarebbe capace, e che quindi i contadini russi non possano inserire una moderna industria nelle loro strutture collettivistiche di lavoro, in modo da fare di esse la base economica di una società comunista, se non con un aiuto esterno di mezzi, tecniche e cultura, che soltanto il proletariato occidentale, ove avesse il potere, potrebbe loro dare. Egli conclude infatti così il suo ragionamento:
“Se una rivoluzione contadina russa fosse il segnale per una rivoluzione operaia in Occidente, sì che l’una integrasse l’altra, allora soltanto l’odierna comunità di villaggio russa potrebbe diventare il punto di partenza di uno sviluppo comunista“.
La prospettiva di una rivoluzione comincia tuttavia a sfumare, in Russia, proprio dal momento in cui, con l’uccisione di Alessandro II, la tensione sembra salita al massimo. Tra i contadini russi oppressi dallo sfruttamento feudale dei nobili si diffonde infatti sempre più l’idea che lo zar non solo non sia responsabile di tale sfruttamento, ma faccia anzi il possibile per attenuarlo. L’uccisione di Alessandro II viene quindi vista con raccapriccio, e in alcuni villaggi si crede addirittura che i terroristi siano stati armati da nobili timorosi che lo zar potesse troppo proteggere i contadini.
La stessa opinione pubblica borghese, pur ostile allo zar, disapprova ora la sua uccisione. Narodnaja volja si trova dunque isolata come non mai proprio dopo aver raggiunto l’obiettivo da anni perseguito con assoluta priorità. A ciò occorre aggiungere che ha perduto tutti i suoi militanti più esperti. Un suo ultimo nucleo, guidato da un giovane studente di grandi doti, Aleksandr Uljanov, fratello maggiore di Vladimir, viene catturato per intero il 1° marzo 1887 nel tentativo di uccidere Alessandro III andato a pregare sulla tomba del padre nel sesto anniversario della sua morte, e i suoi membri sono tutti impiccati. Il crollo di Narodnaja volja, e in genere della prospettiva rivoluzionaria, si spiega con il fatto che la reazione autocratica seguita al terrorismo è riuscita ad impedire che il malcontento contadino si dirigesse contro lo Stato.
Abbiamo già accennato come dopo il 1880 si fosse rafforzata tra i contadini l’assurda immagine di uno zar protettore del popolo contro la nobiltà, alimentata da una propaganda menzognera e dagli insegnamenti impartiti nelle scuole elementari di campagna, che Alessandro II ha messo poco prima di morire nelle mani del clero, abolendo la scuola elementare di Stato con maestri laici. Ma la semplice propaganda non sarebbe certo bastata per rafforzare un’immagine idealizzata dello zar nella mente dei contadini se essi non avessero visto soddisfatte, sia pure in maniera parziale, distorta ed imbarbarente, alcune loro esigenze materiali.
Una di tali esigenze è quella di liberarsi dall’usura. Poiché l’usura è di solito praticata, nelle campagne russe dell’epoca, da trafficanti ebrei, il governo zarista ha l’abilità di scaricare su di loro tutto il malcontento contadino. Si sviluppa così, in vasti strati del mondo contadino russo e per influenza diretta dei funzionari dello Stato, un atteggiamento ideologico ed emotivo di antisemitismo che ha le sue più barbariche manifestazioni, nel 1881 e nel 1882, nei primi pogrom. Il pogrom antisemitico, nella sua forma moderna e nel suo stesso nome (che in lingua russa significa esattamente “azione violenta di una folla eccitata“) nasce proprio nella Russia di questi anni. Si tratta, cioè, di una folla che si raduna per invadere borghi, botteghe e dimore private di ebrei, rubando e distruggendo beni, dando alle fiamme o rovinando edifici, tormentando, storpiando e violentando, e spesso uccidendo, persone.
Suggerendo e incoraggiando (anche con bande organizzate) tali azioni, il governo zarista raggiunge molteplici obiettivi. Si libera di una borghesia affaristica che, con l’autonomia dei suoi comportamenti, intralcia la piena reazione autocratica seguita al terrorismo dei narodniki. Libera inoltre le comunità di villaggio da pratiche di usura – dalle quali essenzialmente è nato l’odio contadino contro la borghesia ebraica – alleggerendo così, sia pure lievemente, la loro miseria, in modo da rendere più tollerabile lo sfruttamento feudale della nobiltà e dello Stato. Trasforma poi le comunità ebraiche, in una certa misura effettivamente responsabili di forme di sfruttamento economico dei contadini, una misura minima però, rispetto a quelle della nobiltà, del clero e dello Stato stesso, in veri e propri capri espiatori su cui viene scaricato tutto il malcontento contadino.
Se però il regime zarista cessa di temere i contadini dipende non solo dal suo successo nell’alimentare l’antisemitismo, ma da alcuni provvedimenti, sia pure di portata limitata, presi a loro favore dal ministro delle finanze Nikolaj Bunge, il quale fa riscuotere le imposte gravanti sui contadini non più alla polizia, che ha sempre svolto tale mansione con estrema brutalità, ma a speciali ispettori incaricati di essere concilianti, e fonda una Banca agricola con il compito di fornire ai contadini stessi prestiti a tassi di interesse non usurari. Infine l’ostilità dei contadini verso i grandi proprietari terrieri viene indirizzata dal governo zarista quando non è in grado di controllarla in altra maniera, contro i ceti proprietari delle nazionalità non russe che vivono nell’Impero, in modo da risparmiare la nobiltà ed il clero russi.
Si spiega così la cosiddetta “politica di russificazione integrale“, basata sul principio “un solo sovrano, una sola fede, una sola legge e una sola lingua“, che viene perseguita da Alessandro III negli anni Ottanta, parallelamente all’incoraggiamento dato all’antisemitismo, e che comporta persecuzioni di vario genere contro Ucraini, Estoni, Lettoni, Lituani e Turchi viventi nell’Impero, dei quali si tende a cancellare non solo l’autonomia legislativa ed amministrativa, ma anche le specificità culturali e la stessa lingua materna.
4.3 Dal populismo al marxismo
La capacità della reazione autocratica, negli anni Ottanta, di soffocare le tendenze rivoluzionarie manifestatesi in Russia nel decennio precedente, provoca una grossa emigrazione di intellettuali verso i paesi liberali dell’Europa occidentale, e fa emergere tra loro nuove concezioni. Raggiunge così una grande importanza la figura di Georgij Plechanov – andato esule a Ginevra subito dopo la rottura con i narodniki – il cui saggio Socialismo e lotta politica (1883) influenza un’intera generazione di esuli russi. In questo suo scritto Plechanov, diventato avversario irriducibile dei narodniki di ogni tendenza, denuncia come assurda utopia l’idea che la Russia possa, saltando la fase capitalistica dello sviluppo storico, approdare direttamente al comunismo dal feudalesimo, attraverso lo sviluppo progressivo delle sue comunità di villaggio.
Una tale idea, secondo Plechanov, non avendo alcuna efficacia pratica, finisce involontariamente per rafforzare il dispotismo autocratico che regge la società feudale russa, e che è di gran lunga peggiore di qualsiasi immaginabile genere di regime che abbia le basi in un’economia capitalistica. “Il capitalismo fa del male, ma il dispotismo autocratico ne fa enormemente di più. Il capitalismo sviluppa l’egoismo nell’uomo, ma il dispotismo autocratico lo trasforma in una bestia da soma. Il capitalismo allunga le sue mani interessate sulla letteratura e sulla scienza, ma il dispotismo autocratico uccide la letteratura e la scienza“.
Il capitalismo rappresenta, per Plechanov, l’unica strada possibile di modernizzazione e di incivilimento della Russia, e il suo avvento, attraverso una rivoluzione che abbatta il dispotismo autocratico, è per lui nell’interesse stesso delle classi lavoratrici russe, che entro le istituzioni capitalistiche potranno per la prima volta organizzarsi in maniera moderna e preparare, per un lontano futuro, una nuova rivoluzione, che solo allora potrà avere un carattere socialista. Allo scopo di giustificare l’ineluttabilità dell’avvento del capitalismo dopo il feudalesimo, in base ad una legge di successione delle fasi di sviluppo storico-sociale non modificabile dall’intervento della volontà umana, Plechanov aderisce al marxismo, divulgandone con tale forza persuasiva quelli che crede esserne i postulati fondamentali, che un comune giudizio fa di lui l’uomo che ha introdotto il marxismo in Russia.
Questo giudizio è sostanzialmente esatto purché sia chiaro che il marxismo di Plechanov non corrisponde affatto all’autentica teoria scientifica di Marx, ma ne costituisce quella medesima deformazione ideologica in chiave positivistica che negli stessi anni – cioè subito dopo la morte di Marx, avvenuta a Londra nel 1883 – che si afferma, anche nell’Europa occidentale. Mentre però nell’Europa occidentale, questo marxismo ideologico è espressione di un moderno proletariato di fabbrica che si organizza autonomamente per difendere i propri interessi entro un sistema capitalistico di cui accetta ormai le regole fondamentali, in Russia è espressione di un ceto intellettuale che spera ormai di abbattere il dispotismo autocratico attraverso l’avvento del capitalismo, ma che non è in grado di inquadrare questa sua speranza in un contesto ideologico liberal-borghese, per la mancanza in Russia di una robusta ed autonoma classe borghese.
La borghesia russa continua ad essere schiacciata dal progredire della reazione autocratica. Nel 1885 viene smantellata la riforma giudiziaria del 1864, con l’abolizione delle giurie popolari, del libero dibattimento processuale e dell’indipendenza ed inamovibilità dei giudici. Nel 1886 sono riformati in senso reazionario i programmi di insegnamento delle scuole superiori, limitando le materie di studio alla lingua russa, alla teologia e alle lingue antiche (latino e greco), e sopprimendo l’insegnamento delle scienze naturali, della storia europea e della letteratura anche russa, con la giustificazione che “potrebbero dar luogo a considerazioni liberali“.
Nel 1887 viene vietato ufficialmente ai figli di genitori di modesta condizione sociale di accedere alle scuole superiori. Nel 1888 vengono stabilite umilianti ingerenze del potere governativo nella vita e nell’insegnamento stesso delle università. Nel 1889 viene abolita anche la pubblicità dei processi. Nel 1890, infine, il governo dello zar assesta il colpo definitivo al sia pur scarso potere che la borghesia ha finora avuto negli zemstvo, e attraverso il quale si è resa popolare, in quell’anno, per le iniziative prese contro l’infuriare di una grave carestia: viene modificato lo statuto degli zemstvo in modo che la nobiltà vi abbia la maggioranza assoluta e che i rappresentanti della borghesia siano eletti non dalla borghesia stessa ma dai governatori delle province.
Nel 1886, si dimette il ministro delle Finanze Bunge, perché il governo zarista non vuole adottare altri provvedimenti a favore dei contadini da lui richiesti e il suo posto è preso da Ivan Vysnegradskij. Questi, non avendo più da temere rivolte nelle campagne ormai soggiogate e imbarbarite, aumenta spietatamente la pressione fiscale sui contadini, in modo che essi, per trovare il denaro con cui pagare le tasse ed evitare di essere incarcerati, sono costretti a vendere il loro grano, anche a costo di patire la fame. Questo grano, súbito esportato all’estero, fa entrare ogni anno in Russia grosse quantità di moneta straniera. La Banca di Stato russa può così accrescere enormemente la sua riserva aurea (tutte le monete allora usate negli scambi internazionali erano d’oro o convertibili in oro), tanto che il rublo diventa una moneta solidissima. Vysnegradskij deve però dimettersi nel 1890, a causa della spaventosa carestia provocata dalla sua politica. Questa politica viene sostanzialmente perseguita anche dal suo successore Sergej Witte, che promuove anche costruzioni ferroviarie adatte a collegare i maggiori centri portuali con le aree interne a maggiore sviluppo demografico ed economico.
La solidità dei rublo, i collegamenti ferroviari sicuri, le condizioni favore che Witte fa agli investimenti stranieri, e la possibilità di impiegare mano d’opera locale priva di qualsiasi protezione legislativa ed alla quale possono essere imposti orari lavorativi pesantissimi e salari bassissimi non più possibili ormai nell’Europa occidentale, spingono molti capitalisti stranieri – inglesi, francesi e soprattutto belgi – ad impiantare moderne industrie in Russia, e attraggono nel paese grossi prestiti bancari francesi, che vanno a finanziare lo sviluppo industriale.
Così, nell’ultimo decennio del secolo alcune circoscritte zone della Russia – l’area di Pietroburgo, quella del Don, alcune parti dell’Ucraina – conoscono un processo accelerato di industrializzazione capitalistica. Si tratta però di un capitalismo dipendente dall’estero, tanto che è stato calcolato che ben i 2/3 dei capitali investiti in Russia all’epoca della sua industrializzazione siano stati capitali stranieri. Il restante terzo, il capitale nazionale – i cui investimenti industriali tendono a concentrarsi nell’area di Mosca e in quella degli Urali è poi in larga misura fornito dallo Stato russo ad affaristi che godono dei suoi favori. L’industrializzazione capitalistica non genera, quindi, in Russia, una consistente borghesia nazionale.
4.4 La rivoluzione del 1905
In Russia, la rapida industrializzazione di alcune regioni nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, crea nuove contraddizioni sociali destinate ben presto a mettere in crisi l’autocrazia zarista. Una prima contraddizione è data dall’esistenza stessa, per la prima volta in Russia, di un proletariato di fabbrica. Tale proletariato è trattato con una brutalità che non ha più riscontro in alcun altro paese industrializzato: orari di lavoro di 15 ore giornaliere senza alcun giorno di riposo, salari di fame, multe e persino frustate per ogni infrazione, sfruttamento brutale della mano d’opera femminile e minorile, nessuna assistenza per gli anziani e gli infortunati. L’autocrazia zarista, da un lato, non può evitare, permanendo questa situazione, futuri scoppi insurrezionali, ma, da un altro lato, non può migliorarla oltre un certo limite senza provocare un crollo economico, perché la maggior parte dell’industria russa dipende da capitali stranieri, che non avrebbero più ragione di rimanere in un paese ancora arretrato come la Russia se perdessero il decisivo vantaggio di poter sfruttare la mano d’opera locale molto più di quanto non sia possibile nei paesi avanzati, dove le classi lavoratrici sono tutelate da leggi a carattere sociale e difesi, da libere organizzazioni sindacali.
Perciò lo Stato zarista, dopo aver fatto ridurre la giornata lavorativa ad 11 ore, in séguito a violenti scioperi divampati a Pietroburgo nel 1898, e dopo aver lasciato costituire, a Sergej Zubatov, capo dell’Ochrana, società operaie di mutuo soccorso con vaghi compiti di contrattazione sindacale (ma senza diritto di sciopero e sotto la sorveglianza dei poliziotti che ne hanno la guida), non intende concedere altro. E la classe operaia russa rimane, naturalmente, un elemento di contraddizione nella società. Un’altra contraddizione è data dall’emergere, con l’industria, anche di una borghesia capitalistica nazionale che, per quanto poco consistente e in larga misura dipendente dallo Stato zarista, si sente tuttavia intralciata dai rapporti feudali, da una burocrazia onnipotente ed antiquata, e dalla mancanza di ogni libertà di espressione che esso perpetua, ed è quindi spinta ad avvalersi del potere che il denaro le conferisce per opporsi al regime autocratico.
Queste contraddizioni si manifestano per la prima volta con particolare asprezza nel 1901, quando nelle principali città russe si susseguono grandi dimostrazioni anti-zariste, di cui gli studenti costituiscono l’elemento trascinante, e poi nel 1902, quando divampano, invece, agitazioni contadine contro l’oppressione feudale nelle campagne, e nelle città, scioperi spontanei di operai che rivendicano le 9 ore di lavoro, il riposo festivo, e l’assistenza ai vecchi ed agli invalidi. Le sanguinose repressioni compiute dalle forze di polizia per ordine del crudele ministro dell’Interno, Vjaceslav Pleve, sembrano spegnere senza alcuna conseguenza le fiammate di protesta del 1901-1902. Ma nel 1904 è la borghesia russa ad entrare in agitazione, per i costi della guerra contro il Giappone, nella quale la Russia si trova coinvolta per interesse esclusivo di una ristretta cerchia di grandi aristocratici, i quali spingono lo zar ad interferire nella sfera di influenza giapponese in Corea al solo scopo di accrescere le proprie rendite, declinanti a causa dell’arretratezza feudale dell’agricoltura russa, con le ricchezze dell’economia forestale coreana.
Man mano che le sconfitte militari subite dalla Russia rivelano l’inefficienza e la corruzione imperanti nella burocrazia e nelle forze armate zariste, la borghesia promuove, negli zemstvo una crescente agitazione contro l’autocrazia, fino ad organizzare un congresso nazionale dei rappresentanti degli stessi zemstvo, che, riunitosi nel novembre del 1904, rivendica le libertà civili e l’elezione di un’assemblea rappresentativa del popolo dotata di poteri legislativi. Lo zar, indebolito dalla sconfitta dei suoi eserciti contro il Giappone, cerca di tenere tranquilla la borghesia nominando ministro dell’Interno (dopo la morte di Pleve, ucciso in un attentato), il principe Mirskij, in fama di liberale.
Il 9 gennaio 1905 decine di migliaia di operai di Pietroburgo disertano il lavoro per recarsi in corteo fino al Palazzo d’inverno, residenza dello zar e per presentare al sovrano una petizione richiedente la fine della guerra, l’abolizione delle imposte indirette, l’introduzione delle libertà civili, e la giornata lavorativa di 9 ore con riposo festivo per gli operai. Non si tratta di un gesto di ribellione, e neppure di una manifestazione spontanea, essendo stata organizzata da un giovane prete ortodosso, Georgij Gapon, posto da Zubatov alla guida delle società operaie di Pietroburgo, il quale pensa di agire nell’interesse dell’autocrazia zarista.
In quell’inverno 1904-’05, infatti, la continuazione della guerra contro il Giappone, da un lato, si è rivelata, dopo la nuova sconfitta russa di Porth Arthur, del tutto inutile, e da un altro lato ha provocato un aumento del 40% del prezzo dei generi alimentari, che, senza una corrispondente riduzione delle imposte che vi gravano, ha portato letteralmente alla fame il proletariato, non permettendogli di sopportare oltre l’enorme fatica del suo lavoro, e aprendolo perciò all’influenza di agitatori rivoluzionari. In questo contesto, il pope Gapon organizza la manifestazione operaia davanti al Palazzo d’inverno al triplice scopo di evitare che lui e gli altri fiduciari della polizia perdano, rimanendo passivi di fronte al fortissimo malcontento operaio, ogni influenza sugli operai stessi, di incanalare le loro esigenze più immediate ed indilazionabili in richieste tali da non mettere in questione il sistema politico vigente, e, infine, di accrescere il prestigio dello zar, dal quale sarebbe dovuta venire una risposta paternalisticamente benevola alla petizione presentatagli. Succede, invece, che Nicola II non solo rifiuta di ricevere la petizione, ma nomina governatore generale di Pietroburgo, con pieni poteri, il generale Trepov, già comandante di polizia noto per le sue crudeltà, il quale, non appena la folla dei manifestanti si è ammassata davanti al Palazzo d’inverno, in atteggiamento supplice, agitando immagini di santi e cantando cori liturgici, dà ordine ai suoi soldati di sparare per uccidere, e lascia così sul selciato, prima che la gente terrorizzata faccia in tempo a fuggire, non meno di 1000 morti e di 2000 feriti.
La “domenica di sangue“ - con tale nome è passata alla storia la tragica giornata del 9 gennaio – distrugge d’un colpo le ingenue speranze, fino ad allora nutrite dal popolo russo sulla paterna sollecitudine dello zar, e segna l’inizio di una serie di scioperi che nei mesi successivi punteggiano la Russia ora nell’uno ora nell’altro dei suoi centri industriali. Lo zar, licenziato il Mirskij, chiama ad affrontare la situazione, come ministro dell’Interno, il conservatore Bulygin, il quale, da un lato, affida a Trepov spietate repressioni, e dall’altro cerca di attrarre dalla sua parte la borghesia con discorsi accattivanti e concessioni apparenti. La politica zarista, in realtà, è in questo momento sostenuta soltanto dall’aristocrazia feudale, dalla burocrazia e dai comandi dell’esercito e delle forze di polizia, cioè dal tradizionale blocco di potere reazionario. La borghesia, cui la guerra contro il Giappone ha rivelato fino a che punto i suoi interessi siano posposti dallo Stato zarista a quelli dell’aristocrazia, vuole invece sostituire l’autocrazia con una monarchia costituzionale, che le consenta di far valere i suoi interessi attraverso un organo rappresentativo dotato di poteri legislativi. Ciò spiega come gli scioperi operai contro l’autocrazia zarista trovino un incoraggiamento da parte dei loro stessi padroni capitalisti, che pagano loro le giornate di sciopero.
Nell’estate del 1905 gli scioperi operai diventano più frequenti. L’esito sempre più disastroso della guerra contro il Giappone porta uno spirito di rivolta tra le stesse forze armate, provocando diversi ammutinamenti, tra cui è famoso quello, nel Mar Nero, della corazzata Potemkin (immortalato dal celebre film, del 1925, del regista russo Ejsenstejn). Infine la rivolta dilaga anche tra i contadini, esasperati dalla mancanza di terre di cui vivere (le migliori tra le terre un tempo appartenute ai contadini sono state loro tolte dall’aristocrazia feudale) e dall’anacronistico tributo cui sono ancora tenuti per essere stati liberati dalla servitù della gleba. La pace con il Giappone, sottoscritta in agosto, non serve dunque a riportare la calma all’interno.
Nell’ottobre 1905 uno sciopero iniziato dai tipografi di Mosca per chiedere salari più alti si estende rapidamente, in un primo momento, e sempre per motivi salariali, dapprima ai ferrovieri della città e quindi di tutto il paese, e in un secondo momento, arricchito da esplicite rivendicazioni politiche, agli operai di ben 39 centri urbani della Russia. La lotta operaia si concentra su tre grandi obiettivi economici (9 ore di lavoro, riposo festivo, abolizione delle imposte indirette) e tre grandi obiettivi politici (amnistia per tutti i detenuti politici, introduzione di tutte le libertà civili, elezione a suffragio universale di un’assemblea costituente incaricata di dare alla Russia un nuovo regime politico). In questa situazione l’autocrazia zarista non è in grado di sconfiggere da sola la sfida rivoluzionaria portata contro di essa, e ciò per due ragioni. Una prima ragione è che questa volta la protesta operaia non si presenta, come nei mesi precedenti, spontanea e indotta solo dalla fame e dalle fatiche. Al contrario, nei centri nevralgici del paese essa si manifesta in forme organizzate e a carattere politico. Gli operai in sciopero eleggono infatti, in alcune zone, propri rappresentanti, sempre revocabili e sostituibili con altri, che si riuniscono in consigli, in russo chiamati soviet, incaricati di organizzare e guidare le lotte. Emerge, su tutti, il soviet della capitale Pietroburgo, composto da circa 200 delegati in rappresentanza di circa 400 mila operai della città, che da comitato di sciopero si trasforma, nel giro di pochi giorni, in un vero e proprio centro di potere alternativo a quello dello Stato, fino al punto che la maggior parte della popolazione della capitale non esegue più gli ordini delle pubbliche autorità non approvati da esso. Una seconda ragione che impedisce all’autocrazia zarista di reagire contro gli operai è che le sue forze di repressione sono impegnate nelle campagne contro le rivolte contadine.
Sollecitato energicamente dal ministro delle Finanze Witte, Nicola II cerca allora di venire a capo della situazione con la promulgazione, il 17 ottobre, del cosiddetto Manifesto di Ottobre, che contiene la promessa dell’introduzione delle libertà civili e della convocazione di una Duma, ovverosia di un’assemblea elettiva dotata di alcune competenze legislative. Si tratta, però, di una concessione più apparente che reale, non solo perché elude le questioni dell’amnistia e della Costituente, e perché non attribuisce l’interezza del potere legislativo alla Duma, né dà alcuna garanzia che essa sia eletta con voto segreto e di eguale peso per tutti i sudditi, ma anche perché è accompagnata da scelte di uomini che rivelano le vere intenzioni del sovrano. Infatti Trepov non solo non viene destituito, ma viene messo a capo di forze più consistenti, e il ministero dell’Interno viene attribuito al famigerato reazionario Durnovo, già stretto collaboratore di Pleve. Il nuovo ministro e Trepov finanziano e proteggono i Centoneri, bande di criminali inizialmente assoldate dalla nobiltà reazionaria per aggredire ebrei, intellettuali e lavoratori, e moltiplicano gli arresti. Gli operai di Pietroburgo rispondono perciò al Manifesto di Ottobre con una canzone che dice: “Lo zar nel suo terrore emanò un manifesto / con cui diede ai morti libertà e ai vivi l’arresto“, e il loro soviet dà l’indicazione di continuare la lotta.
Ma la lotta operaia che ha ridotto all’impotenza l’aristocrazia zarista ha spaventato non soltanto lo zar ma anche tutta la ricca borghesia, non disposta a tollerare operai ribelli, capaci di autoorganizzazione e persino di esercitare un proprio potere. La ricca borghesia, perciò, rinuncia a proseguire la sua lotta contro il regime zarista, che vuole ora sufficientemente forte per eliminare il nascente potere operaio, ed è quindi costretta a prendere per buono il Manifesto di Ottobre.
La diserzione della borghesia e la repressione cruenta delle rivolte contadine lasciano la classe operaia sola di fronte all’autocrazia zarista e divisa al suo interno, perché una parte di essa, ancora sotto l’influenza della borghesia, ottenuti modesti aumenti salariali, desiste dallo sciopero, pochi giorni dopo il Manifesto di Ottobre. Nei giorni successivi, perciò, anche gli altri scioperanti sono costretti a tornare al lavoro. Il soviet di Pietroburgo tuttavia non si scioglie, e guida altre lotte, finché a dicembre proclama uno sciopero fiscale e finanziario, cioè invita il popolo russo a non pagare più tasse e a ritirare tutti i depositi dalle banche finché lo zar non abbia almeno liberato i detenuti politici. Ma la polizia zarista riesce a sorprendere il Soviet di Pietroburgo in riunione e ad arrestarne tutti i membri. La notizia scatena scioperi operai in 13 città della Russia, tra le quali non c’è Pietroburgo, a riprova di quanto la capacità di lotta degli operai russi dipenda dalle doti di coraggio, di iniziativa, di organizzazione e di guida dei loro capi riuniti nei soviet.
A Mosca lo sciopero assume dimensioni imponenti, tanto che il regime zarista fa concentrare in quella città la maggior parte delle sue forze di repressione. Gli operai moscoviti, allora, si chiudono nei loro quartieri, erigendovi barricate e prelevando tutte le armi disponibili presso gli armaioli. I quartieri operai di Mosca, così difesi, cominciano, di fatto, ad essere governati dal soviet costituitosi nella città. L’inevitabile scontro armato vede i quartieri operai moscoviti sottoposti ad un violento cannoneggiamento da parte dell’esercito zarista, con l’approvazione incondizionata non soltanto della nobiltà e della burocrazia ma anche della borghesia, e costretti a soccombere dopo pochi giorni di scontri sanguinosi, sempre nel dicembre 1905.
4.5 La reazione di Stolypin
Con la repressione all’insurrezione di dicembre a Mosca, la rivoluzione del 1905 è sconfitta e trionfa, su di essa, l’autocrazia zarista. Sin dal febbraio 1906 lo zar conferma il mantenimento di tutte le istituzioni feudali della Russia. Consente anche l’elezione di una Duma nell’aprile 1906, ma con una competenza legislativa ridotta al minimo e con membri scelti da elettori suddivisi in sei classi, chiamate curie, in maniera tale che il voto dei nobili e degli alti prelati, appartenenti alle prime due curie, valga quanto 4 voti dei borghesi, distribuiti in una terza e in una quarta curia, a 15 voti dei contadini, appartenenti alla quinta curia, e a 50 voti degli operai, appartenenti alla sesta curia. Inoltre, poiché persino una Duma eletta in questo modo si rivela ostile all’autocrazia, egli ne decreta lo scioglimento nel luglio 1906. Una seconda Duma, eletta nel gennaio successivo, viene sciolta per lo stesso motivo, ma questa volta con un colpo di Stato, compiuto il 3 giugno 1907 da Petr Stolypin, un reazionario che lo zar ha nominato, nell’anno precedente, prima ministro dell’Interno e poi presidente di tutti i ministri, carica conferita in precedenza al Witte. Stolypin, con il consenso dello zar, fa arrestare, sotto l’accusa di tradimento, i deputati di opposizione, caccia via dalle scuole gli insegnanti non reazionari, dà pieni poteri alle forze di polizia, istituisce tribunali militari incaricati di colpire la dissidenza politica senza più la minima garanzia per gli imputati. Una terza Duma si rivela finalmente docile all’autocrazia grazie ad un cambiamento del sistema elettorale, che fa equivalere un voto dei nobili e degli alti prelati a 75 voti borghesi, a 300 voti contadini e 500 voti operai. La Russia cade in un clima di cupo terrore.
Stolypin è però un uomo non soltanto feroce, ma anche di lucida intelligenza. Egli ha infatti compreso che il regime zarista non avrebbe potuto sopravvivere a lungo se all’inevitabile odio degli operai si fosse aggiunta l’ostilità generalizzata delle campagne. Perciò prima ancora del colpo di Stato, e cioè nell’autunno 1906, ha imposto una riforma agraria che, soppressi i tributi di riscatto dovuti dai contadini, sciolto il vecchio mir, e suddivise le sue terre, in piena proprietà privata e in proporzione degli animali e degli attrezzi posseduti, tra i contadini suoi componenti, ha fatto emergere nelle campagne uno strato di contadini ricchi, in russo kulàki (così sono detti quelli che hanno più terra di quanta ne possono coltivare i membri delle loro famiglie, tanto da dover necessariamente assumere braccianti salariati), corrispondente al 15% della popolazione rurale, e uno strato di contadini medi (così sono detti quelli che hanno una terra, coltivabile dai membri delle loro famiglie, sufficiente per garantire sia il consumo delle famiglie stesse sia la vendita di modeste eccedenze sul mercato a differenza dei contadini poveri (che non hanno eccedenze e sono costretti ad andare anche a lavorare come braccianti salariati nelle terre altrui), corrispondente al 20% della popolazione rurale. Il suo obiettivo politico è quello di rendere sia i contadini ricchi che quelli medi alleati dello zarismo.
Nell’autunno 1911, Stolypin cade vittima di un attentato. Contemporaneamente riprendono le agitazioni operaie e particolarmente vaste e compatte si rivelano quelle degli operai degli stabilimenti auriferi lungo il fiume Lena, nella Siberia orientale, di proprietà inglese. Il loro sciopero sarà stroncato soltanto dall’intervento armato dell’esercito, che uccide quasi 500 scioperanti. La reazione di Stolypin non è dunque riuscita, a soffocare le tensioni sociali.
4.6 I partiti politici: metodi e finalità della rivoluzione russa
Il riemergere di tensioni rivoluzionarie nella società russa ripropone, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il problema, già dibattuto due decenni prima, con l’intervento dello stesso vecchio Marx, delle forze sociali, dei metodi di lotta e degli scopi ultimi di una rivoluzione in un paese economicamente e politicamente arretrato come la Russia. I nuclei politicamente attivi della ricca borghesia russa e degli intellettuali ad essa legati sono convinti che l’arretratezza della Russia al confronto del resto d’Europa dipenda dalla sopravvivenza, in essa, di istituzioni economico-sociali di stampo feudale e di istituzioni politiche espressione del tradizionale assolutismo autocratico. Ciò spinge i maggiori esponenti politici della ricca borghesia, quali Miljukov, noto avvocato, Muromtsev, docente all’Università di Mosca, Terescenko, industriale dello zucchero, a fondare un partito costituzionale-democratico, chiamato, dalle prime sillabe delle due parole russe, partito cadetto (agosto 1905), diviso al suo interno in un’ala destra, più favorevole al compromesso con la monarchia, guidata da Miljukov, e in un’ala sinistra, più decisa nel sostenere l’introduzione del suffragio universale e del governo parlamentare, guidata da Terescenko.
L’eredità ideologica dei narodniki è invece ripresa dal partito socialista-rivoluzionario, fondato nel giugno 1902 per iniziativa di un intellettuale russo, Victor Cernov. Si tratta di un partito che esprime la mentalità e gli interessi della piccola borghesia rurale, e che quindi è irriducibilmente ostile allo sfruttamento feudale delle campagne e all’autocrazia zarista che lo impone. Contro l’autocrazia zarista i socialrivoluzionari non esitano ad usare metodi terroristici di lotta, tanto che in quegli anni molti esponenti del regime zarista (da Pleve nel 1904 a Stolypin nel 1911) cadono vittime dei loro attentati. Essi hanno perciò bisogno di un’ideologia che giustifichi con un grande ideale sociale le loro azioni sanguinose e che dia loro la forza e la compattezza necessarie per affrontare la clandestinità e le persecuzioni poliziesche. Di qui lo scopo che essi attribuiscono alla rivoluzione russa, riallacciandosi appunto alla tradizione ideologica dei narodniki, di instaurare un perfetto comunismo, senza neppure bisogno di sopportare i costi economici dell’industrializzazione e di passare attraverso gli squilibri e le ingiustizie del capitalismo occidentale, ma invece in armonia con le tradizioni comunitarie slave originarie del paese, tramite lo sviluppo dei mir ed il trasferimento alla loro gestione di tutta la terra coltivabile.
Ma questa ideologia non corrisponde più, a differenza dell’epoca dei narodniki, alla sostanza delle aspirazioni diffuse nel mondo rurale russo, dove il comunitarismo e l’egualitarismo tradizionali si sono molto indeboliti all’interno dei mir, e maschera perciò involontariamente la tendenza effettiva di un’emergente borghesia contadina a desiderare la espropriazione delle terre dell’aristocrazia feudale per ottenerle a titolo di proprietà privata. Quando poi, in séguito alla riforma agraria di Stolypin, si forma nelle campagne russe uno strato di kulaki, emergono anche, tra i socialrivoluzionari, uomini sempre più orientati ad esprimere politicamente gli interessi soltanto dei più ricchi tra i contadini, e quelli, ad essi omogenei, di una borghesia urbana di piccoli industriali che stanno trovando nello strato superiore del mondo contadino un promettente mercato di sbocco. Si costituisce così, nel 1912, in occasione delle elezioni per la quarta Duma, il partito laburista, derivato dalla fusione del partito socialista popolare (nato da una scissione dell’ala destra del partito socialrivoluzionario) con il partito socialista nazionale (di sinistra borghese e guidato da Aleksandr Kerenskij).
Il partito socialdemocratico russo, affiliato alla Seconda Internazionale, nasce, nel 1898, da un congresso clandestino a Minsk da nemici dell’autocrazia zarista provenienti, a differenza dei socialrivoluzionari, esclusivamente da ambienti urbani, ed influenzati dalle idee della socialdemocrazia europea e soprattutto da quelle di Plechanov. Tale partito si caratterizza perciò per la convinzione che il socialismo e, a maggior ragione, il comunismo, non possano scaturire che dalle contraddizioni di un capitalismo pienamente sviluppato e dalla forza di un proletariato ben organizzato nell’àmbito di un sistema politico democratico. Di conseguenza, data l’arretratezza della Russia, l’unica rivoluzione che essa possa conoscere è, secondo i socialdemocratici, una rivoluzione democratica nei suoi esiti politici, borghese in quelli sociali, e capitalistica in quelli economici, o, come essi dicono sinteticamente, una rivoluzione democratico-borghese.
Parte seconda
Premessa
Prima di affrontare l’evolversi dei fatti in Russia negli anni che vanno dal 1914 al 1918, sarà opportuno riprendere almeno gli elementi di fondo con i quali si concludeva la prima parte. In sostanza, questa si chiudeva con alcune considerazioni sul problema delle forze sociali, dei metodi di lotta e degli scopi ultimi di una rivoluzione in un paese economicamente e politicamente arretrato come la Russia. A questo proposito si metteva in evidenza come i nuclei politicamente attivi della ricca borghesia russa e degli intellettuali ad essa legati, convinti che l’arretratezza della Russia, rispetto al resto d’Europa, dipendesse dalla sopravvivenza di istituzioni economico-sociali di stampo feudale e di istituzioni politiche espressione dell’assolutismo autocratico, avessero fondato nell’agosto del 1905 un partito costituzionale-democratico, il partito cadetto, diviso al suo interno in un’ala destra, più favorevole al compromesso con la monarchia, e in un’ala sinistra, più decisa nel sostenere l’introduzione del suffragio universale e del governo parlamentare.
Venivano poi analizzate le altre forze politiche, chiarendo come l’eredità ideologica dei narodniki fosse stata ripresa dal partito socialista-rivoluzionario, espressione della mentalità e degli interessi della piccola borghesia rurale, decisamente ostile allo sfruttamento feudale delle campagne e all’autocrazia zarista. Contro tale autocrazia, i socialrivoluzionari avevano anche usato metodi terroristici di lotta (sia Pleve nel 1904 che Stolypin nel 1911 erano caduti vittime dei loro attentati). Lo scopo che essi attribuivano alla rivoluzione, collegandosi appunto alla tradizione ideologica dei narodniki, era quello di instaurare un perfetto comunismo, senza passaggi intermedi, in armonia con le tradizioni comunitarie del paese, tramite lo sviluppo dei mir ed il passaggio sotto la loro gestione di tutta la terra coltivabile.
Ma questa ideologia non corrispondeva più, a differenza che all’epoca dei narodniki, alla sostanza delle aspirazioni diffuse nel mondo rurale russo, dove il comunitarismo e l’egualitarismo tradizionali si erano molto indeboliti all’interno dei mir, ed era in realtà espressione di un’emergente borghesia contadina che puntava all’espropriazione delle terre dell’aristocrazia feudale, per ottenerle a titolo di proprietà privata. La nascita del partito laburista, nel 1912, in occasione delle elezioni per la quarta Duma, derivato dalla fusione del partito socialista popolare (nato da una scissione dell’ala destra del partito socialrivoluzionario) con il partito socialista nazionale (di sinistra borghese e guidato da Aleksandr Kerenskij), rappresentava proprio la naturale conseguenza di una situazione così modificata.
Infine si faceva riferimento alla nascita, nel 1898, del partito socialdemocratico russo (affiliato alla Seconda Internazionale), da un congresso clandestino a Minsk, ad opera di oppositori dell’autocrazia zarista provenienti esclusivamente da ambienti urbani, ed influenzati dalle idee della socialdemocrazia europea e soprattutto da quelle di Plechanov. Tale partito si caratterizzava perciò per la convinzione che il socialismo e, a maggior ragione, il comunismo, non potessero scaturire che dalle contraddizioni di un capitalismo pienamente sviluppato e dalla forza di un proletariato ben organizzato nell’àmbito di un sistema politico democratico. Di conseguenza, data l’arretratezza della Russia, l’unica rivoluzione che essa potesse conoscere era, secondo i socialdemocratici, una rivoluzione democratica nei suoi esiti politici, borghese in quelli sociali, e capitalistica in quelli economici, una rivoluzione democratico-borghese.
Ed è proprio a partire dal ruolo che Lenin svolge nel partito socialdemocratico e dall’evoluzione di questo partito nel quadro della rivoluzione del 1905, durante la Grande guerra e poi nella rivoluzione del 1917, che le due parti trovano una loro organica connessione.
1. Lenin, teorico della rivoluzione
Le idee di Lenin sulla rivoluzione trovano la loro prima esposizione sistematica nel saggio Che fare? del marzo 1902. Un saggio molto famoso, cui Lenin dedica quasi un anno di lavoro. Ma la fama di questo saggio è soprattutto legata all’idea che esso contenga una teoria del partito rivoluzionario, come organizzazione disciplinata e centralizzata di professionisti della rivoluzione, la cui volontà politica è espressa da un nucleo dirigente omogeneo al di fuori di qualsiasi regola di conduzione democratica. Un’idea che però non corrisponde al contenuto del testo, un’idea sbagliata, in sostanza.
Infatti, l’organizzazione centralizzata del partito e la sua accettazione soltanto di militanti a tempo pieno e molto disciplinati, sono intese come necessità pratiche della lotta politica sotto un regime autocratico, ma non come implicazioni di una teoria generale della rivoluzione, e sono concepite non come finalità valide in sé, ma come strumenti, indispensabili in un certo contesto storico, per la realizzazione di obiettivi di emancipazione umana.
Che il tema del Che fare? non sia l’organizzazione del partito rivoluzionario è dimostrato dal fatto che dall’inizio alla fine del saggio non si trova una sola indicazione specifica riguardante la sua gestione. È ben vero anche che, a partire da qualche decennio dopo la sua uscita, il Che fare? sarà usato per legittimare una forma-partito soffocatrice di ogni libertà espressiva e di ogni ricerca critica, o, al contrario, per denigrare le teorie leniniane come nemiche di ogni democrazia.
Ma questi usi sono stati arbitrari e irrispettosi della verità storica, e fatti da chi non si era dato pena di leggere davvero il saggio di Lenin, o, meglio ancora, intendeva farne comunque un uso strumentale. Leggendo con la dovuta attenzione il Che fare?, ci si rende facilmente conto che il suo tema non è affatto la forma-partito, ma è invece il contenuto-partito: esso indica cioè quali contenuti politici debba avere un partito per essere realmente rivoluzionario, e convalida una certa forma-partito, senza esporla e giustificarla nei particolari, solo in quanto si riempia di quel contenuto e lo pratichi.
1.1 Il Che fare?
Da questo punto di vista il Che fare? contiene tre idee fondamentali.
In primo luogo, la classe operaia, pur essendo l’unica forza sociale concepibile per una trasformazione rivoluzionaria della società, non è in grado di acquisire un’intenzionalità rivoluzionaria né spontaneamente né autonomamente. “La storia di tutti i paesi“, scrive Lenin, “attesta che la classe operaia lasciata a se stessa può elaborare soltanto una coscienza sindacale [...] mentre la dottrina del socialismo sorge da teorie filosofiche, storiche, economiche elaborate dagli intellettuali delle classi possidenti“. Un partito rivoluzionario, dunque, ha un senso soltanto in quanto sia depositario di un sapere sociale di grado superiore rispetto alla coscienza spontanea delle masse lavoratrici, e sia organizzato per portare questo sapere alla classe operaia. Senza un partito rivoluzionario in questo senso, e lasciando che la classe operaia si auto-organizzi seguendo le sue tendenze spontanee, l’organizzazione di classe serve soltanto (e non è poco!) a consentire ai lavoratori di battersi per una ripartizione più favorevole del prodotto sociale all’interno del sistema dato.
In secondo luogo, il partito rivoluzionario della classe operaia adempie al suo compito più importante quando riesce a far esprimere la classe sul piano della generalità sociale, e quindi della dimensione statuale. “La socialdemocrazia“, scrive Lenin, “deve rappresentare la classe operaia non nei suoi rapporti con un determinato gruppo di capitalisti, ma nei suoi rapporti con tutte le classi della società contemporanea, e con lo Stato come forza politica organizzata“. Questa convinzione induce Lenin a respingere con forza ciò che egli chiama l’economicismo, cioè “la tendenza che vuole che gli operai conducano una lotta soltanto economica, e che i loro rappresentanti politici li tutelino sul piano statuale alleati con i liberali“.
Infine, il partito della classe operaia può portare questa classe sul terreno della lotta politica per la conquista dello Stato, e può elevarne la coscienza fino a farla diventare una forza rivoluzionaria, se e soltanto se la abitua a contrastare non già una sola forma di oppressione, quella del padrone capitalista in fabbrica, ma ogni forma di oppressione dell’uomo sull’uomo. “Poiché l’oppressione“, egli scrive, “si esercita sulle più diverse classi della società, e si manifesta nei più diversi campi della vita, economica, civile, privata, familiare, religiosa, scientifica ecc., non è forse evidente che non adempiremmo il nostro compito di sviluppare la coscienza politica degli operai se non ci incaricassimo di organizzare la denuncia politica dell’oppressione in tutti i suoi aspetti?“.
Lenin spiega che il partito rivoluzionario della classe operaia non è veramente tale se non aiuta ed alimenta la lotta per la libertà della cultura a fianco degli studenti e degli intellettuali, la lotta per il riconoscimento dei diritti elementari della persona nell’esercito a fianco dei soldati, la lotta per la libertà di culto a fianco delle minoranze religiose, la lotta per le autonomie nazionali a fianco delle nazioni non russe, e, soprattutto, la lotta contro la concentrazione della terra nelle mani dell’aristocrazia feudale a fianco dei contadini.
Dunque, per Lenin, il compito di un’avanguardia rivoluzionaria consiste soprattutto nel denunciare le oppressioni non contrastate, suscitando così, con la sua denuncia, i soggetti antagonisti. Esemplare perciò quanto è successo quando il governo ha introdotto l’arruolamento forzato nell’esercito, di una parte della popolazione studentesca, superiore al numero prefissato di esentati: il giornale clandestino, l’Iskra, ha avviato una campagna contro questo provvedimento governativo, mostrandone l’ingiusta oppressività, prima che qualsiasi manifestazione studentesca lo avesse contestato, e quando ancora gli studenti cercavano di sottrarsi ciascuno individualmente all’arruolamento. Sarà proprio la campagna di denuncia politica dell’Iskra a spingere gli studenti a costituirsi in un soggetto collettivo di lotta.
1.2 Bolscevichi e menscevichi
Come abbiamo visto parlando della sua vita, Lenin, esule a Ginevra nel 1900, alla fine di quell’anno è riuscito a far uscire, nella città svizzera, assieme ad altri esuli, tra cui Plechanov, Martov e Vera Zasulic, una rivista politica marxista in lingua russa, l’Iskra (La scintilla), introdotta in quasi tutti i centri urbani della Russia da un piccolo ma infaticabile gruppo di militanti che girano come corrieri clandestini in tutto il territorio del paese. Gli iskrovtsi, come sono chiamati gli abbonati all‘Iskra, non sono che qualche migliaio in tutta la Russia, ma arrivano a costituire ben presto una forza non trascurabile, perché la lettura della rivista finisce per fornire al loro odio verso lo zarismo una base comune a tutti, di informazione e di cultura, ed un comune linguaggio e modo di pensare politico, tanto da fare di loro un corpo compatto ed agguerrito di militanti.
Da parte sua, la redazione della rivista viene a disporre di un quadro abbastanza chiaro dei piccoli gruppi di opposizione antizarista di ispirazione marxista sparpagliati per la Russia, e diventa il naturale centro di coordinamento delle loro cospirazioni. Di qui, l’idea del gruppo redazionale dell’Iskra di organizzare un congresso attraverso cui ricostruire il tessuto organizzativo del partito socialdemocratico, praticamente dissoltosi dopo il primo congresso del partito, quello di Minsk del 1898, in séguito all’arresto, pochi mesi dopo tale congresso, di quasi tutti i suoi promotori, scoperti dalla polizia zarista.
Il 2° congresso del partito socialdemocratico russo comincia a Bruxelles, nel luglio 1903, e termina il mese successivo a Londra, dove è stato spostato in séguito alla scoperta dell’esistenza di numerose spie zariste in Belgio. I suoi partecipanti si dividono in due fazioni antagoniste, di cui l’una, che fa capo a Lenin, ottiene la maggioranza e viene perciò detta bolscevíca (dal russo “bolsce“, che vuol dire “di piú“), mentre l’altra, che fa capo a Martov, rimane in minoranza e viene perciò detta menscevíca (dal russo “mensce“, che vuol dire “di meno“). Il motivo della discordia è costituito dai criteri di ammissione al partito, che il congresso è chiamato a definire.
Martov propone infatti di accettare l’iscrizione al partito di chiunque, condividendone le finalità, intenda aderire ad una delle sue organizzazioni, ma Lenin si oppone, sostenendo che in un paese come la Russia, dove manca ogni libertà civile e vige un brutale dispotismo poliziesco, l’adesione ad un partito come quello socialdemocratico ha un senso solo per chi non si limiti a simpatizzare per le sue finalità e a volersene considerare membro, ma sia disposto anche a militare in esso a tempo pieno, e ad eseguire con fermezza e disciplina tutti gli ordini dei suo gruppo dirigente. Questo contrasto assume subito particolare asprezza perché sottintende, anche se i suoi protagonisti non sono, all’inizio, ben coscienti della profondità delle loro divergenze, una diversa concezione del ruolo del partito nella rivoluzione russa.
I menscevichi immaginano, infatti, che il carattere inevitabilmente democratico-borghese della rivoluzione russa implichi che essa debba essere politicamente diretta dai partiti della borghesia, in funzione di interessi esclusivamente borghesi, e che quindi il partito socialdemocratico, in quanto rappresentante della classe operaia, non debba far parte, per non essere costretto dalla natura della rivoluzione a tradire gli interessi della classe operaia stessa, di alcun governo rivoluzionario, e debba piuttosto prepararsi a difendere gli interessi economici degli operai nel contesto borghese capitalistico creato dalla rivoluzione. È chiaro che affidando al partito questo ruolo, non di prima linea né direttivo nella lotta rivoluzionaria, i menscevichi pensino poi ad una sua organizzazione non rigida, sino ad identificarla, in pratica, con le forme associative spontaneamente assunte dal proletariato nel corso delle lotte da esso condotte per il miglioramento delle sue condizioni economiche.
Lenin, invece, si è convinto che in un paese come la Russia, dove la borghesia si è sviluppata tardivamente ed è rimasta una classe debole e dipendente dai pubblici poteri, anche una rivoluzione non socialista ma semplicemente democratico-borghese non possa verificarsi senza che la classe operaia sia in prima fila nella lotta rivoluzionaria, sotto la direzione politica di un partito socialdemocratico capace di assumersi anche le responsabilità di una partecipazione ad un governo rivoluzionario. Di conseguenza, quello che vuole Lenin è un partito che sia uno strumento efficace di lotta rivoluzionaria, e quindi rigidamente organizzato e disciplinato, e che coincida non con il proletariato in quanto tale, ma con la sua avanguardia cosciente, capace di educare politicamente il resto della classe.
In realtà, la frattura che si determina nel partito operaio socialdemocratico russo al suo secondo congresso, ha soltanto come causa occasionale il contrasto tra un’idea di partito più rigidamente disciplinato ed elitario (idea bolscevica), e un’altra di un partito più aperto e flessibile nell’accogliere nuovi membri nelle sue file. La divergenza più profonda e sostanziale sta nel fatto che il bolscevismo, creato da Lenin, è stato da lui sempre indirizzato a costituire il perno di un’alleanza della classe operaia con altri settori della società, e in primo luogo con i contadini, mentre il menscevismo è rimasto legato all’idea di un partito che rappresenti essenzialmente gli operai, e che si radichi nelle loro lotte sindacali.
Per i menscevichi, inserire i contadini in un’alleanza rivoluzionaria significa deviare dal marxismo, negandone l’idea fondamentale che, dopo la borghesia, soltanto il proletariato di fabbrica sia una classe storicamente progressiva, e regredire all’anarchismo. Per Lenin, al contrario, la classe operaia diventa rivoluzionaria nel senso marxista del termine soltanto se non si chiude nell’orizzonte rivendicativo della fabbrica, e se assume come suoi obiettivi di lotta anche quelli capaci di sottrarre all’oppressione altre classi sociali.
Questa divergenza ne implica un’altra. I menscevichi ritengono che, essendo la Russia un paese ancora nella fase feudale-autocratica dello sviluppo storico, la sua rivoluzione dovrà introdurvi il capitalismo, per cui sarà la borghesia a dirigerla, assumendo la guida politica di tutte le altre classi sociali. Questa concezione giustifica la loro idea che il loro partito debba limitarsi a rappresentare gli interessi economici della classe operaia, rimanendo subordinato ai partiti borghesi nella lotta politica. Lenin, invece, pensa che la Russia sia già entrata nella fase capitalistica dello sviluppo storico, con un capitalismo, però, dipendente dal capitalismo straniero, che ha trovato conveniente mantenere in vita il sistema autocratico e la sottomissione feudale dei contadini per garantirsi manodopera a basso costo e senza diritti sindacali.
Lenin espone questa impostazione politica, che sarà quella del bolscevismo, in un famoso saggio uscito nel giugno 1905, Le due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica. Dunque, la rivoluzione che egli prospetta per la Russia è – in pieno accordo, su questo punto, con i menscevichi – una rivoluzione democratico-borghese, non socialista. Né, d’altra parte, esiste per lui – ancora in accordo con i menscevichi – una scorciatoia verso il socialismo che non passi prima per la piena realizzazione dei principi democratici creati dalla borghesia. “Chi vuol marciare verso il socialismo per un cammino che non sia quello della democrazia politica“, egli scrive, “arriverà inevitabilmente a conclusioni assurde e reazionarie“. E allora perché due tattiche nella socialdemocrazia russa, quella bolscevica e quella menscevica?
Lenin è profondamente convinto che la rivoluzione democratico-borghese debba servire in Russia non già ad instaurare il capitalismo, già esistente, ma a sostituire un capitalismo dipendente dall’estero e colluso con l’autocrazia con un capitalismo capace di un autonomo sviluppo. La borghesia russa, infatti, che è al servizio del capitale straniero, non è in grado di promuovere il passaggio ad un capitalismo capace di autonomo sviluppo e ad un sistema democratico. La tattica menscevica di lasciare alla borghesia l’iniziativa e la guida della rivoluzione democratica in Russia finirebbe con l’essere una tattica di ostacolo ad una vera rivoluzione. La rivoluzione democratico-borghese in paesi arretrati come la Russia è, scrive Lenin, “più vantaggiosa per il proletariato che per la borghesia“, in quanto in tali paesi “la classe operaia soffre non tanto per il capitalismo quanto per l’insufficienza del suo sviluppo“. La tattica del bolscevismo dovrà perciò essere quella di spingere la classe operaia a promuovere e dirigere essa la rivoluzione democratica.
La rivoluzione democratica sarà cioè borghese non nel senso di essere promossa e diretta dalla classe borghese, ma nel senso che “non uscirà dal quadro economico e sociale di origine storica borghese, vale a dire dal quadro capitalistico” sul piano dei risultati. In Russia “la rivoluzione non soltanto non distruggerà le basi del capitalismo, ma anzi le allargherà rendendole internamente autosufficienti“. D’altra parte, una rivoluzione democratico-borghese in Russia compiuta dal proletariato, potrebbe spingere il proletariato alla rivoluzione anche nell’Europa occidentale, e là la rivoluzione segnerebbe il passaggio dalla democrazia al socialismo. Di qui la famosa tattica del fintantoché adottata dai bolscevíchi: essi avrebbero appoggiato le iniziative borghesi, ed un eventuale governo borghese, fintantoché questi avessero promosso lo sviluppo della rivoluzione, mentre, non appena fossero cominciati gli inevitabili compromessi ed arretramenti della borghesia, essi avrebbero cercato di abbatterne la direzione politica e di assumere direttamente la guida della rivoluzione.
Lenin poi sosteneva con forza l’idea che in un paese come la Russia la socialdemocrazia avrebbe dovuto dirigere anche la lotta antifeudale dei contadini, per dare soddisfazione alla loro aspirazione borghese di ottenere la proprietà delle terre da sottrarre all’aristocrazia. Soltanto una simile alleanza, avrebbe consentito la realizzazione della rivoluzione democratico-borghese, permettendo alla socialdemocrazia di tenere il potere grazie all’appoggio contadino, e di guidare la Russia ad uno sviluppo moderno ed autonomo del capitalismo, cui avrebbero dato un contributo decisivo, dopo essersi impadroniti delle terre dell’aristocrazia, i contadini più ricchi, e nel cui àmbito il proletariato avrebbe potuto godere di tutti i diritti civili e politici ed organizzarsi per la tutela dei suoi interessi. In un simile contesto, la socialdemocrazia avrebbe potuto conservare il potere promuovendo, qualora se ne fossero verificate le condizioni, la transizione dal capitalismo al socialismo immediatamente dopo l’avvento di un capitalismo moderno e non dipendente dall’estero.
E tali condizioni, per Lenin, erano sostanzialmente due, una interna e l’altra esterna.
Occorreva innanzitutto uno sviluppo del capitalismo nelle campagne tale da creare uno strato di contadini proletarizzati direttamente interessati, come proletari, all’avvento del socialismo. Ma la condizione interna non sarebbe stata sufficiente, perché il concreto impiego dei lavoratori agricoli in grandi fattorie collettive organizzate in maniera socialista esigeva una grande disponibilità di mezzi e di tecniche di origine industriale. Infatti, senza macchine agricole, fertilizzanti chimici, distribuzione di energia elettrica e presenza di esperti, neppure i contadini più poveri avrebbero capito la necessità di rinunciare alla proprietà privata a favore del lavoro cooperativo su larga scala. Inoltre l’industria russa non avrebbe potuto fornire tutto questo senza una lunga fase di sviluppo capitalistico moderno.
Per instaurare il socialismo anche senza questa fase preliminare era necessaria, secondo Lenin, una seconda condizione non interna ma internazionale, e cioè il verificarsi di una rivoluzione socialista in qualcuno dei paesi maggiormente dotati di un’industria moderna, che avrebbero potuto così fornire alla Russia i mezzi necessari per instaurare il socialismo. La rivoluzione del 1905 approfondirà le divergenze tra menscevichi e bolscevichi al punto che essi cesseranno di essere due ali di un unico partito socialdemocratico e diventeranno due partiti distinti. La rottura definitiva avverrà nell’aprile 1905, quando il gruppo dirigente bolscevico organizza a Londra il 3° congresso del partito, al quale i menscevichi rifiutano di partecipare, riunendosi in un congresso separato a Ginevra.
2. Alcune considerazioni sulla rivoluzione e sulla guerra
L’idea di rivoluzione è nata in Europa con la rivoluzione francese. Una rivoluzione borghese perché, anche se i moti di rivolta contro le istituzioni dell’Ancient Régime sono stati compiuti dai ceti popolari, sono state tuttavia le classi borghesi a dare loro sbocchi politici, ed a servirsene per progettare e realizzare nuove forme di relazioni sociali conformi ai propri interessi, trasformando così le rivolte in rivoluzione. Per tre generazioni, la parte più ambiziosa, intelligente e irrequieta della gioventù europea è stata affascinata dall’idea di rivoluzione, che per essa ha rappresentato la prospettiva esaltante di una volontà umana divenuta capace di indirizzare la storia ad esiti conformi a progetti razionali e morali.
Consolidando il loro potere sociale, le classi borghesi hanno avuto una tendenza sempre più marcata a liquidare l’idea di rivoluzione, per rendere immutabili gli assetti della società, conformi ai loro interessi. Hanno poi tentato di separare le idee di nazione e di rivoluzione (gemelle alla nascita, perché l’aspirazione della nazione a farsi Stato aveva comportato la rivoluzione contro i poteri imperiali ed ecclesiastici, e perché la rivoluzione era stata necessaria per dare compimento democratico alla realtà della nazione), contrapponendo la prima alla seconda. L’idea di rivoluzione resiste, ma come rivoluzione proletaria. Rivoluzionari sono stati allora coloro che intendevano indirizzare la classe operaia ad abbattere l’ordine borghese, per instaurare una società senza più differenze di classe, la società socialista. Identificato l’ordine borghese, e con esso il sentimento della nazione, con il sistema capitalistico, la rivoluzione è stata di conseguenza identificata con la distruzione del capitalismo, e con l’affermazione di un internazionalismo portatore di eguaglianza e negatore dell’appartenenza nazionale. Da parte borghese la valorizzazione dell’appartenenza nazionale è stata usata per svalutare l’appartenenza di classe e delegittimare la rivoluzione.
Quando nel 1914 scoppia la guerra europea (poi mondiale), sembra che sia l’idea di nazione a trionfare, con la contestuale liquidazione dell’idea di rivoluzione. I partiti socialisti si schierano infatti ciascuno con la borghesia della propria nazione in guerra, contro le nazioni nemiche, e così le classi proletarie di diversa nazionalità. L’appartenenza di classe sembra quindi perdere significato di fronte al valore, percepito come supremo nel contesto di una guerra di immani proporzioni, dell’unità nazionale. Ogni nazione in guerra sembra unita da un fervore patriottico che coinvolge tutti i ceti sociali, induce interi popoli ad accettare come giusto il quotidiano massacro delle armi, lascia nell’ombra i sordidi interessi mercantili che alimentano il conflitto, e favorisce la criminalizzazione del dissenso politico e dell’uso critico del pensiero. Chi si oppone alla guerra viene violentemente attaccato come nemico della sua stessa patria, e chi avanza ragionate obiezioni contro la guerra viene squalificato e messo a tacere, perché, si dice, la nazione minacciata dai nemici non può dividersi e coltivare dubbi. La ragione viene messa al bando, e la vita militare inibisce la riflessione critica, ottunde il senso morale, annienta l’autonomia personale.
Si può dire che nasca addirittura una nuova figura antropologica, quella di un uomo che interpreta ogni vicenda umana esclusivamente secondo il vantaggio o lo svantaggio che ne trae la lotta contro il nemico, e che si pensa come un soldato i cui scopi siano raggiungibili soltanto con la violenza, e le cui virtù siano l’obbedienza, e non l’autonomia, il coraggio e non la critica, la fredda determinazione dell’agire e non la sensibilità umana del compendere, l’efficacia nel raggiungere gli obiettivi prescritti e non l’intenzionalità morale. Si tratta della diretta conseguenza del fatto che gli eserciti della Grande guerra non sono più composti, come gli eserciti delle guerre precedenti, da soldati di professione, separati dalla società civile e senza influenze sulle mentalità dei diversi gruppi sociali, ma da soldati radicati nella vita produttiva.
Il soldato del 1914-18, cioè, è un contadino che tornerà a fare il contadino, un artigiano che tornerà a fare l’artigiano, un impiegato che tornerà a fare l’impiegato, un professionista che tornerà alla sua professione civile. La vita militare non è il suo mestiere, ma una parentesi nella sua esistenza normale. Una parentesi, però, così costrittiva, minacciosa e di lunga durata, che per adattarvisi occorre sviluppare nuove abitudini e le nuove forme mentali acquisite dai soldati alla fine inevitabilmente rifluiscono nella vita civile, modificando il modo di pensare e di agire collettivo.
La Grande guerra è la prima guerra industriale e democratica, nel senso che ogni paese combatte i suoi nemici convertendo il suo apparato industriale alla produzione degli armamenti, e mobilitando le sue masse popolari sul piano militare. L’intera società viene quindi irreggimentata e uniformata sotto una disciplina di guerra. Tutto funziona soltanto se ai soldati viene dato, in cambio della libertà che perdono e dei pericoli che corrono, un ruolo che garantisca loro almeno il cibo essenziale, una minima tutela, ed una considerazione gratificante. Quando invece, al prolungarsi della guerra, i paesi con l’apparato industriale meno sviluppato, e l’economia più debole, danno ai loro soldati scarso cibo e armi insufficienti, tenendoli sotto controllo con una disciplina terroristica ed esponendoli a ripetuti massacri con offensive sconsiderate, la militarizzazione delle masse ad un certo momento si spezza. E allora il ripudio della guerra si diffonde dalle forze armate, che tendono a disgregarsi, alla società civile, che tende a ribellarsi. Ma la guerra connette interessi economici e politici di tutti i centri di potere, dal capitalismo industriale alla socialdemocrazia, per cui la spinta a ripudiarla è oggettivamente volta contro l’intero sistema di potere.
L’idea di rivoluzione riprende allora vigore. La guerra, che sembrava all’inizio averla liquidata a favore dell’idea di nazione, nel corso del suo svolgimento la riproduce invece, più forte che mai, sotto forma di “guerra alla guerra”. Il ciclo rivoluzionario che si apre in Europa nel 1917, è dunque figlio della Grande guerra. La rivoluzione che esso prospetta è una rivoluzione contro il sistema capitalistico che ha prodotto la guerra, ed è una rivoluzione che si vuole attuare attraverso la mobilitazione delle masse per la conquista del potere politico, perché già la guerra ha mobilitato le masse, e le ha politicizzate con la sua propaganda sui doveri del popolo verso la patria. L’idea di rivoluzione che rinasce si basa poi sul mito della classe operaia come classe destinata dalla sua collocazione nel processo produttivo ad abbattere il capitalismo, e ad eliminare la distinzione tra le classi, e quindi anche sé stessa come classe. Si tratta di un mito che in parte discende direttamente dall’ideologia del socialismo ottocentesco, dalla quale provengono solitamente i nuovi militanti rivoluzionari, e per la quale la classe operaia di fabbrica è il soggetto rivoluzionario per eccellenza, ma in parte è sollecitato dalla guerra stessa.
Una sola classe sociale, infatti, non ha assorbito le abitudini eticamente ed umanamente degradate del soldato, e cioè la classe operaia di fabbrica, per il semplice fatto che gli operai, indispensabili nelle fabbriche, per la produzione di armi, non sono stati quasi mai inviati al fronte. Di conseguenza, man mano che la guerra totale si manifesta sotto forma di privazioni e di repressioni anche per gli operai, questi non sono spinti all’adattamento, ma piuttosto alla ripugnanza per la guerra, che li fa effettivamente apparire come l’unica classe rivoluzionaria. La classe operaia è inoltre diventata con la guerra più consistente, autonoma e conscia della propria forza, perché l’enorme sviluppo della produzione bellica l’ha accresciuta e separata dall’intreccio con forme precapitalistiche di produzione che vedevano l’operaio partecipare anche alla produzione rurale domestica.
3. La Russia e la Grande guerra
Il ciclo rivoluzionario che si apre nel 1917 inizia in Russia, “l’anello debole” della catena capitalistica che avvolgeva il mondo e lo brutalizzava inducendo milioni di individui a considerare come loro dovere quello di massacrarsi reciprocamente. L’industrializzazione capitalistica si era sviluppata soltanto dalla fine del XIX secolo, limitata ad un arcipelago di piccole isole di produzione industriale in un mare di arretrata economia contadina. Ne facevano parte alcune zone dell’Ucraina, Mosca e il suo distretto, e soprattutto Pietroburgo, dove lavoravano ben 600.000 operai di fabbrica, dipendenti da capitali in larga misura inglesi e francesi. L’autocrazia monarchica e il feudalesimo rurale che permettevano lunghissimi orari di lavoro, bassi salari, e assenza di protezione sindacale degli operai costituivano il tramite che attiravano in Russia gli investimenti stranieri.
Con simili caratteristiche, l’industrializzazione capitalistica aveva portato in Russia, accanto ad una maggiore chiarezza complessiva, maggiori disuguaglianze, e crescenti contraddizioni sociali e politiche, esasperate dalla bruciante sconfitta russa nella guerra del 1904-1905 con il Giappone. Come abbiamo visto nella prima parte, nel 1905, c’era stato un moto rivoluzionario in alcune fabbriche e in alcune aree rurali, di operai e di contadini. Gli operai avevano sviluppato una propria organizzazione rivoluzionaria, quella dei soviet, organismi elettivi di membri revocabili in ogni momento dai loro elettori ed incaricati di rappresentarli di fronte ai padroni delle fabbriche ed alle autorità governative, mentre i contadini avevano dato vita ad agitazioni caotiche. L’autocrazia zarista era riuscita a spegnere il moto rivoluzionario isolando gli operai, attraverso una rapida e sanguinosissima repressione delle caotiche agitazioni contadine, ed attirando dalla sua parte la borghesia, con la promessa di una legislazione più favorevole ai suoi interessi economici e dell’istituzione di un parlamento in cui essa avrebbe potuto far sentire la sua voce.
E così l’opposizione borghese all’autocrazia zarista, dopo aver cercato in un primo momento di assumere la guida del moto rivoluzionario, per orientarlo a sostituire il sistema feudale con un sistema capitalistico-borghese, e a trasformare la monarchia autocratica in una monarchia costituzionale, aveva voltato le spalle agli operai, spaventata dai loro soviet, che prefiguravano un potere operaio più che borghese, e si era schierata a fianco della repressione zarista, convinta di poter ottenere in cambio, senza lotta, la trasformazione della monarchia autocratica in una monarchia costituzionale. La Corte zarista scivolò sempre più nella corruzione e nell’inefficienza, aggravate e rese ridicole dalla crescente influenza politica di Rasputin, un monaco fanatico e incolto, addirittura analfabeta, ma considerato mago, taumaturgo e astrologo della famiglia dello zar, che gli delegò la scelta dei ministri!
3.1 La Russia entra in guerra
Nel 1914 la Russia entra in guerra. Nel 1915, respinto dall’esercito ottomano l’attacco inglese nella penisola di Gallipoli, che rende impossibile all’Inghilterra inviare la sua flotta a rifornire attraverso gli Stretti la Russia, questa si trova a dover combattere con i suoi soli mezzi economici contro la Germania, l’Austria-Ungheria e l’Impero ottomano. La ristrettezza dell’apparato industriale della Russia, l’arretratezza del suo sistema economico rimasto in vaste regioni ancora feudale, l’ignavia della sua nobiltà, e l’inefficienza della sua burocrazia corrotta e servile, hanno effetti devastanti. L’intera Polonia russa viene perduta già nel 1915, conquistata dalle armate tedesche. Le prime offensive vittoriose contro l’Austria-Ungheria si spengono, perché l’industria non riesce ad alimentarle con un flusso adeguato di armamenti, fino all’esito rovinoso di interi reparti russi che vengono a trovarsi nell’impossibilità di far fuoco sui nemici per mancanza di munizioni. L’esercito russo si rivela incapace persino di piegare il fragile Impero ottomano.
Nell’autunno del 1916, sotto il peso di un impegno bellico troppo pesante per il suo apparato produttivo, e senza aiuti economici dall’Inghilterra, con la quale non esistono vie praticabili di comunicazione, la società russa si avvia al collasso. Manca il cibo per i soldati e per vasti strati popolari, perché la sottrazione di milioni e milioni di braccia ai campi, per effetto della trasformazione dei contadini in soldati, ha fatto crollare la produzione agricola. Manca ogni genere di combustibile, persino il legname così abbondante nel paese, perché mancano i mezzi di trasporto con cui farlo affluire nei centri abitati. La popolazione soffre quindi tremendamente il freddo, e diverse fabbriche chiudono per mancanza di carbone, e licenziano i loro operai, creando così altra miseria. Le classi più elevate si chiudono nei loro lussi e creano risentimento in mezzo alla miseria diffusa, disinteressandosi del resto della società, che, senza più guide autorevoli, vede dissolversi il suo tessuto connettivo.
3.2 La Rivoluzione di febbraio
Nel settembre 1916, lo zar Nicola II si affida ancora una volta al monaco imbroglione Gregorj Rasputin. Su suo suggerimento chiama alla guida del governo il conte Sturmer, espressione di quella parte della nobiltà e dei comandi militari che ritengono indispensabile una pace separata con gli Imperi centrali, per evitare che la prosecuzione della guerra dissolva l’ordine sociale. L’ascesa al potere di Strumer preoccupa molto sia i governi dell’Intesa, che temono il vantaggio militare derivante alla Germania da un’uscita della Russia dalla guerra, sia la parte più dinamica della borghesia russa, che teme una pace che la possa declassare. Infatti, i partiti borghesi sono stati autorizzati, sia pure entro limiti ristretti, a fare apertamente attività politica, benché di opposizione al regime autocratico. Temono perciò che una pace separata restituisca alla nobiltà e alla sua burocrazia anche i pochi privilegi perduti, e porti ad una nuova messa al bando dei partiti dell’opposizione borghese.
Questi partiti si riuniscono dunque in un “Blocco progressista” che attacca duramente il nuovo indirizzo di governo. Sturmer viene licenziato in novembre, ma il suo successore, il reazionario Trepov, è indicato anch’egli da Rasputin. Nel dicembre del 1916, Rasputin, diventato ormai il simbolo stesso dell’estremo discredito in cui era caduta la Corte zarista, viene avvelenato. La sua morte è opera di una congiura guidata dall’ambasciatore inglese a Pietroburgo, intenzionato a spianare la strada a un colpo di Stato interno, con l’intento di deporre lo zar Nicola II e sostituirlo con suo figlio secondogenito Alessio. Questi, ancora minore di età, consentirebbe una reggenza volta ad instaurare una monarchia costituzionale, modernizzare il paese, e condurre più efficacemente la guerra, senza passare attraverso una rivoluzione popolare.
Ma nessuno approfitta del disorientamento in cui è caduto l’ambiente dello zar dopo la morte di Rasputin, e non c’è alcun colpo di Stato. La situazione sociale e politica perciò si incancrenisce e l’economia va al collasso: nell’inverno 1916-17 in Russia si comincia a morire di fame e di freddo. Il ministro degli interni dello zar, il feroce reazionario Protopopov non sa rispondere che con una repressione a tutto campo, molto dura anche nei confronti dei più moderati tra gli esponenti dell’opposizione borghese, e questa, priva di ogni alternativa, non ostacola la possibilità di un moto popolare, sempre più probabile vista la rabbia degli operai che chiedono pane e lavoro, e dei soldati che chiedono la fine dei massacri inutili e della disciplina terroristica.
Quando il moto scoppia, l’8 marzo 1917, a Pietroburgo, tra gli operai delle acciaierie Putilov, diventa subito una valanga: gli operai in sciopero invadono le strade, e trascinano allo sciopero e sulle strade tutti gli altri operai della città. Alle dimostrazioni si aggiungono disoccupati e piccolo borghesi e i soldati di guarnigione inviati a reprimere i dimostranti si uniscono a loro, trasformando l’agitazione in un fiume in piena, dandole il carattere di una vera e propria rivolta antizarista. I reparti militari fedeli allo zar non possono raggiungere la città per il boicottaggio dei ferrovieri e alla fine il governo zarista perde totalmente il controllo della sua capitale.
Tutto questo avviene a Pietroburgo nell’arco di una sola settimana, da giovedì 8 a mercoledì 14 marzo 1917, quando lo zar Nicola II abdica in favore del fratello Michele che rinuncia a sua volta al trono, non avendo la possibilità di insediarsi a palazzo reale, poiché la capitale è completamente in mano agli insorti, Con la rinuncia di Michele finisce il dominio della dinastia dei Romanov sulla Russia e scompare la sua burocrazia, perché tutti i funzionari del regime, temendo di cadere vittime di vendette popolari, abbandonano i loro posti direttivi. Questa insurrezione è nota come la rivoluzione di febbraio, perché le date della Russia zarista, quelle del calendario giuliano, erano sfasate di tredici giorni all’indietro rispetto al calendario gregoriano.
Gli insorti si rivolgono contro le istituzioni e le autorità del regime zarista e le abbattono, ma senza capi né progetto politico. La loro rivoluzione è quindi una rivolta plebea contro la fame, la disoccupazione e l’oppressione poliziesca e militaristica, il cui esito vittorioso non determina il trapasso da un regime ad un altro, apre soltanto un vuoto di potere. A Pietroburgo, nel marzo 1917, non comandano più gli uomini dello zar, né vigono più le loro leggi, ma al loro posto c’è il caos. Il potere politico, che la rivolta popolare di Pietroburgo ha tolto all’apparato zarista senza consegnarlo ad alcun altro, è perciò a disposizione di chi sappia più rapidamente organizzarsi per prenderselo, vale a dire di chi per primo si renda capace di riempirne il vuoto.
Saranno due soggetti politici distinti che penseranno a colmare questo vuoto. Il comitato esecutivo della Duma, costituitosi come emanazione del gruppo parlamentare del “Blocco progressista”, e presieduto dal principe Lvov e il soviet degli operai e dei soldati di Pietroburgo, costituito sul modello di quello del 1905 sotto la guida del capo menscevico Ccheidze. I due organismi, entrambi desiderosi di porre termine a una situazione caotica, raggiungono in tutta fretta un accordo che prevede l’attribuzione del potere ad un governo provvisorio formato da esponenti dei soli partiti borghesi, con l’impegno, però di garantire la piena libertà di espressione a tutte le componenti politiche e di organizzare l’elezione a suffragio universale di un’assemblea costituente.
Il governo provvisorio (15 marzo 1917) gode all’inizio di un consenso generale, sia tra le forze politiche tornate alla luce del sole, che contano su una trasformazione democratico-borghese del sistema politico e sociale, sia tra le masse popolari, desiderose di pace e lavoro. La memoria della rivoluzione del 1905 e l’esempio di Pietroburgo spingono i settori più attivi di queste masse ad esprimersi attraverso i soviet. Nel corso della seconda metà di marzo si formano circa seicento soviet, per lo più nelle città, con criteri rappresentativi diversi da luogo a luogo. Essi si coordinano attraverso una conferenza nazionale che si tiene a Pietroburgo alla fine del mese. Si viene così a determinare il famoso dualismo dei poteri riconosciuto, dai contemporanei e dagli storici, come esito caratteristico della rivoluzione di febbraio: c’è il potere del governo provvisorio della borghesia, e c’è il potere dei soviet degli operai e dei soldati. I due poteri vanno per ora d’accordo, e il governo provvisorio viene riconosciuto dai soviet come l’istanza politica più alta. Ma in realtà, tra il popolo molti obbediscono solamente al soviet che hanno eletto, e il governo provvisorio funziona, soltanto perché le sue direttive sono tradotte in ordini esecutivi dai soviet.
3.3 Il ritorno di Lenin
Quando scoppia a Pietroburgo la rivoluzione di febbraio, Lenin si trova in Svizzera, a Zurigo, dove vive esule, con la moglie Nadezda Krupskaja. Quando riceve la notizia, il 15 marzo, che in Russia l’autocrazia zarista è crollata, Lenin è un uomo sui quarantasette anni, con seri problemi di salute, avendo ereditato dal padre una predisposizione genetica alle malattie gastriche e all’arteriosclerosi cerebrale. La Krupskaja racconta: “Avevamo appena finito di pranzare, ed io stavo ancora lavando i piatti, quando arrivò trafelato Bronski, per dirci che in Russia c’era la rivoluzione. Esitammo a credergli, e, invece di andare in biblioteca, come avevamo stabilito, corremmo fino al lungolago, dove si affiggevano in una vetrina i telegrammi che riferivano le notizie dall’estero; lì, davanti a quella vetrina scoprimmo, storditi e felici, che sì, era vero, la rivoluzione era cominciata in Russia, e l’odiata famiglia Romanov aveva già perso il trono“.
Da quel momento, l’ossessione di Lenin sarà di tornare subito in Russia, per non ripetere l’errore commesso nel 1905, quando, rimasto troppo a lungo in Svizzera, aveva finito per non avere alcuna influenza sullo sviluppo delle vicende. Ma questa volta tra la Svizzera e la Russia ci sono i fronti di guerra, ed egli sente il suo esilio come una gabbia. Esclusa la possibilità di tornare in patria attraverso la Francia e il Mare del Nord, perché Francia ed Inghilterra non avrebbero certo concesso il transito ad un rivoluzionario russo ostile alla partecipazione alla guerra della potenza loro alleata, cerca per qualche tempo di noleggiare un aereo con cui sorvolare la Germania, ma si arrende poi all’evidenza che i tedeschi lo avrebbero abbattuto.
Un altro esule, il menscevico Martov, gli prospetta l’idea di provare a tornare in Russia attraverso uno scambio tra il libero transito di un certo numero di esuli russi in Germania, ed il rilascio di un numero equivalente di prigionieri tedeschi da parte della Russia. Questo tentativo fallisce, perché il ministro degli esteri del governo provvisorio russo, Pavel Miljukov, non vuole far andare in Russia uomini che finirebbero sicuramente per contrastare la sua politica di guerra imperialista. Ma sarà proprio questa posizione a favorire le argomentazioni di uno strano personaggio per convincere i tedeschi a facilitare il ritorno in Russia di un gruppo di esuli di Zurigo, senza chiedere alcuna contropartita.
Costui è un coetaneo di Lenin, Aleksandr Gelfand, che aveva militato in passato tra i bolscevichi con il nome di battaglia di Parvus. Deportato in Siberia dopo la rivoluzione del 1905, ne fugge e raggiunge avventurosamente la Germania, dove diventa un industriale di successo. Quando scoppia la guerra, fa affari con l’esercito tedesco, cercando di far scomparire ogni traccia del suo passato rivoluzionario. Ma non dimentica di essere stato Parvus, e vive con un certo senso di colpa il suo stato di capitalista speculatore. Si inserisce allora nella questione del possibile transito in Germania degli esuli russi, per avere la gratitudine di Lenin, e non essere considerato un traditore. Forte della conoscenza del capo dello stato maggiore tedesco del fronte orientale, Max Hoffmann, gli prospetta il vantaggio di inviare in Russia un gruppetto di capi rivoluzionari, che ne avrebbero sabotato l’impegno militare. Su suggerimento di Hoffmann, il governo tedesco incarica il suo ambasciatore a Berna, Gisbert von Romberg, di assecondare i progetti di Lenin. Le trattative si svolgono tra lo stesso ambasciatore Romberg e il socialista svizzero Fritz Platten, dal quale si fanno rappresentare gli esuli di Zurigo. L’accordo prevede il transito degli esuli russi attraverso la Germania su un treno dotato di extraterritorialità, e il loro arrivo in Russia attraverso la Svezia e la Finlandia.
Il treno parte dalla stazione di Zurigo il mattino del 9 aprile 1917, diretto al porto settentrionale tedesco di Sassnitz, dove è collegato al traghetto per la Svezia. Giunto al vicino confine svizzero-tedesco, gli esuli russi vengono raggruppati in un solo vagone, con le porte piombate, e con l’unica uscita all’esterno nell’ultimo scompartimento occupato da due ufficiali tedeschi. Sul corridoio antistante a tale scompartimento, una linea tracciata col gesso bianco segna l’inizio dello spazio di extraterritorialità del vagone. Gli esuli sono trentadue, diciannove dei quali bolscevichi. Tra costoro vi sono i tre massimi dirigenti del partito: Lenin, Zinovev e Radek. Degli altri tredici, sette sono menscevichi, e sei membri di un’organizzazione socialista ebraica.
Giunti il 12 aprile a Sassnitz, sono traghettati nel porto svedese di Trelleborg. La mattina del giorno dopo prendono il treno per Stoccolma, dove, con loro sorpresa, ricevono il benvenuto dal sindaco della città, che li invita a pranzo. La sosta del 13 aprile a Stoccolma induce i bolscevichi a portare quasi di forza Lenin in un grande magazzino, uno dei primi sorti in Europa, dove gli comprano un abito nuovo e un nuovo paio di scarpe, con cui sostituire la sua tenuta troppo sciupata. “Ora sei vestito nel modo giusto per guidare la rivoluzione“, gli dicono. È lunedì 16 aprile 1917, poco prima della mezzanotte, quando il treno, rallentando al massimo per percorrere un lungo tratto curvilineo, fa il suo ingresso nella grande stazione Finlandia di Pietroburgo. Lenin non sa immaginare cosa lo attenda in una capitale da cui non ha più ricevuto informazioni dettagliate, e teme che un rivoluzionario radicale come lui possa venire arrestato subito al suo arrivo.
Pochi minuti dopo, Lenin si accorge invece di essere atteso da grandi festeggiamenti. I marinai, che poco prima ha temuto fossero guardie venute ad arrestarlo, gli presentano le armi, una piccola banda suona la Marsigliese, una giovane militante bolscevica gli porge un mazzo di fiori e molti operai in tenuta da lavoro lo applaudono freneticamente, in un tripudio di bandiere rosse al vento della notte. Si commuove, ma subito dopo si infastidisce nel rendersi conto che ai festeggiamenti partecipano politici di tutte le tendenze, in un clima di unità nazionale attorno al governo provvisorio, che sta continuando la guerra. Sceso dal treno, viene condotto nel salone imperiale della stazione, dove il presidente del soviet degli operai e dei soldati di Pietroburgo, il menscevico Nikolaj Ccheidze, lo saluta ufficialmente, dandogli un altro mazzo di fiori, e pronunciando un discorso di benvenuto in cui auspica il mantenimento dell’unità di tutte le forze democratiche nella difesa della patria. Lenin non risponde affatto a tono, e rivolgendosi ai marinai che lo circondano, dice:
“Cari compagni, la guerra di rapina imperialistica sta per essere contrastata dalla guerra dei popoli contro i loro sfruttatori capitalisti che li hanno mandati al macello… L’alba della rivoluzione socialista mondiale è spuntata“.
Giunto al quartier generale bolscevico di Pietroburgo, si rende conto che anche i capi cittadini del bolscevismo, Lev Kamenev e Iosif Stalin, hanno partecipato all’appoggio generale al governo provvisorio del principe Lvov. Secondo Lenin si è trattato di un errore catastrofico, che è deciso a contrastare con tutte le sue energie. Il punto di riferimento per Lenin, in quel momento, è l’atteggiamento di fronte alla guerra: il governo del principe Lvov è un governo infame perché vuole continuare la guerra, ed i partiti operai che lo appoggiano tradiscono, ingannandolo, il proletariato. I bolscevichi di Pietroburgo sono stati complici di questo inganno, ed è necessario far cambiare loro strada.
3.4 Le Tesi di aprile
In quello stesso giorno, a Lenin viene affidato il compito di riferire le posizioni del gruppo “svizzero”, prima ad un’assemblea dei militanti socialdemocratici sia bolscevichi che menscevichi, poi al comitato centrale bolscevico. Di fatto, riferisce le sue posizioni, messe per iscritto nella notte. Esse costituiranno le linee guida per tutta la durata della rivoluzione. Tali posizioni, articolate in dieci distinte tesi, passeranno alla storia come le Tesi di aprile. Data la loro estrema importanza, le riportiamo in dettaglio.
La prima sostiene la fondamentale parola d’ordine con cui i bolscevichi devono presentarsi alle masse popolari è “pace ai popoli!“, chiarendo alle masse popolari che sono gli interessi capitalistici ad alimentare la guerra, e che quindi un governo legato a tali interessi non può essere che un governo di guerra.
La seconda sostiene che l’obiettivo politico immediato dei bolscevichi deve essere quello di “smascherare il governo provvisorio“, a cui deve essere negato ogni appoggio.
La terza inquadra la lotta al governo provvisorio nel passaggio dalla prima alla seconda fase della rivoluzione democratico-borghese, cioè dall’abbattimento della macchina statale zarista e dalla conquista del potere statale da parte della borghesia, alla dissoluzione della proprietà feudale e a un nuovo sviluppo industriale non dipendente dal capitale straniero. Lenin evidenzia come la prima fase, nella quale la borghesia svolge ancora un ruolo progressivo, si sia compiuta rapidissimamente, nella settimana della “rivoluzione di febbraio”, e che la seconda, che si è appena aperta, può compiersi soltanto se il proletariato sottrae il potere statale alla borghesia. E il grande errore dei bolscevichi russi è stato quello di non rendersene conto.
La quarta tesi lancia la parola d’ordine, famosissima, di tutto il potere ai soviet! Poiché la borghesia russa non può promuovere la modernizzazione del paese, a causa dei suoi legami strutturali con la proprietà feudale ed il capitale straniero, la rivoluzione democratica non può compiersi in Russia nelle forme di una repubblica parlamentare borghese, ed esige invece una democrazia proletaria, che si è già data le sue forme nei soviet degli operai e dei soldati. La rivoluzione democratico-borghese in Russia è dunque borghese nei suoi contenuti socioeconomici (nel senso che è una rivoluzione che generalizza i rapporti mercantili e capitalistici e promuove lo sviluppo industriale), ma non nel suo soggetto politico chiamato a realizzarli, che è l’avanguardia politicamente cosciente del proletariato.
La quinta tesi sostiene che compito dei bolscevichi è quello di far capire al proletariato che non vi sarà alcuna rivoluzione democratica se esso non prenderà il potere politico e non ne promuoverà direttamente la realizzazione.
La sesta chiede la confisca senza indennizzo di tutte le proprietà fondiarie dell’aristocrazia, del clero e della casa reale, e il loro passaggio sotto il controllo dei soviet, che dovranno trarne aziende agrarie di non meno di trecento ettari ed assegnarle alla gestione di cooperative di contadini. La parola d’ordine deve dunque essere “Tutta la terra ai contadini!“.
La settima sostiene che il potere dei soviet dovrà procedere alla nazionalizzazione del commercio estero e di tutte le più importanti banche.
L’ottava sostiene che “l’instaurazione del socialismo non è il nostro compito immediato“, in quanto il proletariato, una volta assunto il potere politico attraverso i soviet, dovrà promuovere trasformazioni socioeconomiche entro limiti democratico-borghesi, rimanendo entro tali limiti finché non vi sarà una rivoluzione socialista nei paesi più sviluppati d’Europa.
La nona tesi sostiene che, essendo stato screditato il nome del socialismo dall’adesione dei maggiori partiti socialisti alla guerra imperialistica, le forze autenticamente rivoluzionarie dovranno chiamarsi comuniste.
La decima tesi infine sostiene che tali forze rivoluzionarie dovranno trasformarsi in veri e propri partiti, e dare vita ad una nuova Internazionale operaia, la Terza Internazionale, o Internazionale comunista.
Le Tesi saranno respinte con sdegno da tutti i menscevichi, e gli stessi bolscevichi si mostreranno in maggioranza contrari, pensando che gli obiettivi del bolscevismo possano venire più facilmente raggiunti condizionando il governo provvisorio piuttosto che contrastandolo frontalmente. Lenin si trova quindi ad essere, nell’aprile 1917, un capo-partito isolato non soltanto dagli altri partiti, ma dalla maggioranza del suo stesso partito. Le sue idee non hanno fatto presa. Ma nel maggio 1917, la stampa russa parla di una nota trasmessa dal ministro degli esteri del governo provvisorio, il cadetto Miljukov, agli altri governi dell’Intesa, per rassicurarli sull’intenzione della nuova Russia di tener fede ai patti sottoscritti con le potenze alleate.
Il governo provvisorio non intende dunque porre fine alla guerra se non dopo una completa vittoria militare, e con una pace annessionista. Gli operai delle fabbriche ed altri strati popolari, anche non affiliati ad alcun partito o addirittura menscevichi, reagiscono con rabbiose manifestazioni di protesta, perché pensavano che il governo provvisorio puntasse alla pace, e perseguisse quindi una pace senza annessioni. I bolscevichi capiscono allora quanta verità vi fosse nelle Tesi di Lenin, e come la parola d’ordine del loro capo, pace ai popoli!, consentisse al bolscevismo di attrarre masse popolari deluse e scontente.
A Pietroburgo, il ministro della guerra Guckov predispone la repressione del moto operaio. Ma il soviet della capitale ne paralizza l’azione, perché gli stessi soldati obbediscono ad esso piuttosto che al ministro. Il capo del governo, il principe Lvov, deve allora accettare la completa libertà di manifestazione, promettendo nel contempo che in futuro si sarebbe consultato con i soviet prima di prendere decisioni politiche. Si forma allora un secondo governo Lvov, di dodici ministri, sei dei quali appartenenti al partito della borghesia, cioè quello cadetto, e sei ai partiti dei soviet esclusi i bolscevichi. Hanno cioè due ministri ciascuno i menscevichi, i socialrivoluzionari e i socialisti nazionali, questi ultimi nati per scissione da destra dai socialrivoluzionari, sotto la guida di Kerenskij.
Il passaggio dei partiti dei soviet dal semplice appoggio al governo provvisorio alla partecipazione ad esso, li fa da questo momento apparire responsabili di tutte le scelte del governo provvisorio, e quindi, della continuazione della guerra. In questa situazione le Tesi di aprile di Lenin diventano naturalmente la nuova strategia del partito bolscevico, in quanto tutti i suoi dirigenti capiscono ora che lottare da soli per la pace, per il potere ai soviet e per la terra ai contadini farà rapidamente crescere il partito.
3.5 L’ascesa del bolscevismo
Sembra dunque che la borghesia russa, nel maggio 1917, abbia conquistato la guida del proprio paese. L’autocrazia si è dissolta, l’aristocrazia feudale è padrona dei suoi contadini nelle campagne, ma non ha più alcun controllo dello Stato. E il governo provvisorio del principe Lvov tutela esclusivamente gli interessi borghesi, avendo neutralizzato l’autonomia dei soviet operai con la cooptazione dei capi come ministri. Ma la borghesia deve al più presto scegliere tra l’uscita dalla guerra contro la Germania e l’Austria, e la sua continuazione, ben sapendo che nel primo caso, può mantenere il suo controllo sulle classi popolari, inimicandosi però il capitalismo franco-britannico, dal quale dipendono i suoi affari e che nel secondo caso, scegliendo cioè la continuazione della guerra, conserverebbe l’appoggio del capitalismo franco-britannico, perdendo inevitabilmente il controllo delle masse popolari, per le quali la fine della guerra è ormai la più indilazionabile delle esigenze.
La borghesia sceglie questa seconda strada: in giugno il ministro della Guerra del governo Lvov, Aleksandr Kerenskij, rappresentante dei soviet per conto del partito socialista nazionale, molto popolare tra i soldati, cerca di rendere popolare anche l’idea di una guerra patriottica, lanciando un’offensiva militare contro l’Austria-Ungheria in Galizia, accompagnata da un’intensa propaganda pubblica, che faccia pensare ad ultimo sforzo da compiere per ottenere quelle vittorie che consentano di uscire dalla guerra con una pace democratica.
Questa propaganda convince soltanto i borghesi già persuasi della necessità di continuare la guerra, non certo i soldati, che non si fidano più dei loro ufficiali, e non sopportano l’idea di venire nuovamente mandati davanti ai reticolati ed alle mitragliatrici delle trincee nemiche. L’offensiva di giugno fallisce, e allenta ulteriormente la disciplina dei soldati. I metodi spietati con cui i comandanti militari cercano di ristabilirla hanno come effetto quello di esasperare il malcontento nell’esercito, di moltiplicare le diserzioni, di accrescere enormemente l’influenza dei bolscevichi e della loro parola d’ordine della pace subito e ad ogni costo.
Kerenskij, per la sua convinta determinazione ad imporre alle masse popolari la guerra e la disciplina sociale, per il ruolo e il peso da lui mantenuti nei soviet, e per la sua residua popolarità tra gli strati più bassi della società, appare alla borghesia russa come l’unico “uomo forte” capace di stroncare l’ascesa politica del bolscevismo. E così, a luglio, i partiti politici favorevoli alla continuazione della guerra indicano come nuovo capo del governo proprio Kerenskij. Questi, che conserva anche il ministero della Guerra, forma una sorta di triunvirato, che decide tutto da solo emarginando gli altri ministri, con il menscevico Cereteli, che assume il ministero degli Interni conservando anche quello della Giustizia, e con il cadetto Nekrasov, che assume il ministero delle finanze conservando anche quello dell’Industria.
Il triunvirato di governo diretto da Kerenskij crea tribunali militari contro la sovversione, deferendovi molti capi bolscevichi e costringendoli così all’esilio (Lenin ripara in Finlandia), lascia devastare le tipografie dei giornali bolscevichi, fa reprimere gli scioperi, ristabilisce la pena di morte (abolita dalla “rivoluzione di febbraio”) per i soldati, si affida alla durezza dei generali reazionari.
Lenin sostituisce allora le Tesi di aprile con le Quattro tesi di luglio.
La prima tesi dice che “la controrivoluzione si è organizzata, consolidata e impadronita del potere dello Stato [...], i comandi superiori dell’esercito, con l’aiuto cosciente o semicosciente di Kerenskij, sono diventati padroni della situazione [...], il potere statale effettivo è attualmente in Russia una dittatura militare, benché ancora mascherata da istituzioni democratiche inoperanti“.
La seconda spiega come menscevichi e socialrivoluzionari abbiano scelto, per paura della rivoluzione, di essere “le foglie di fico della controrivoluzione“.
La terza dice che la parola d’ordine del potere ai soviet, relativa alla fase dello sviluppo pacifico della rivoluzione, possibile fino al momento del passaggio del potere effettivo nelle mani della dittatura militare, non è ora più possibile, perché la democrazia dei soviet non può svolgersi sotto una dittatura, e perché essa è stata tradita dai menscevichi e dai socialrivoluzionari.
La quarta tesi invoca la preparazione di una insurrezione armata comunista, l’unica in grado ormai di abbattere la dittatura.
Nell’estate, pur nell’illegalità, i bolscevichi diventano un partito di massa, e attraggono nelle loro file migliaia e migliaia di soldati, i numerosissimi disertori che non vogliono essere fucilati, quelli di guarnigione che non vogliono più tornare al fronte, quelli in trincea che non vogliono più andare all’offensiva e quelli in licenza che non vogliono abbandonare di nuovo le famiglie. Pietroburgo rigurgita di soldati ed ex-soldati divenuti accesissimi bolscevichi. Il tentativo dei menscevichi e dei socialrivoluzionari di ridurre i soviet a gruppi inamovibili di funzionari di partito operanti come semplici cinghie burocratiche di trasmissione degli ordini governativi non riesce, perché in molti luoghi operai e soldati impongono sostituzioni che fanno uscire dai soviet i rappresentanti più smaccatamente kerenskiani e fanno entrare nuovi rappresentanti, bolscevichi a volte, oppure esponenti critici dei partiti menscevico e socialrivoluzionario.
In questi partiti si rafforza così un’ala che fa capo a Martov tra i menscevichi, e alla Spiridonova tra i socialrivoluzionari. Sempre nell’estate i contadini russi, che sono rimasti fino a questo momento piuttosto passivi, tanto da non aver contribuito in alcun modo al rovesciamento dello zar, e ad aver partecipato pochissimo alla nuova vita democratica della primavera, entrano in agitazione, manifestando insofferenza per i vincoli feudali oltre che fame di terre. Nascono così, accanto ai soviet degli operai e a quelli dei soldati, anche i soviet dei contadini, che cominciano a diffondersi a macchia d’olio, promuovendo varie forme di occupazione delle terre incolte, e che sono composti bensì in prevalenza da militanti socialrivoluzionari, per lo più contrari alla politica di sostegno a Kerenskij, del loro capo Viktor Cernov.
Cernov, ministro dell’agricoltura, ha predisposto certamente norme di redistribuzione della terra a favore dei contadini, ma ha anche accettato il principio che tali norme entreranno in vigore soltanto dopo che saranno approvate da una assemblea costituente, rinviata alla conclusione vittoriosa della guerra. Queste esitazioni e questi rinvii esasperano i contadini, i cui rappresentanti nei soviet appoggiano perciò spesso la Spiridonova contro il loro capo Cernov.
Alla fine dell’estate, lo spietato generale Kornilov, al quale Kerenskij ha affidato quasi del tutto la gestione effettiva del potere nelle zone del fronte, si ribella. Kornilov, che detesta Kerenskij sul piano personale, ha con lui due gravissimi dissensi politici, in primo luogo perché vuole una repubblica che sia esplicitamente una dittatura militare, senza la minima traccia dei soviet e dei partiti e, soprattutto, perché è convinto che la borghesia possa continuare a dominare le classi popolari soltanto uscendo dalla guerra. Ritiene perciò suicida la politica di Kerenskij, che intende perseguire la guerra fino alla vittoria, perché non potrà avere altro effetto che quello di disgregare l’esercito, cioè l’unico possibile strumento di repressione delle forze rivoluzionarie.
Quando Kornilov marcia con i suoi feroci “battaglioni selvaggi”, da lui addestrati alla repressione sanguinosa dei moti popolari, contro la capitale Pietroburgo, per destituire ed uccidere Kerenskij, questi capisce subito di potersi salvare soltanto facendosi difendere dalle migliaia e migliaia di soldati fuggiti dalla guerra che affollano la città, armandoli. Compie perciò questa scelta, pur sapendo che tutti quei soldati sono bolscevichi. Essi lo salvano, senza neanche bisogno di combattere, perché si affidano ai ferrovieri bolscevichi, che fanno deragliare tutti i treni che trasportano i soldati di Kornilov. Ma, con la capitale piena di bolscevichi armati, Kerenskij è costretto a rimettere il loro partito nella legalità.
Lenin, tornato in Russia ai primi di settembre, in un saggio Sui compromessi, torna a riproporre uno sviluppo pacifico della rivoluzione. “Soltanto per uno sviluppo pacifico della rivoluzione“, egli scrive, “che è una possibilità estremamente rara nella storia ed estremamente preziosa“, precisa, “soltanto per questa possibilità i bolscevichi possono e debbono addivenire ad un compromesso“.
E qual è il compromesso?
“I bolscevichi rinunzierebbero alla rivendicazione immediata del passaggio del potere al proletariato e ai metodi insurrezionali per far valere questa rivendicazione“.
In cambio di cosa?
“Della piena libertà politica per i bolscevichi“.
Con quale esito?
“I bolscevichi tornano alla rivendicazione del potere ai soviet, si forma un governo di menscevichi e socialisti rivoluzionari, senza cadetti kerenskiani, con i bolscevichi all’opposizione legale“.
Si tratta, evidentemente, della proposta di una democrazia sovietica: poiché i membri dei soviet sparsi per la Russia approverebbero a maggioranza una coalizione di governo tra menscevichi e socialrivoluzionari, questi due partiti dovrebbero governare da soli, senza andare al seguito di Kerenskij, i cui seguaci nei soviet sono ormai un’infima minoranza.
Governando da soli, dimostrerebbero che non accettano alcuna dittatura, ma intendono basare il loro governo esclusivamente sul consenso popolare. Dovrebbero inoltre accettare la libera propaganda dei bolscevichi tra il popolo, ed essere disposti a cedere il governo ai bolscevichi qualora costoro conquistassero la maggioranza.
4. La rivoluzione d’Ottobre
Nel settembre 1917, nella provincia di Tambov, si susseguono numerosi episodi di saccheggi e incendi di tenute nobiliari. Ne sono autori contadini che ne avevano occupato le terre, con ferimenti e uccisioni di proprietari ed amministratori. È l’inizio di uno sconvolgimento violento del mondo contadino russo, nel quale sfociano atavici rancori plebei contro forme pesantissime ed umilianti di sfruttamento sociale, e sul quale agiscono come acceleratori alcune drammatiche situazioni contingenti. La prima di queste è il tentativo assurdo, compiuto dalla nobiltà russa, di tornare ad imporre ai contadini le opprimenti consuetudini feudali, da mesi cancellate, esasperandone così la rabbia e l’aggressività. Una seconda è dovuta alle avversità climatiche, e conseguenti cattivi raccolti, che rendono intollerabili ai contadini i gravami pretesi dai nobili e la mancanza di terre.
Ma la situazione decisiva è il ritorno nelle campagne di numerosissimi soldati congedati, o disertori, o appartenenti a reparti discioltisi, che portano l’abitudine alla violenza omicida, acquisita in guerra, nelle loro famiglie, spingendole a prendersi con la forza le risorse di cui hanno bisogno. L’eccezionale genialità politica di Lenin nel 1917 emerge in particolare nel settembre, quando comprende rapidamente, unico tra i rivoluzionari, che sta crescendo in Russia una gigantesca sollevazione contadina, con un cambiamento radicale delle prospettive sociali e politiche del paese. Se le masse rurali in rivolta non vedranno le loro esigenze soddisfatte e incanalate in una nuova legalità da una rivoluzione proletaria, si determinerà un caos sociale contro il quale si leverà una repressione dittatoriale. Kerenskij è già pronto per il ruolo di repressore.
Sciolto il suo governo, ne forma, sempre in settembre un secondo, orientato in senso ancor più reazionario del primo. Esclude infatti il menscevico Cereteli, sostituito ai suoi due ministeri della giustizia e degli interni rispettivamente da un menscevico di destra e da un cadetto compromesso con Kornilov, e il socialrivoluzionario Cernov, sostituito da un kerenskiano ostile ad ogni ipotesi di riforma agraria.
Lenin si rende conto che la situazione russa si è drammaticamente semplificata fino ad una alternativa secca: dittatura borghese o dittatura proletaria.
Con la rivolta contadina, con il rifiuto di menscevichi e socialrivoluzionari di lottare per soddisfarne le esigenze, e con la scelta esplicitamente repressiva di Kerenskij, la prospettiva di uno sviluppo pacifico della rivoluzione, da lui ardentemente sostenuta qualche settimana prima, si è chiusa: un’opposizione puramente legalitaria dei bolscevichi sarebbe ormai, in assenza di un governo democratico fondato sui soviet, e in presenza di una rivolta contadina, una copertura della dittatura borghese.
Ne La crisi è matura della fine di settembre dice: “È indubbio che in Russia si stia sviluppando una generale sollevazione contadina [...]. Di fronte ad un fatto come questo, tutti gli altri sintomi politici, anche se contraddicessero l’imminenza di una crisi conclusiva, sarebbero privi di qualsiasi valore. Ma tutti i sintomi indicano invece che la crisi è matura nell’intero paese [...]. Insieme alla questione contadina, sta esplodendo la questione nazionale [...]. Abbiamo visto le truppe finlandesi e la flotta baltica staccarsi completamente dal governo [...]. Soldati e operai, inoltre, non sperano ormai più che nei bolscevichi [...]. Vediamo che, nelle ultime elezioni per i soviet di Mosca, 14.000 soldati su 17.000 hanno votato per i bolscevichi [...]. Il proletariato di fabbrica di Mosca, che pure, in confronto a quello di Pietroburgo, ha maggiori legami con la campagna, ed è più vicino alla mentalità dei contadini [...] ha dato ai bolscevichi 82.000 voti, corrispondenti al 47% del totale, contro i 34.000 delle precedenti elezioni di giugno“.
Lenin è dunque convinto che si possa impedire la dittatura borghese con un’insurrezione bolscevica vittoriosa, capace di instaurare una dittatura proletaria: con il 51% dei delegati nei soviet di Mosca, con il 49% nei soviet di Pietroburgo (alla cui presidenza il menscevico Ccheidze ha dovuto lasciare il posto al bolscevico Trotzkij), con alcune migliaia di guardie rosse in armi costituitesi per fronteggiare il colpo di Stato di Kornilov, con i marinai della flotta del Baltico tutti dalla loro parte, con le truppe finlandesi pronte ad appoggiarli per ottenere l’indipendenza della Finlandia dalla Russia, i bolscevichi possono sconfiggere il governo provvisorio di Kerenskij, che non dispone di forze armate da usare contro di loro. I reparti dell’esercito, dove ormai quasi tutti i soldati vogliono la pace, e conoscono ormai Kerenskij come uomo della guerra, gli si rivolterebbero immediatamente se egli pretendesse di avvalersene per reprimere i bolscevichi.
Il compito più difficile per Lenin è paradossalmente quello di convincere il comitato centrale del partito bolscevico ad intraprendere l’insurrezione. L’insurrezione, poi, affidata a un comitato militare rivoluzionario istituito dai soviet di Pietroburgo sotto la guida di Trotzskij, si compie con facilità estrema in un solo giorno con la fuga di Kerenskij e la vittoria degli insorti.
Il giorno è il 7 novembre 1917, il 25 ottobre del calendario giuliano. Quello stesso giorno si riunisce a Pietroburgo il congresso dei rappresentanti di tutti i soviet della Russia (il secondo, dato che un primo congresso di tutti i soviet si era tenuto a giugno), che ratifica a maggioranza i decreti rivoluzionari proposti dagli insorti nei due giorni successivi, che nel calendario russo sono il 26 e il 27 ottobre 1917. Così, come la rivoluzione avvenuta ai primi di marzo è passata alla storia come “rivoluzione di febbraio”, allo stesso modo, la rivoluzione più celebre e importante del XX secolo, avvenuta in Russia ai primi di novembre del 1917, è passata alla storia come “rivoluzione d’ottobre”. Il giorno successivo alla conquista del potere a Pietroburgo da parte dei bolscevichi, il congresso dei soviet approva tre decreti che coinvolgeranno l’intera Russia nella rivoluzione avvenuta a Pietroburgo.
Il primo è il decreto sulla formazione del governo operaio e contadino, che propone un nuovo governo rivoluzionario all’intera Russia, con l’autorità di capitale che da due secoli promana da Pietroburgo, e contando sui militanti rivoluzionari pronti a farne eseguire gli ordini in tutte le regioni del paese. Recita il decreto: «Il congresso dei soviet degli operai, dei soldati e dei contadini di tutta la Russia decreta di costruire, per la direzione del paese, fino alla convocazione dell’assemblea costituente, un governo provvisorio operaio e contadino che si chiamerà Consiglio dei commissari del popolo (Sovnarkom) [...]. Il controllo sulle attività dei commissari del popolo e il diritto di sostituirli spetta al congresso dei soviet degli operai, dei soldati e dei contadini di tutta la Russia». Segue la lista dei primi commissari, tutti bolscevichi, che contempla Lenin come presidente, Rykov agli interni, Trotzskij agli esteri, Miliutin all’agricoltura, Antonov alla guerra, Stepanov alle finanze, Lunaciarski all’istruzione, Stalin alle nazionalità, Lomov alla giustizia. Il congresso dei soviet è formato da 670 deputati, dei quali 321 (cioè il 48%) sono bolscevichi. Poiché 99 deputati sono socialrivoluzionari di sinistra, che si sono staccati dal partito socialrivoluzionario perché favorevoli ad una rivoluzione che dia immediatamente la terra ai contadini, c’è nel congresso una sia pur leggera maggioranza a favore del nuovo governo, nonostante l’opposizione di 88 socialrivoluzionari, 85 menscevichi, 47 socialisti nazionali, 30 socialdemocratici ebrei, opposizione che del resto si riduce subito ai minimi termini con l’abbandono dell’aula, per protesta contro la rivendicazione bolscevica dell’atto insurrezionale, di gran parte dei suoi membri.
Il secondo è il decreto sulla pace, che nelle settimane successive, man mano che sarà conosciuto, conquisterà un vastissimo consenso popolare in tutta la Russia, ed infiammerà molti anche in altri paesi:
“Il governo sovietico propone a tutti i governi e a tutti i popoli dei paesi belligeranti di concludere immediatamente un armistizio, durante il quale vi sia piena possibilità di condurre a termine le trattative di pace, con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i popoli“.
Il terzo è il decreto sulla terra. Il suo primo articolo: “La grande proprietà fondiaria è abolita immediatamente senza alcun indennizzo“. Il secondo: “Le tenute dell’aristocrazia fondiaria, della famiglia reale e dei monasteri, con tutte le loro scorte vive e morte, con le loro ville e suppellettili, sono messe a disposizione dei comitati agricoli e dei soviet distrettuali dei contadini“. Viene così legittimata e regolamentata l’appropriazione contadina delle grandi tenute, che era già in corso da qualche settimana in forme molto violente in gran parte della Russia.
Successivi decreti sanciscono le otto ore di lavoro, l’istruzione gratuita e laica, l’eguaglianza di diritti tra uomini e donne, il matrimonio civile e il divorzio, la statizzazione delle grandi industrie e delle banche, il rifiuto di pagare i debiti dello Stato zarista. Questo è il volto con cui si presenta la “rivoluzione d’Ottobre”: una rivoluzione che abolisce il feudalesimo e la nobiltà, ma non è certo liberale; tuttavia non è neanche socialista, perché autorizza, là dove i soviet dei contadini lo vogliono, l’appropriazione privata individuale della terra da parte dei contadini; non statalizza tutte le industrie, e vi mantiene le gerarchie capitalistiche interne.
4.1 I dieci giorni che sconvolsero il mondo
Così John Reed intitola il suo resoconto completo delle giornate della “rivoluzione d’Ottobre”, un libro famosissimo del giornalista americano, presente sul posto. I dieci giorni sono quelli che vanno, secondo il calendario russo dell’epoca, dal 16 al 25 ottobre 1917, (secondo il nostro calendario i giorni vanno dal 29 ottobre al 7 novembre). Ripercorriamoli.
Lunedì 16 ottobre, alle ore 17, nella sede della duma distrettuale alla periferia di Pietroburgo, requisito dai bolscevichi per le loro attività, si riuniscono i ventiquattro membri del comitato centrale del partito bolscevico, insieme ad altri quindici autorevoli esponenti del partito senza diritto di voto, per deliberare sulla proposta di Lenin di promuovere immediatamente un’insurrezione contro il governo provvisorio di Kerenskij.
Lenin è tornato a Pietroburgo dalla Finlandia appena dieci giorni prima, clandestinamente, perché, nonostante che i bolscevichi abbiano di fatto ottenuto libertà politica da quando Kerenskij ha dovuto appoggiarsi a loro per difendersi da Kornilov, alcuni loro capi sono ancora ricercati dalla polizia. Si è truccato il viso e messo una parrucca per non essere riconosciuto, ed è stato ospitato da Margarita Fofanova, una simpatizzante bolscevica, nota come una innocua agronoma, nella sua casa prospiciente la stazione Finlandia, dove vanno a trovarlo soltanto la moglie Nadezna Krupskaja, la sorella di lei Marija, e l’operaio bolscevico Eino Rahja, che fa la staffetta tra lui ed il partito.
Il presidente del comitato centrale del partito, Jakov Sverdlov, dà subito la parola a Lenin, che fa un discorso appassionato sulla necessità dell’insurrezione, senza nemmeno liberarsi del trucco e della parrucca, mentre parla in tono solenne della rivoluzione. Contro l’insurrezione si esprimono in maniera molto dura prima Kamenev e poi Zinoviev: per loro, l’insurrezione è destinata ad una sconfitta che consentirà la repressione sanguinosa dei bolscevichi e l’affossamento definitivo della rivoluzione. Zinoviev conclude così: “Ci si dice che la maggioranza della popolazione lavoratrice russa è con noi, e che la maggioranza del proletariato internazionale è con noi. Purtroppo entrambe le affermazioni sono sbagliate. Il problema è tutto qui“.
I due oppositori di Lenin ottengono un certo seguito, soprattutto tra gli esponenti del partito senza diritto di voto, che riflettono le realtà locali. Perciò la proposta di Stalin di affidare la decisione sull’insurrezione ai comitati regionali del partito è un’abile mossa per far vincere, senza compromettersi con loro, Kamenev e Zinoviev. Ma Lenin riesce facilmente a farla ritirare, mostrando l’urgenza di una scelta. Poi, in una faticosissima discussione che si protrae nella notte, riesce a portare dalla sua parte Stalin, Bubnov e Berzin, mostrando quanto sia privo di forze e disorganizzato il potere di Kerenskij e spiegando che la passività delle masse è alimentata dall’inerzia dei bolscevichi, ancora in tempo però a rimetterle in moto dando loro, con l’insurrezione, uno spazio per prendersi ciò di cui hanno bisogno. I contadini, poi, non solo non sono coinvolti nella passività di alcune masse di operai e di soldati, ma sono fin troppo attivi, nel senso che il loro movimento sta scavalcando i bolscevichi rimasti inerti.
All’una di notte di martedì 17 ottobre, il secondo dei dieci giorni viene bocciata una mozione che respinge l’insurrezione, affidando la risoluzione dei problemi sociali della Russia all’Assemblea costituente di cui il governo provvisorio ha promesso la prossima convocazione. Quindici i voti contrari a fronte di sei voti favorevoli (Kamenev, Zinoviev, Rykov, Miliutin, Nogin e Volodarskij), e tre astenuti (Bucharin, Muralov e Sciaumian). Dopo altre due ore di discussione, viene messa ai voti la mozione di Lenin per l’insurrezione, che viene approvata con diciannove voti favorevoli e due soli contrari (Kamenev e Zinoviev), con tre astenuti (Bucharin, Nogin e Volodarskij).
Mercoledì 18 ottobre, il terzo dei dieci giorni, sul giornale Novaija Zizn (Vita Nuova), che rappresenta una corrente d’opinione intermedia tra menscevismo e bolscevismo, e desiderosa di vederli d’accordo, compare un lungo articolo firmato da Kamenev e Zinoviev, che mette in guardia il partito bolscevico dal seguire la via insurrezionale decisa dal suo comitato centrale, in quanto porterebbe ad una catastrofica sconfitta della rivoluzione. Lo scopo di Kamenev e di Zinoviev è evidentemente quello di rendere impossibile l’insurrezione rivelandola in anticipo.
Ciò manda su tutte le furie Lenin, che in una lettera ai membri del comitato centrale commenta aspramente l’attacco di Kamenev e Zinoviev: “Attaccare su una questione simile, dopo una decisione già presa e non resa pubblica, in un giornale estraneo al partito ed al cospetto di Kerenskij, non è forse l’azione più perfida che si possa immaginare? Mi riterrei disonorato se, a causa delle mie strette relazioni di un tempo con quei due che non considero più miei compagni, esitassi a condannarli. Dico subito che mi batterò con tutte le mie forze davanti al comitato centrale per la loro espulsione dal partito“.
Il comitato centrale, appositamente riunito la mattina del 20 ottobre (cioè il 2 novembre), boccia la proposta di Lenin di espellere dal partito Kamenev e Zinoviev con sedici voti contro otto. Lenin è esasperato soprattutto dal fatto che l’insurrezione bolscevica, votata dal partito, non sia stata ancora posta in atto, mentre si sta sempre più sviluppando, lungo le immense pianure del Volga, l’insurrezione spontanea dei contadini.
In una Lettera ai compagni scrive: “Il fatto più importante della vita attuale della Russia è l’insurrezione contadina. Essa dimostra, non a parole, ma nei fatti, che il popolo può passare ai bolscevichi se essi lo guidano all’insurrezione [...]. Questo argomento di fatto a favore dell’insurrezione è più forte delle migliaia di tergiversazioni pessimistiche dei bolscevichi spaventati [...]. La fame non attende. La rabbia contadina non attende. La guerra non attende [...]. Simili questioni non possono essere risolte aspettando l’Assemblea costituente, come credono coloro per i quali la vita reale scompare di fronte ad un pezzo di carta sulla convocazione dell’Assemblea costituente“.
Il governo di Kerenskij, con il rifiuto generalizzato dei soldati di fare la guerra e con il diffondersi di lotte contadine per la terra, non ha più alcun potere reale, prova evidente è la sua incapacità di bloccare il processo insurrezionale anche dopo essere venuto a conoscenza del suo avvio. Non ha modo di impedire che sabato 21 ottobre, il sesto dei dieci giorni, si costituisca nella sua capitale un comitato militare rivoluzionario, espressione dei soviet, con poteri di comando sugli armati della città.
Trotzkij, presidente dei soviet di Pietroburgo, li convince a formare il comitato militare rivoluzionario per fronteggiare un probabile colpo di Stato controrivoluzionario. E in quel giorno stesso il comitato militare rivoluzionario chiede a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni di non eseguire ordini da esso non autorizzati, e ciò accade puntualmente nei giorni successivi. Basti pensare che, quando un funzionario governativo riesce ad individuare la casa in cui si nasconde Lenin, non trova nessun reparto disposto a recarsi ad arrestarlo.
Lunedì 23 ottobre, l’ottavo dei dieci giorni, quando Kerenskij millanta all’ambasciatore inglese la sua capacità di schiacciare nel sangue una eventuale rivoluzione bolscevica, l’ambasciatore risponde di augurarsi che questa venga tentata. Ma la rivoluzione, in realtà, è già avvenuta senza che l’ambasciatore se ne sia accorto, e Kerenskij ha già perso di fatto il potere, senza rendersene conto. Il potere effettivo ha già sede, di fatto, a palazzo Smonlyi, requisito dai soviet a un istituto militare per l’addestramento degli ufficiali, e diventato il quartier generale del comitato militare rivoluzionario.
Questo potere si è reso visibile in quella che è passata alla storia come “la domenica dei soviet“, (domenica 22 ottobre alias 4 novembre), quando a Pietroburgo, in una festosa giornata autunnale più soleggiata delle altre, si susseguono affollatissimi comizi dei delegati locali che rivendicano il potere per i soviet, giungono telegrammi dalle più diverse località della Russia che invocano il potere al prossimo congresso dei soviet, e arrivano i primi rappresentanti eletti a quel congresso, tutti decisi a eliminare Kerenskij. Quella domenica nessuno si cura più di obbedire al governo insediato al Palazzo d’Inverno degli zar, e la vita politica cittadina si svolge come se il governo non ci fosse.
All’alba di martedì 24 ottobre, il nono dei dieci giorni (cioè il 6 novembre), il governo passa all’offensiva, inviando un suo reparto armato a chiudere la tipografia dove si stampano le direttive del comitato militare rivoluzionario, tenta di prendersi un potere che non ha più. Dal palazzo Smolnyi parte subito la controffensiva guidata da Trotzkij, il quale, con una tattica perfetta, invia pochi armati a recuperare la tipografia, riuscendoci. Concentra i più a difesa del palazzo, che viene in brevissimo tempo ben trincerato e ordina all’incrociatore Aurora, attraccato al porto, di sbarcare i suoi marinai inviandoli a controllare il Palazzo d’Inverno. Concluse brillantemente tali operazioni difensive, il comitato militare rivoluzionario ferma la sua azione per tutta la giornata, mentre Lenin, ancora nascosto a casa della Fofanova, e non informato di ben tre successive riunioni del comitato centrale bolscevico, arrabbiatissimo fa pervenire ai suoi compagni un concitato biglietto: “Non bisogna attendere!! Si può perdere tutto!!!“.
Non si sa bene per quale motivo il comitato centrale bolscevico abbia lasciato il capo carismatico del partito fuori dalle sue riunioni in tre giorni cruciali come il 21, il 23 e il 24 ottobre. Ha voluto preservare la sua incolumità, essendosi ripetuto un tentativo del governo di arrestarlo? Ha temuto la sua rabbia contro Kamenev e Zinoviev, riammessi da protagonisti alle riunioni? Ha concordato di tenergli nascosti gli ultimi tentativi di compromesso con socialrivoluzionari e menscevichi, ed i conseguenti rinvii dell’azione risolutiva, per metterlo poi eventualmente di fronte al fatto compiuto di un successo di quei tentativi? La questione non è mai stata chiarita in modo conclusivo, ed è probabile che non lo sarà mai più.
La sera del 24 ottobre, poco dopo le ore venti, Jakov Sverdlov decide di trasmettere ai marinai della flotta del Baltico, tutti conquistati alla causa della rivoluzione, l’ordine di venire a Pietroburgo ad abbattere Kerenskij. Si tratta di una mossa che Lenin aveva più volte sollecitato. Sverdlov forza in qualche modo il comitato, portandolo a quella irreversibile scelta insurrezionale, voluta da Lenin, già formalmente approvato? Oppure la decisione definitiva di socialrivoluzionari e menscevichi (esclusi i socialrivoluzionari di sinistra, che ormai formavano un partito a sé) di schierarsi con Kerenskij contro i bolscevichi, convince tutti, Kamenev e Zinoviev compresi, che a questo punto non resta che condurre fino in fondo la scelta insurrezionale?
Si arriva così al decimo giorno, mercoledì 25 ottobre, cioè mercoledì 7 novembre 1917. È da poco passata la mezzanotte, quando a palazzo Smolnyi giunge Lenin. Poco dopo il suo arrivo, non si sa se per suo impulso, o perché così già progettato da Trotzkij, l’insurrezione si sviluppa senza freni. Lo scontro che decide l’esito della rivoluzione avviene tra un numero di armati sorprendentemente ridotto: nessun reparto dell’esercito impegnato contro i tedeschi raggiunge la capitale, non affluiscono militanti bolscevichi da altre regioni, e le guarnigioni della città rimangono neutrali nelle loro caserme, per cui finiscono per fronteggiarsi 2.000 guardie di Kerenskij e 7.000 bolscevichi (4.000 guardie rosse e 3.000 marinai della flotta del Baltico). Trotzkij dirige con eccezionale acume militare gli insorti, riuscendo anche, con grande abilità politica, a far apparire l’insurrezione al servizio non tanto dei bolscevichi quanto dei soviet di tutta la Russia, i cui delegati stanno finendo di raggiungere Pietroburgo per il loro congresso.
Alle due di notte piccoli reparti di bolscevichi si impadroniscono dei depositi di viveri e di munizioni della città, e delle agenzie telegrafiche e di stampa del governo, che viene così subito privato dei suoi strumenti di resistenza e di comunicazione. Alle tre sono occupate tutte le stazioni ferroviarie della città. Alle quattro i bolscevichi prendono possesso della Banca di Stato, e ne sequestrano le riserve auree. Alle cinque vengono occupate le centrali dell’elettricità e dell’acqua. Alle sei ed alle sette le sedi dei ministeri.
Alle nove del mattino, quando l’insurrezione è ormai dilagata vittoriosa a Pietroburgo senza aver dovuto superare alcuna resistenza, Kerenskij non pensa che a salvare se stesso, e fugge dal Palazzo d’Inverno, lasciandovi senza la minima direttiva funzionari, ministri e guardie. Fugge sull’automobile dell’ambasciata americana, protetta dall’immunità diplomatica, che gli consente di passare indenne attraverso il campo dei marinai dell’Aurora.
Alle dieci del mattino di quello storico mercoledì 7 novembre 1917, Lenin stila un comunicato che viene immediatamente diffuso, anche nelle città vicine, in decine di migliaia di volantini:
“Il potere statale è passato nelle mani del comitato militare rivoluzionario dei soviet. Alla causa per cui il popolo ha lottato, l’immediata proposta di una pace democratica e l’abolizione della proprietà fondiaria dei nobili, è stata così garantita la vittoria“.
Nella immensa aula magna del palazzo Smolnyi, affollato fino all’inverosimile da centinaia di delegati convenuti per il congresso dei soviet, da centinaia di guardie rosse bolsceviche, e da centinaia di cittadini desiderosi di informazioni di prima mano, alle ore 14.35, Trotzkij, il comandante vittorioso dell’insurrezione, annuncia tra la sorpresa generale l’ingresso nella sala di Lenin. Un’ovazione che dura per ben sei minuti accoglie il capo del bolscevismo, che, ottenuto il silenzio, con Trotzkij al suo fianco, scandisce emozionato:
“Il potere di Kerenskij è stato abbattuto. Alcuni ministri sono stati arrestati. Quelli ancora a piede libero lo saranno presto. La rivoluzione operaia e contadina, della cui necessità abbiamo sempre parlato, è finalmente compiuta“.
Urla di gioia accolgono quest’ultima frase, in un clima di indescrivibile entusiasmo. Manca la conquista dell’ultima roccaforte del governo, privo del suo capo, il Palazzo d’Inverno, che i marinai del Baltico assediano per tutto il pomeriggio senza attaccarlo, per non spargere sangue inutile. Alla mezzanotte, quando ogni volontà di resistenza del suo presidio è fiaccata, il suo cancello viene sfondato, e il palazzo occupato.
4.2 La rivoluzione russa e la guerra civile
Il governo rivoluzionario bolscevico, insediatosi a Pietroburgo giovedì 8 novembre 1917, ottiene nelle settimane successive il riconoscimento di gran parte delle altre località della Russia, sia pure gradualmente, e spesso dopo aspri scontri dei militanti bolscevichi con gli oppositori. Le elezioni da tempo fissate per l’Assemblea costituente si tengono la domenica 25 novembre 1917, con il sistema proporzionale di assegnazione dei seggi su scrutinio di lista. La lista di maggioranza relativa, risulta, con il 42% dei voti, quella del partito socialrivoluzionario, che ottiene 308 seggi su 707 complessivi. La lista, compilata quando il partito era ancora unito dai suoi dirigenti di destra, ha sacrificato la sinistra socialrivoluzionaria, alleata dei bolscevichi, alla quale vanno soltanto 38 dei 308 seggi ottenuti. La destra socialrivoluzionaria, assai ostile ai bolscevichi, ottiene quindi ben 270 deputati.
Il partito socialrivoluzionario vince in sostanza nelle zone rurali, dove i contadini che gli sono tradizionalmente legati, non sanno della divisone in destra e sinistra, e nemmeno che la destra non vuole legalizzare le loro occupazioni di terre. Secondo partito risulta quello bolscevico, la cui lista ottiene il 24% dei voti e 175 seggi. La distribuzione del voto bolscevico è molto differenziata: tra i soldati le sue percentuali superano di norma il 60%, nei grandi centri operai si attestano attorno al 50%, nei piccoli centri operai attorno al 30%, per scendere sotto il 20% nelle cittadine di provincia e sotto il 10% nelle campagne. Terzo partito risulta sorprendentemente quello cadetto, che ottiene il 14% dei voti e 97 deputati, grazie al consenso plebiscitario dei ceti borghesi ferocemente antibolscevichi.
Molto deludente è il risultato dei menscevichi, la cui lista raccoglie appena il 5% dei voti ottenendo soltanto 36 seggi. Essi, che nell’ultimo periodo si sono spostati a sinistra, assumendo una posizione soltanto moderatamente antibolscevica, hanno infatti perso consensi sia tra gli operai, a favore dei bolscevichi, sia tra i borghesi, a favore dei cadetti. La novantina di seggi rimanenti viene distribuita tra liste minori (22 ad una lista autonoma dei socialrivoluzionari di sinistra presente solo in alcune circoscrizioni, 17 ad una lista kerenskiana, 12 ad una lista monarchica) e liste di nazionalità non russe (40 in tutto).
Domenica 9 dicembre 1917, due settimane dopo l’elezione dell’Assemblea costituente, si svolge a Pietroburgo un congresso dei soviet dei contadini, i cui delegati sono stati eletti nei giorni immediatamente successivi alla rivoluzione d’Ottobre. I socialrivoluzionari hanno ottenuto la maggioranza assoluta del congresso, con il 58% dei consensi. Ma soltanto il 12% dei delegati sono socialrivoluzionari di destra, mentre il 46% sono socialrivoluzionari di sinistra, che vogliono rimanere alleati dei bolscevichi. Poiché questi ultimi hanno ottenuto il 15% dei delegati, l’alleanza tra loro ed i socialrivoluzionari di sinistra forma una solida maggioranza del 61% dei delegati.
Questa maggioranza esprime un comitato esecutivo che dà la sua approvazione alla rivoluzione d’Ottobre, e decide di unirsi al comitato uscito dal congresso generale dei soviet in un unico comitato panrusso dei soviet. Il 19 dicembre 1917, i socialrivoluzionari di sinistra entrano nel governo rivoluzionario. L’accordo di governo prevede concessioni reciproche da parte delle due forze politiche che lo compongono. I socialrivoluzionari di sinistra accettano che i bolscevichi statalizzino le maggiori industrie, centralizzino il potere, mettano fuorilegge gli organi dirigenti del partito cadetto, colpevoli di sabotaggio antigovernativo, e istituiscano una polizia politica, la Commissione straordinaria di lotta alla controrivoluzione e al sabotaggio, le cui iniziali formano la sigla Veceka, abbreviata in Ceka. I bolscevichi, da parte loro, accettano che le norme applicative del decreto sulla terra favoriscano una redistribuzione egualitaria delle terre espropriate, e che sia sancita la separazione tra potere governativo e potere legislativo, affidando quest’ultimo ai soviet.
Di fatto, l’Assemblea costituente, prima ancora di aver cominciato le sedute, è privata di importanti poteri costituenti, in quanto la configurazione essenziale dei rapporti economici e sociali è stata disegnata dai decreti governativi seguìti alla rivoluzione d’Ottobre, e punti fondamentali dell’assetto dello stato sono stati predisposti dall’accordo tra socialrivoluzionari e bolscevichi. Alla sua prima riunione, il venerdì 18 gennaio 1918, l’Assemblea costituente respinge ogni limitazione dei suoi poteri. Il suo presidente, il socialrivoluzionario di destra Viktor Cernov (eletto con 284 voti, dei socialrivoluzionari di destra e dei menscevichi, contro i 235 voti, dei bolscevichi e dei socialrivoluzionari di sinistra), dopo aver acconsentito a far esporre al presidente del comitato panrusso dei soviet Sverdlov, una richiesta di accettazione, da parte dell’Assemblea, degli esiti sociali e politici della rivoluzione d’Ottobre, fa votare ai deputati, il pomeriggio, l’annullamento di tutti i decreti del governo rivoluzionario. Un gravissimo scontro istituzionale, che il comitato panrusso dei soviet, riunitosi d’urgenza la sera di quel giorno, decide di risolvere di forza, con lo scioglimento dell’Assemblea costituente richiesto da Lenin.
Lo scioglimento dell’Assemblea costituente suscita reazioni soltanto tra le forze politiche, le quali tuttavia nei giorni successivi spostano la loro attenzione sulla questione della pace con la Germania. Il governo nato dalla rivoluzione d’Ottobre, mantenendo la promessa bolscevica di far uscire il paese dalla guerra, aveva immediatamente stipulato un armistizio con gli Imperi centrali. Ma gli armistizi esigono, perché la cessazione della guerra sia definitiva, la successiva stipulazione di trattati di pace. La Germania, rifiutando la richiesta bolscevica di una pace generale senza annessioni, pretende quello che i bolscevichi avevano escluso, e cioè una pace separata e annessionistica fino alla rapina.
Lenin ritiene tuttavia tragicamente necessario accettare la pace voluta dai tedeschi, essendo impensabile la continuazione della guerra con un esercito in disfacimento, con soldati che non vogliono più assolutamente combatterla, con la produzione delle armi ridotta, con una drammatica penuria di viveri che non consentirebbe l’approvvigionamento alimentare di milioni di armati, e dopo aver vinto la rivoluzione agitando la parola d’ordine della pace ad ogni costo.
Il comitato centrale bolscevico respinge ripetutamente la proposta di Lenin di sottoscrivere quella che lui stesso definisce “la pace oscena”, e la accetta soltanto quando i tedeschi, ripresa l’offensiva militare, travolgono facilmente ogni tentativo di resistenza, devastano territori, e minacciano la capitale. La pace stipulata a Brest Litovsk tra la Russia e gli Imperi centrali domenica 3 marzo 1918 impone alla Russia la rinuncia alle regioni della Polonia, della Lituania, della Volinia, della Podolia, della Lettonia, dell’Estonia e dell’Ucraina. I tedeschi, poi, lasciano a questi paesi una formale autonomia, ma insediandovi governi di loro scelta e sostenuti dal loro esercito, che servano da copertura ad una sistematica e terroristica spoliazione di risorse a favore della Germania.
Il settimo congresso del partito bolscevico, tenutosi dal 6 al 9 marzo 1918, oltre a cambiare il nome del partito bolscevico in comunista, ad adottare il calendario gregoriano, ad approvare l’istituzione di squadre annonarie incaricate di prelevare di forza nelle campagne le risorse alimentari necessarie alle popolazioni urbane, e deliberare il trasferimento della capitale da Pietroburgo, troppo vicina alle più avanzate postazioni dell’esercito tedesco, a Mosca, dà il suo assenso alla ratifica del trattato di Brest Litovsk, compiuta poi il successivo 19 marzo dal congresso dei soviet.
La pace oscena con la Germania provoca drammatiche lacerazioni politiche. Attorno a Nikolaj Bucharin, che si era battuto per la guerra rivoluzionaria alla Germania, si forma una corrente di comunisti di sinistra che contesta a Lenin, oltre alla pace di Brest Litovsk, anche il ritardo nella statalizzazione dell’industria russa. Il 19 marzo 1918, quando il congresso dei soviet ratifica la pace di Brest Litovsk, i socialrivoluzionari di sinistra per protesta escono dal governo, al quale rimproverano anche le requisizioni forzate di risorse alimentari ai contadini, e rompono, tre mesi esatti dopo averla stabilita, l’alleanza con i bolscevichi, ormai chiamati comunisti, passando all’opposizione. Lo scontro politico diventa d’ora in poi sempre più feroce: i partiti antibolscevichi trasformano la loro opposizione in aperto sabotaggio, a cui il governo risponde con la violenza dei reparti della Ceka; i soviet a maggioranza socialrivoluzionaria o menscevica vengono sciolti, e gli altri vengono ridotti di fatto ad organi di mera esecuzione delle direttive del partito comunista, in cui si va concentrando tutto il potere. Tra la fine di maggio e i primi di giugno del 1918 lo stato di guerra civile latente sfocia nel vero e proprio scontro militare tra contrapposte forze armate in lotta per il potere.
L’episodio da cui convenzionalmente si fa iniziare la guerra civile in Russia è l’occupazione della città di Celiabinsk, immediatamente ad est degli Urali meridionali, il 26 maggio 1918, da parte della cosiddetta legione cecoslovacca. Questa unità militare è costituita da 40.000 soldati cechi e slovacchi dell’esercito austro-ungarico, che, rifiutatisi ad un certo punto di continuare a combattere per la monarchia asburgica, e consegnatisi ai russi, sono stati convinti da una missione militare francese a Mosca ad organizzarsi come piccola armata, e a tornare in Europa a combattere per l’Intesa, le cui navi li avrebbero raccolti a Vladivostok, porto russo sul mar del Giappone. Prima della pace di Brest Litovsk, il governo rivoluzionario russo ha favorito il progetto, promettendo l’uso della ferrovia transiberiana per far raggiungere più rapidamente Vladivostok ai cecoslovacchi, nella speranza di ottenere in cambio un intervento militare dell’Intesa capace di bloccare l’avanzata tedesca verso Pietroburgo.
Nel marzo, però, la questione appare in tutt’altra luce. Gli inglesi, infatti, sbarcano un corpo militare nella lontana Murmansk, vicino all’estremo nord della Finlandia. Il consiglio di guerra dell’Intesa, riunito a Londra, accetta, su proposta di Clemenceau, l’idea di una occupazione giapponese di Vladivostok. Il ministro degli esteri russo Trotzkij comincia allora a temere che la legione cecoslovacca possa servire all’Intesa non contro la Germania, ma per aprire la strada ad una spartizione della Russia tra le potenze dell’Intesa stessa. Egli consente allora, il 26 marzo, il viaggio a Vladivostok dei cecoslovacchi soltanto se disarmati: essi dovranno cioè ricostituirsi come unità combattente quando avranno raggiunto l’Europa. Questa direttiva dà luogo ad infinite controversie tra i soviet locali ed i cecoslovacchi, i quali, dopo essere rimasti bloccati per settimane lungo le stazioni della ferrovia transiberiana, si esasperano, anche perché degli agenti dell’Intesa fanno loro credere che i russi, ormai alleati dei tedeschi, li riconsegneranno prima o poi agli Imperi centrali. A questo punto si moltiplicano gli incidenti tra i loro reparti e le autorità locali.
A Celiabinsk, il 26 maggio 1918, tutto comincia con uno di questi incidenti. È domenica, ed un prigioniero ungherese dei cecoslovacchi, bastonato perché protesta per la mancanza del consueto supplemento festivo della scarsissima razione di cibo, uccide un soldato ceco. I compagni del soldato ucciso si vendicano massacrando altri loro prigionieri ungheresi, e inseguendo fin dentro la città altri prigionieri che si sono dati alla fuga. Le autorità cittadine intervengono per segregare i cecoslovacchi, in base ad un’ordinanza emanata proprio il giorno prima da Trotzkij, secondo cui “ogni reparto cecoslovacco, in cui sia scoperto anche un solo uomo armato, deve essere rinchiuso in un campo di prigionia”. Ma i cecoslovacchi massacrano i membri del soviet locale, e si impadroniscono a mano armata della città.
All’occupazione di Celiabinsk segue quella di altre città lungo la ferrovia transiberiana, fino, ad est, alla steppa dell’Irtys, e, ad ovest, alla pianura del Volga. L’occupazione più clamorosa è quella di Samara, che avviene senza colpo ferire, sabato 8 giugno 1918, con l’appoggio della borghesia locale. Da Samara si passa a diverse altre località della regione del Volga, dopo che anche la regione del Don di etnia cosacca è passata alla controrivoluzione, sotto il comando del generale zarista Krasnov. Il governo comunista reagisce con la massima violenza, ristabilendo, il 21 giugno 1918, la pena di morte, incoraggiando l’esecuzione sommaria di tutti coloro che si ribellano al suo potere, e facendo uccidere lo zar Nicola II con tutta la sua famiglia, il 18 luglio 1918, a Ekaterinburg, sul versante orientale degli Urali, quando la città sta per essere presa da reparti cecoslovacchi venuti da Celiabinsk, per impedire alle forze controrivoluzionarie di raccogliersi attorno a qualsiasi figura o simbolo del passato regime.
La costituzione approvata in quella estate dal congresso dei soviet riflette già il mutamento che i princípi ispiratori della rivoluzione d’Ottobre hanno subíto nel gorgo della guerra civile. Essa fonda infatti uno Stato chiamato Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (U.R.S.S.) proprio quando i soviet sono stati espropriati del potere. La direzione dello Stato spetta, infatti, secondo tale costituzione, non già ai soviet, ma al partito comunista, chiamato a garantire il processo di trasformazione del paese in senso socialista (l’Unione sovietica si chiama socialista – si dice infatti – non perché lo sia già, ma perché mira a diventare socialista, sotto la guida appunto del partito comunista). Il governo è un’emanazione non già dello Stato, ma del partito comunista, ed ai soviet spetta soltanto il potere legislativo. Il congresso dei soviet è eletto a suffragio universale maschile e femminile (con esclusione di nobili, preti, carcerati e chiunque guadagni con il lavoro altrui), ma il potere legislativo spetta al suo comitato esecutivo, su proposta del governo, che in certi casi può legiferare autonomamente.
4.3 Lenin al governo
Lenin diventa capo del governo russo giovedì 8 novembre 1917, con un mutamento di situazione così enorme e rapido da non avere eguali nella storia. Basti pensare che, se l’11 novembre egli riceve nella capitale ogni sorta di felicitazioni e riconoscimenti come massima autorità del paese, soltanto la domenica prima, era ancora, a Pietroburgo, un clandestino che la polizia aveva cercato di arrestare. Le testimonianze concordano però nel presentarci un Lenin a cui il potere non dà alla testa né lo corrompe. Egli aderisce all’ideale di una trasformazione del mondo intero in una universale società solidale senza sfruttatori e sfruttati, al punto da non calcolare più i rischi personali, come era solito fare. Né si illude sulla solidità del potere che ha conquistato, perché ritiene anzi che, essendo la Russia un paese arretrato, con uno scarso sviluppo del moderno proletariato di fabbrica, vi sia più probabile, nel breve periodo, una vittoria della controrivoluzione.
Lo scopo della rivoluzione d’Ottobre è, per lui, più esterno che interno alla Russia, in quanto consiste essenzialmente in un potente impulso alla rivoluzione socialista nei più avanzati paesi europei, con l’aiuto dei quali, poi, la rivoluzione potrà rinascere dalle sue ceneri anche in Russia, con altri protagonisti. Egli considera quindi il potere che ha conquistato ben circoscritto nella sua funzione storica e nella sua durata: numera i giorni in cui il suo governo rivoluzionario rimane in piedi, per vedere se arriveranno almeno ad eguagliare la durata della Comune di Parigi, esistita tra il marzo e il maggio 1871.
Il suo tenore di vita rimane quanto mai morigerato. Si prende, come luogo nello stesso tempo di abitazione, condivisa con la moglie e la cognata, e di disbrigo delle pratiche burocratiche di capo del governo, appena due stanze con l’aggiunta di un bagno e di una cucina, al secondo piano dell’ala nord di palazzo Smolnyi, l’edificio che rappresenta il centro pulsante della politica rivoluzionaria: gli basta varcare la porta del suo appartamento per trovarsi in un corridoio in cui ci sono da un lato l’appartamento del ministro degli esteri Trotzkij e quello del ministro della giustizia Lomov, e dall’altro la sala d’aspetto dei funzionari che vogliono conferire col capo del governo e la grande sala per le riunioni del governo; e gli basta scendere una rampa di scale per trovare, al primo piano, le sale di riunione del comitato centrale del partito e del comitato esecutivo dei soviet. Si prende, inoltre, come figura di servizio, soltanto una segretaria (Margherita Fofanova, nel cui appartamento si era nascosto prima dell’insurrezione, incaricata di battergli a macchina i testi e conservargli i documenti), un autista (Stepan Gil, marinaio bolscevico, incaricato di condurlo su una vecchia limousine nelle località distanti dove è richiesta la sua presenza), e un assistente personale (Vladimir Bonc Bruevic, vecchio amico della famiglia Uljanov, incaricato di risolvergli i problemi pratici).
La sua salute peggiora dopo che è diventato capo del governo, tanto è vero che in dicembre la moglie deve condurlo, come si è visto, a riprender forza in un sanatorio finlandese, con qualche giorno di ricovero e di riposo. Lo tormentano l’emicrania, la gastrite e l’insonnia. Si dice che ciò dipenda dall’enorme carico di lavoro che deve svolgere, perché la vita economica, sociale e politica della Russia postrivoluzionaria è una continua emergenza, e perché tutte le autorità del paese fanno riferimento a lui. C’è però anche una ragione più profonda della sua cattiva salute, che è in parte la ricaduta fisica di un suo profondo malessere psicologico. Man mano che passano le settimane, infatti, i suoi grandi ideali si scontrano con condizioni concrete estremamente difficili. Manca un apparato statale per mezzo del quale far eseguire le direttive, perché il crollo dello zarismo ha provocato lo sfacelo della macchina burocratica. Inoltre i pezzi di apparato statale ancora funzionanti, timorosi di perdere sotto il nuovo regime privilegi economici e poteri arbitrari, lo sabotano selvaggiamente.
Quasi tutti i funzionari scioperano ininterrottamente, e quelli del ministero dell’assistenza sociale impediscono fisicamente al nuovo ministro, Aleksandra Kollontaj, di entrare nel loro edificio, sostenendo che una donna non può essere ministro. Di fronte al caos che rischia di travolgere la rivoluzione Lenin fa leva sull’unico strumento che ha, il suo partito, la cui disciplina di tipo militare garantisce almeno l’esecuzione degli ordini. Ma la forza del partito dipende dalle centinaia di migliaia di nuovi militanti – popolani duri e rozzi, mossi da idee di giustizia sincere ma semplicistiche e mescolate ad esigenze plebee – che vi sono entrati con le grandi lotte del 1917, e che hanno sommerso l’originario nucleo di poche migliaia di membri intellettualmente preparati.
Lenin è continuamente irritato dai modi di fare dei dirigenti usciti da queste leve. Non sopporta i loro lunghi discorsi pieni di autocompiacimento, e i loro diverbi su questioni banali, tanto che impone un limite massimo di dieci minuti per ogni rapporto sulle attività svolte, estendendolo anche ai rapporti dei ministri nelle riunioni di governo, e si sforza di circoscrivere le discussioni alle questioni essenziali.
Un momento drammatico della vita di Lenin si ha quando egli deve convincere il partito a sottomettere la Russia alla pace separata e annessionista imposta dalla Germania. Non può non ripugnargli intimamente, infatti, doversi battere perché il paese pieghi la testa di fronte ai “briganti” tedeschi, e ceda loro regioni in cui si trovano complessivamente metà delle sue risorse agricole, con prevedibili effetti di grave penuria alimentare. Né può non sentirsi a disagio nel dover contare sul sostegno proprio degli uomini che, come Kamenev e Zinovev prima di tutto, e poi anche Stalin, Nogin e altri lo hanno intralciato nella rivoluzione d’Ottobre, e nel doversi scontrare frontalmente proprio con i comunisti di cui ha maggiore stima intellettuale e morale, primo tra tutti Bucharin. E tuttavia ritiene di doversi battere con la massima asprezza contro costoro, perché proprio il loro nobile idealismo porterebbe alla catastrofe: se la Russia non si sottomettesse alle condizioni di pace volute dalla Germania, ne sarebbe conquistata, e i tedeschi non esiterebbero ad annientare in un bagno di sangue, a Pietroburgo, un’intera generazione di rivoluzionari.
Nel marzo 1918, poiché Pietroburgo è assai vicina alle postazioni avanzate dell’esercito tedesco, del quale i comunisti russi non si fidano, pur avendo firmato un trattato di pace con clausole favorevolissime alla Germania, la capitale viene trasferita nella più sicura Mosca. Gli organi di governo vengono insediati nel Cremlino, una grande fortezza triangolare che si erge nel centro della città, e che contiene al suo interno diversi splendidi edifici antichi. Lenin si sistema, con la moglie e la cognata, in un comodo appartamento di tre camere con ingresso, cucina e bagno.
La più comoda situazione di vita del Cremlino di Mosca rispetto a quella dello Smolnyi di Pietroburgo non lo sottrae ad una crescente usura psicofisica. Nella primavera e nell’estate del 1918, infatti, si moltiplicano gli attacchi armati, dall’interno e dall’esterno, contro il suo governo, le città sono letteralmente alla fame, le campagne non cedono prodotti alimentari ai rapporti di scambio fissati dal governo, il quale, d’altra parte, non ha i mezzi per acquistarli a condizioni che ne sollecitino la cessione volontaria, e ricorre perciò a requisizioni forzate sempre più brutali. Di fronte a questi frangenti, Lenin vive sempre più in preda all’angoscia, alla frustrazione ed al risentimento, e le sue scelte avvengono talvolta, anche se non sempre né prevalentemente, sotto la spinta di uno stato interiore incollerito, esasperato e vendicativo.
Documenti usciti dagli archivi russi dopo la caduta del comunismo ce ne mostrano una inedita spietatezza. Ad esempio, al comitato esecutivo del soviet di Penza, dove si erano verificate insurrezioni rurali contro le requisizioni forzate, invia un telegramma in cui è detto tra l’altro: “Impiccate, e assicuratevi che le impiccagioni avvengano sotto gli occhi del popolo, non meno di cento ricconi e succhiasangue“. E, alla notizia di una rivolta menscevica a Novgorod, scrive il seguente telegramma per il locale soviet: “Neanche un minuto di indugio. Bisogna reagire con la massima energia: perquisizioni di massa, e fucilazione immediata per chi sia trovato in possesso di armi“. Si è anche scoperto che l’eccidio dell’intera famiglia dello zar, un tempo attribuito all’iniziativa locale dei bolscevichi in ritirata da Ekaterinburg, è stato invece deciso dal comitato centrale del partito, da tempo impegnato a discuterne l’opportunità o meno, e dotato di una linea diretta di comunicazione con i dirigenti degli Urali.
La violenza da cui Lenin si lascia prendere nasce in un contesto storico di feroci scontri sociali, di totale instabilità dei rapporti di potere, e di gravissime minacce armate alla rivoluzione. In questo contesto egli non ha alcun altro punto d’appoggio, per fronteggiare difficoltà inaudite e respingere attacchi tremendi, che il partito comunista, e ciò lo induce ad identificare la salvezza della rivoluzione con la conservazione del potere da parte del partito comunista. Una tale identificazione attribuisce illusoriamente al partito comunista una natura rivoluzionaria indipendente dalla sua concreta e variabile conformazione storica, e pone le premesse perché la dittatura del partito sulla società e sullo Stato trapassi da fatto di emergenza in un regime stabilmente oppressivo.
Venerdì 30 agosto 1918, nella tarda mattinata, Lenin esce dal cortile di una fabbrica dove ha tenuto un comizio. Si sta avvicinando alla sua automobile quando gli vengono sparati, da uno o più attentatori appostati dietro un muricciolo alle sue spalle, cinque colpi d’arma da fuoco, due dei quali lo colpiscono. Una pallottola gli si conficca alla base del collo, e un’altra raggiunge il polmone sinistro. Militanti comunisti scattano subito dal cortile della fabbrica, lo circondano in modo da fargli scudo con i loro corpi contro altri eventuali colpi, e lo depongono sul sedile posteriore dell’automobile. Lenin sta perdendo molto sangue, ma il suo autista Stepan Gil non lo porta in ospedale, per timore che nei suoi pressi siano appostati altri attentatori, ma lo porta nel suo appartamento al Cremlino.
Vladimir Bonc Bruevic, suo assistente personale, chiama la moglie, che è medico, per le prime cure. Due giorni dopo Lenin è fuori pericolo, e venti giorni dopo è in grado di affrontare un viaggio che lo conduce in una località adatta per la convalescenza. Intanto si scatena, in risposta all’attentato, il “Terrore rosso”. Si conclude qui questo lungo articolo su Lenin come genio della rivoluzione. Spero di poter affrontare in un vicino futuro l’evolversi della rivoluzione bolscevica, alla quale purtroppo Lenin, che morirà nel 1924, potrà contribuire soltanto parzialmente. Resta fondamentale la sua capacità, la sua genialità, nell’aver saputo analizzare concretamente la situazione determinatasi in Russia con l’entrata in guerra e di aver guidato il partito bolscevico, talvolta riluttante, a volte addirittura contrario alle sue tesi, ed in sintonia con le esigenze fondamentali del popolo russo, al trionfo della rivoluzione.
Parte Terza
1. La guerra civile
Della “data di nascita” della guerra civile e dei suoi sviluppi, ce ne siamo occupati nel paragrafo 4.2 La rivoluzione russa e la guerra civile della Parte seconda. Riprendiamo ora il discorso a partire dal «Terrore rosso» scatenato dal potere comunista dopo l’attentato a Lenin del 30 agosto 1918, con migliaia e migliaia di anticomunisti processati direttamente dalla Ceka e condannati a morte per fucilazione, che si colloca in una guerra civile che ormai sconvolge l’intera Russia.
Nell’estate 1918, infatti, vasti territori del paese sono in mano alle opposizioni armate. I resti del vecchio esercito zarista, raccolti dal generale Kornilov, alla morte di questi sono guidati dal generale Anton Denikin, che ne ha assunto il comando, nella regione cosacca del Don, dove viene riconosciuta la sua autorità, e gli viene fornito sostegno. I cosacchi, infatti, erano ferocemente contrari al potere bolscevico, perché sapevano che avrebbero perduto, sotto di esso, lo speciale rapporto con lo Stato che gli zar avevano loro garantito: in cambio del servizio militare da loro prestato nell’esercito zarista, con tutte le spese di equipaggiamento a loro carico, erano esentati dalle imposte e avevano ottenuto i migliori fondi agricoli.
l reparti cecoslovacchi che hanno occupato in primavera i principali centri urbani lungo la linea ferroviaria transiberiana, nella regione meridionale siberiana si sono posti agli ordini, in estate, di un governo di generali zaristi formatosi ad Omsk sotto la presidenza dell’ammiraglio Aleksandr Kolcak. Il governo del Kolmuc a Samara sul Volga stabilisce stretti rapporti con quello di Omsk, fino al punto da accogliere tra i propri membri un suo rappresentante. Per fronteggiare questa drammatica situazione, ma anche semplicemente per garantire la sussistenza al proprio apparato di potere in un contesto di spaventoso regresso economico e di forte degrado sociale, il governo instaura il cosiddetto «comunismo di guerra».
1.1 Il comunismo di guerra
Si tratta di una forma di organizzazione della vita associata a cui la Russia sotto il controllo bolscevico rimane sottomessa per quasi tre anni, dall’inizio dell’estate 1918 all’inizio della primavera 1921, e che consiste nel completo dominio del partito comunista sullo Stato, nella militarizzazione dello Stato-partito, e nella sua gestione diretta, in assenza totale di qualsiasi scambio mercantile, della produzione industriale e della distribuzione dei beni economici. Dopo il crollo della Germania, il «comunismo di guerra» deve fronteggiare non soltanto le rivolte interne, ma anche l’intervento militare delle potenze dell’Intesa non più impegnate nel conflitto europeo.
Prospettato appena cinque giorni dopo la fine della Grande guerra, il 16 novembre 1918, in un esplicito e crudele comunicato del comando supremo alleato che dice: «Se l’Intesa vuole conservare i frutti della vittoria conquistata con così grande sacrificio, deve isolare il bolscevismo con un cordone sanitario che lo condanni a perire d’inedia, e deve costituire in Russia nuclei di forze armate alleate attorno a cui gli elementi sani del paese potranno riorganizzarlo sotto l’egida dell’Intesa».
Lo scopo dei vincitori della Grande guerra è dunque chiaro: la riorganizzazione della Russia «sotto l’egida dell’Intesa», cioè in funzione degli interessi economici e politici delle potenze vincitrici. I mezzi che essi intendono usare sono due: i «nuclei di forze armate alleate» in territorio russo, e il «cordone sanitario» che lo riduca a «perire d’inedia». Il termine «cordone sanitario», usato nel linguaggio medico per indicare l’isolamento di un focolaio di infezione, intende presentare il comunismo russo come un’infezione ideologica e sociale da cui l’Europa deve difendersi con una barriera protettiva che ne uccida sul nascere i germi. L’immediata applicazione del «cordone sanitario» porta al sequestro delle poche navi sovietiche che alimentavano piccoli rivoli di scambi con l’Europa, e al blocco totale dell’invio di viveri e medicinali ad un paese sconvolto dalle carestie e dalle epidemie, oltreché dalla guerra.
Peccato che oggi, in tempo di pandemia, l’espressione “cordone sanitario” che doveva ritenersi una pratica utile oltre che necessaria sia stata interpretata come un espediente del potere per limitare la libertà dei cittadini, a fronte di un insignificante virus! Ma torniamo alla Russia, divenuta ormai URSS, del 1918
Inghilterra, Francia e Giappone (Stati Uniti e Italia mantengono una posizione più defilata) vogliono a tutti i costi evitare che una rivoluzione anticapitalistica risulti vittoriosa, e che un paese immenso come la Russia esca dal mercato mondiale. Il Giappone, che non era stato impegnato nella guerra in Europa, già nell’aprile 1918 aveva fatto sbarcare una forza armata di 70.000 uomini a Vladivostok, con l’intenzione di accaparrarsi le risorse minerarie siberiane. L’Inghilterra e la Francia inviano le loro forze nel novembre 1918, dopo la fine della guerra con la Germania: la flotta francese, entrata nel Mar Nero, sbarca un corpo di spedizione ad Odessa, per alimentare la rivolta del generale Denikin nella regione del Don; la flotta inglese, entrata nel Mar Bianco, sbarca un corpo di spedizione ad Arcangelo, con l’intento di avanzare in direzione sudovest per portare sostegno ad un esercito russo appena organizzato nei paesi baltici, con il supporto finanziario e logistico dell’Intesa, dal generale Iudenic; il Giappone, da parte sua, appoggia il governo siberiano dell’ammiraglio Kolcak, che si annette anche, con un colpo di forza compiuto in quello stesso novembre 1918, i territori del Volga governati fino a quel momento dal Komuc.
Per affrontare questo schieramento di forze non bastano certo al governo comunista le guardie rosse di Mosca e Pietroburgo ed i reparti provinciali della Ceka. Trotzkij, che ha lasciato a Georgij Cicerin il ministero degli esteri per assumere quello della guerra, organizza quindi, in tempi rapidissimi, un vero e proprio esercito, denominato Armata rossa, sulla base di due criteri fortemente criticati dai comunisti di sinistra di Bucharin e da molti altri militanti comunisti, e divenuti operanti soltanto per l’appoggio decisivo di Lenin.
Il primo criterio è quello di fare dell’Armata rossa non un esercito partigiano predisposto alla guerriglia, ma un esercito regolare idoneo alle battaglie campali, con gerarchie rigidamente stabilite. Il secondo criterio è il reimpiego nell’Armata rossa di quegli ufficiali dell’esercito zarista che si mostrino disposti a servire il nuovo regime. Gli ufficiali dell’Armata rossa sono comunque controllati da altrettanti commissari politici, che ne devono controfirmare tutti gli atti. Al vertice dei commissari politici è posto Stalin, il quale esercita così un grande potere sul personale dell’Armata rossa. Ed è proprio grazie all’efficacia di questi criteri, ed allo straordinario talento militare rivelato da Trotzkij, che il governo comunista si trova rapidamente a disporre di un esercito consistente ed efficiente, con il quale nell’inverno 1918-19 recupera parte dei territori perduti.
La guerra civile russa viene così a configurarsi come guerra tra l’Armata rossa di Trotzkij da un lato, e le armate dette «bianche» di Iudenic, aiutato dagli inglesi, nei paesi baltici, di Denikin, aiutato dai francesi, nella regione del Don, e di Kolcak, aiutato dai giapponesi, nell’area uralico-siberiana. Quest’ultimo sferra una grande offensiva nella primavera del 1919, ma, dopo iniziali successi, deve battere in ritirata. Nel frattempo Denikin conquista l’Ucraina, che il governo comunista aveva ripreso ai tedeschi quando, nell’autunno precedente, crollata la Germania, aveva denunciato il trattato di Brest-Litovsk. Dall’Ucraina sferra, nel giugno, un’offensiva che lo porta a raggiungere, in settembre, la città di Orel, quattrocento chilometri a sud di Mosca.
A questo punto gli inglesi compiono il massimo sforzo militare e diplomatico per distruggere l’Unione sovietica: convincono i governi della Lettonia e dell’Estonia a fornire contingenti armati al generale Iudenic, al quale essi fanno pervenire un parco di artiglieria e numerosi carri armati. Iudenic sferra allora un’offensiva in direzione di Pietroburgo che dà l’impressione di essere risolutiva. L’ottobre 1919 rappresenta il momento di massimo rischio per la vita dell’Unione sovietica. Con le forze di Denikin che minacciano ormai Mosca da sud, con le forze di Iudenic alle porte di Pietroburgo, e con un crescente impegno antisovietico anglo-francese, lo stesso Lenin comincia a pensare che la partita sia perduta, al punto da predisporre organizzativamente e finanziariamente il ritorno del partito comunista alla lotta clandestina.
Chi ha fiducia nella vittoria è invece Trotzkij, che si batte come un leone, si sposta infaticabilmente da un fronte all’altro e, rivelando una eccezionale abilità strategica, riesce a capovolgere la situazione. L’inverno 1919-20 vede straordinari successi dell’Armata rossa: Iudenic, ripetutamente sconfitto, abbandona il campo e va in esilio, dopo che gli inglesi si sono reimbarcati; Denikin, dopo aver visto distrutti interi suoi reparti e reimbarcati i francesi, raccoglie le sue residue forze in Crimea e, ritiratosi dalla lotta, le affida al generale Vrangel; Kolcak, perse tutte le sue divisioni, viene inseguito implacabilmente dai comunisti che, nel febbraio 1920, lo catturano nella lontana Irkutsk, a duecento chilometri dal confine con la Mongolia, e lo fucilano.
La guerra viene tuttavia riaccesa nella primavera del 1920, perché l’Intesa riesce a scagliare contro la Russia gli Stati confinanti sorti per secessione al crollo dell’Impero zarista. Dopo nuove, drammatiche vicende, meno pericolose per l’Unione sovietica, comunque, di quelle dell’anno prima, la guerra civile è definitivamente vinta dai comunisti all’inizio del nuovo anno. Nel marzo 1921, il X congresso del partito comunista russo, celebrando la vittoria, decreta l’abolizione del «comunismo di guerra», perché, dice Lenin parlando ai congressisti, «ci troviamo in tali condizioni di impoverimento e distruzione delle forze produttive, che per un certo periodo bisogna subordinare ogni altra considerazione alla necessità assoluta di far aumentare, con qualsiasi mezzo, la quantità di derrate alimentari a disposizione del popolo». La guerra civile ha lasciato la Russia alla fame, e i contadini non hanno più eccedenze che lo Stato-partito possa loro togliere di forza e avvalersene per alimentare le città, per cui senza consentire loro di produrre di più il paese morirebbe.
1.2 La Nuova Politica Economica (NEP)
Ottenuta dal X congresso una distratta approvazione, poco prima della conclusione dei lavori, della sua proposta di abolizione del «comunismo di guerra», del cui grosso significato sociale e politico i delegati non si rendono evidentemente conto, Lenin lancia, il mese successivo, la cosiddetta NEP (Nuova Politica Economica), i cui capisaldi, subito approvati dal governo e dal comitato esecutivo dei soviet, sono:
- una modesta imposta in natura a carico dei contadini;
- il divieto di requisizione ai contadini che abbiano pagato l’imposta dovuta allo Stato;
- il libero smercio a prezzi liberi dei prodotti rimasti ai contadini, da quello che hanno consumato e da quello che hanno pagato come imposta, della loro produzione agricola;
- il libero smercio a prezzi liberi dei prodotti artigiani;
- la privatizzazione delle industrie capitalistiche che, statizzate all’inizio del «comunismo di guerra», avevano dimensioni molto piccole, con meno di dieci dipendenti salariati.
La NEP rappresenta, in sostanza, un ritorno, dovuto ad una assoluta necessità economica, all’idea originaria della rivoluzione d’Ottobre di promuovere in Russia un capitalismo autonomo dal capitale straniero e sotto 1′egida dello Stato, dopo la scorciatoia di una totale abolizione dei rapporti mercantili praticata con il «comunismo di guerra», dovuto, anch’esso, ad una assoluta necessità economica (quello di non far morire di fame le città, a favore delle quali non sarebbe servita una imposta in natura, mancando all’epoca uno stabile e professionale apparato statuale capace di riscuoterla).
La NEP non manifesta subito i suoi effetti positivi. Le terribili devastazioni provocate da tre anni di crudelissima guerra civile non consentono la formazione di alcuna eccedenza vendibile nelle campagne. Il mercato dei prodotti agricoli, quindi, benché nuovamente autorizzato dalla legge, continua a non esistere nei fatti, perché mancano le merci che lo dovrebbero costituire. I viveri necessari alle città, perciò, non potendo essere acquistati in mercati che non ci sono, e non potendo essere ottenuti che in minima parte da un’imposta in natura il cui gettito è all’inizio bassissimo, per mancanza di organizzazione dei percettori e miseria dei contribuenti, continuano per mesi ad essere prelevati di forza nonostante il divieto della legge.
Ciò che viene prelevato, però, a questo punto non è più l’eccedente, ma lo strettamente necessario. Lo strettamente necessario, inoltre, viene eroso non soltanto dal prolungarsi delle requisizioni, ma anche da una terribile siccità che colpisce le campagne russe nell’estate 1921. La concatenazione di queste vicende porta nell’autunno 1921 ad una vera e propria grande carestia, la prima del genere dopo quella del 1891, che continua ad aggravarsi fino all’estate 1922, quando raggiunge il suo culmine, coinvolgendo 30 milioni di persone e facendo 6 milioni di morti. Altri due milioni di morti sono provocati dal tifo e dal colera, che si propagano a macchia d’olio su corpi debilitati.
Soltanto nel 1923 la Russia esce dalla carestia, l’economia si riprende, e la NEP, cominciando a funzionare, ne promuove lo sviluppo. Ma la realtà del paese è lontana dagli ideali in nome dei quali sei anni prima i bolscevichi avevano preso il potere. La residua democrazia ancora flebilmente operante negli anni del «comunismo di guerra» è completamente soppressa prima del concreto avvio della NEP. Mentre si svolge il X Congresso del partito comunista, la rivolta dei marinai della base navale di Kronstadt, già protagonisti della rivoluzione d’Ottobre, ed ora sostenitori di una rinascita di soviet pluralisti contro il dominio di un solo partito, viene repressa nel sangue, e centinaia di insorti sono fucilati dopo essersi arresi. Menscevichi e socialrivoluzionari non sono più uccisi soltanto quando si levano in armi contro il governo, ma sono messi fuori legge come tali, insieme a qualsiasi altro partito che non sia quello comunista. Lo stesso partito comunista si dà, nel suo citato X Congresso del marzo 1921, nuove regole antidemocratiche che ne vietano le frazioni e colpiscono il dissenso politico dal gruppo dirigente con misure amministrative ed espulsive.
Non c’è alcuna contraddizione tra l’avvio di una liberalizzazione economica e l’instaurazione di una totale dittatura politica. Questa, infatti, è pensata come necessaria proprio per evitare le spinte centrifughe della liberalizzazione economica, che si accentuerebbero se i diversi nuovi interessi economici privati, destinati ad emergere con il ritorno al mercato, potessero farsi rappresentare nello Stato dalle diverse fazioni di un pluralismo politico.
L’Unione sovietica è ora un paese la cui vita economica e sociale è divisa in due grandi settori culturalmente non comunicanti: quello contadino, per lo più analfabeta e spinto da pulsioni individualistiche più forti ancora che al tempo dello zarismo, e quello collettivisticamente organizzato, ma con un collettivo da caserma, dal partito-Stato. Questo esito non corrisponde affatto ai progetti di trasformazione sociale indicati da Marx e dallo stesso Lenin.
La rivoluzione russa se ne è sempre più allontanata dal 1918 in poi, sotto la pressione di terribili contingenze storiche, ed i suoi capi ne hanno sempre più affidato la futura realizzazione non alle forze presenti in Russia, ma alla rivoluzione proletaria dei paesi economicamente e socialmente più sviluppati. Soltanto l’aiuto di nuovi paesi socialisti dotati di effettive risorse economiche, si pensa, potrà far uscire la Russia dall’isolamento e avviarla sulla strada del socialismo, che non potrebbe percorrere con le sue sole forze, essendo troppo arretrata.
1.3 La Terza Internazionale
Quando Bucharin scriverà, nel 1923, che «la rivoluzione socialista internazionale, ed essa soltanto, è la nostra salvezza», esprimerà una convinzione che ha guidato tutto il gruppo dirigente bolscevico. Su questa base era nata a Mosca, nel marzo 1919, la Terza Internazionale proletaria (terza perché c’era stata la Prima Internazionale fondata nel 1864 tra gli altri da Marx, e dissolta dalle contrastanti valutazioni della Comune di Parigi del 1871, ed una Seconda Internazionale fondata nel 1889 sotto la guida del partito socialdemocratico tedesco, e crollata nel 1914 per l’adesione dei suoi partiti agli opposti schieramenti bellici). Si tratta della Internazionale comunista, contrapposta a quella socialdemocratica di prima della guerra, e costituita appunto per dirigere la rivoluzione internazionale. Alla sua fondazione avevano partecipato i pochi partiti comunisti fino ad allora costituiti, e cioè il tedesco, l’austriaco, l’ungherese, il polacco, lo svizzero, l’olandese, il serbo e il finlandese.
Oltre, naturalmente, al partito comunista russo, che non era soltanto quello ospitante, ma era anche quello che svolgeva una funzione dirigente. Questa funzione era tuttavia concepita come temporanea: i comunisti russi erano allora concordi nel pensare che la rivoluzione proletaria sarebbe tra breve divampata in Germania, e che, non appena ciò fosse accaduto, la sede e la direzione dell’Internazionale avrebbero dovuto essere trasferite a Berlino. Mancavano a Mosca, nel marzo 1919, rappresentanti di paesi importanti come Inghilterra, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Svezia, Giappone, Cina e Stati Uniti d’America, perché in tutti questi paesi non si erano ancora formati partiti comunisti.
Al momento della nascita della Terza Internazionale un processo rivoluzionario era in corso in Germania, dove un partito comunista (K.D.P., ovvero partito comunista tedesco) era stato fondato il I gennaio 1919, come risultato della fusione di alcuni piccoli gruppi marxisti di diffusione locale con la Lega di Spartaco. In Baviera, rovesciata la dinastia Wittelsbach già il 7 novembre 1918, prima ancora della fuga dell’imperatore da Berlino, si era insediato un governo provvisorio socialista guidato dal filosofo neokantiano e pacifista Kurt Eisner. Questi si era dimesso il 15 febbraio 1919 in polemica con i suoi ministri della S.P.D. (cioè del partito socialdemocratico, mentre lui era un socialista indipendente), giudicati troppo conservatori. Costoro, anziché accettare la crisi di governo, erano rimasti ai loro posti, semplicemente sostituendo Eisner con uno di loro, cioè Johannes Hoffmann.
Eisner, dopo averli accusati di illegalità, era stato assassinato i1 21 febbraio 1919. Il suo assassinio aveva esasperato l’odio dei comunisti verso i socialdemocratici, che il mese prima già avevano fatto assassinare a Berlino numerosi operai comunisti e i fondatori della Lega di Spartaco Karl Liebneckt e Rosa Luxemburg, ma aveva spinto sul terreno rivoluzionario anche una parte crescente del proletariato bavarese. I dirigenti politici delle forze di sinistra della Baviera erano perciò stati costretti, per non farsi travolgere dalla loro stessa base, a istituire il 6 aprile 1919 una Repubblica bavarese dei consigli, fondata sui Consigli operai formatisi nelle fabbriche di Monaco. Curiosamente nel governo dei Consigli c’erano ministri socialdemocratici, il cui partito era contrario all’esperienza dei consigli operai, e non c’erano ministri comunisti, il cui partito voleva invece trasformare la democrazia parlamentare in una democrazia consiliare proletaria.
Ma i primi stavano nel governo dei Consigli per non perdere contatto con gli operai, ed i secondi non ci stavano a causa della presenza dei primi. Un tentativo dei militari reazionari bavaresi (tra i quali Adolf Hitler), compiuto il 12 aprile 1919, di spengere nel sangue i consigli operai, era stato rintuzzato attraverso la distribuzione di armi agli operai di Monaco, i quali poi, una volta armati, avevano imposto la trasformazione della Baviera in una repubblica sovietica. Nel frattempo una repubblica sovietica era nata anche in Ungheria, paese dove un partito comunista era stato fondato fin dal 20 novembre 1918. Il governo liberale di Karoly, seguito al crollo dell’Impero austro-ungarico, aveva cercato di dividere il movimento operaio, blandendo i dirigenti socialdemocratici, e incarcerando quelli comunisti.
Ma la base operaia aveva poi imposto la svolta del 21 marzo 1919, quando un’assemblea di delegati socialdemocratici riunita a Budapest aveva approvato una mozione che chiedeva il passaggio allo Stato di tutte le aziende con più di venti dipendenti, la confisca di tutte le case sfitte, e la liberazione di tutti i comunisti arrestati. I capi socialdemocratici erano poi andati ad incontrare nel carcere di Budapest i capi comunisti, chiedendo loro se accettavano l’unità dei due partiti su questa piattaforma. Alla loro risposta positiva era seguito un colpo di mano di operai e soldati ribelli di Budapest, i quali, prese le armi dall’arsenale della città, avevano disarmato la polizia e liberato i comunisti detenuti. Si era formato, quello stesso giorno, un governo «sovietico», composto di ministri in maggioranza socialdemocratici, ma diretto dal comunista Bela Kun.
Così, se al momento della nascita della Terza Internazionale c’era un solo partito comunista al potere, quello bolscevico in Russia, un mese dopo i comunisti governavano anche l’Ungheria e la Baviera. Alla fine di aprile, però, l’ex capo del governo socialdemocratico bavarese, Johannes Hoffmann, riparato a Bamberga, nel nord della Baviera, aveva scagliato i reparti più reazionari delle forze armate contro il «governo sovietico» di Monaco. Tornato al potere a Monaco i1 I maggio 1919, il socialdemocratico Hoffmann aveva lasciato che quella giornata, la festa dei lavoratori, diventasse «il primo maggio di sangue», con l’assassinio a freddo di centinaia di comunisti, tra i quali ministri che erano mitissimi intellettuali, come Gustav Landauer e Rudolf Egelhofer.
Nell’agosto 1919 anche il governo «sovietico» di Budapest era stato sanguinosamente travolto dai «capitani di Szeged», un gruppo di ufficiali reazionari che si erano rifugiati in quella cittadina e vi avevano arruolato fanatici e mercenari. Il potere comunista era ritornato ad esistere soltanto in Russia, ed anche qui era stato gravemente minacciato, prima, nell’autunno 1919, dai generali «bianchi» sostenuti da francesi e inglesi, poi, nella primavera 1920, dall’aggressione della Polonia, sostenuta dalla Francia. Questo Stato, rinato nel 1919 dopo essere scomparso nel 1795 per la spartizione del suo territorio tra le potenze vicine, mirava non ai suoi confini etnici, ma alle sue vastissime frontiere della prima età moderna, e cercava di ottenerle proponendosi come campione della lotta anticomunista.
Nel maggio 1920 le truppe polacche erano arrivate alle porte di Kiev. Quando però, il 21 luglio 1920, si era aperto a Mosca il 2° Congresso della Terza Internazionale, ormai chiamata usualmente Komitern, come abbreviazione di Internazionale comunista, la rivoluzione internazionale era sembrata davvero in atto: in Inghilterra si era sviluppato un movimento di consigli operai di impronta rivoluzionaria, in Spagna, Italia e Germania c’erano stati grandi scioperi con rivendicazioni radicali, e in Ucraina l’Armata rossa aveva ripetutamente sconfitto i polacchi, li aveva rigettati fino ai loro confini, ed era poi addirittura entrata nel loro territorio. I dirigenti sovietici avevano allora affidato tutte le loro speranza all’esaltante prospettiva di portare i comunisti al potere a Varsavia e di far congiungere l’Armata rossa con i rivoluzionari tedeschi. La rivoluzione avrebbe allora trionfato in Germania, e la Germania comunista avrebbe aiutato la Russia ad instaurare il socialismo.
Al 2° congresso del Komitern avevano partecipato più partiti comunisti di quelli del congresso di fondazione dell’anno prima, ed anche diversi partiti socialisti, da quello spagnolo a quello svedese, da quello italiano a quello francese, desiderosi di farsi ammettere nell’unica Internazionale proletaria che appariva dotata di prestigio e di futuro. Lenin aveva fatto approvare 21 condizioni di annessione, tra le quali l’espulsione dalle loro file dei riformisti e l’adozione del nome comunista. I partiti socialisti presenti al 2° congresso del Komitern avevano però poi rifiutato di applicare le 21 condizioni, per cui le loro minoranze interne favorevoli ad esse se ne erano scisse, fondando nuovi partiti comunisti: al congresso socialista di Tours del dicembre 1920 era nato il partito comunista francese, al congresso di Livorno del gennaio 1921 era nato il partito comunista italiano, ed al congresso di Madrid dell’aprile 1921 era nato il partito comunista spagnolo.
In questo periodo, però, la possibilità di una rivoluzione proletaria sfuma in tutti i paesi dell’Europa occidentale, dove gli operai rivoluzionari vengono, isolati e sconfitti dalle borghesie. In Polonia lo spirito nazionalistico prevale su quello della trasformazione sociale tra gli stessi operai, e le forze militari polacche, guidate da Jozef Pilsudski, sconfiggono l’Armata rossa. La Russia comunista, a questo punto, è sola.
2. Dalle lotte di frazione alla dittatura di Stalin
Nel 1921, il regime sovietico, uscito vittorioso dalla guerra civile e dall’aggressione dell’Intesa, ed entrato nella fase della NEP, deve misurarsi con la gravissima situazione di penuria interna e con il completo isolamento internazionale. Lenin si impegna a fondo, nel 3° congresso del Komitern, apertosi il 22 giugno 1921, nel far prendere coscienza ai comunisti dell’Europa occidentale dell’avvenuto riflusso del processo rivoluzionario internazionale, e nell’invitarli a battersi anche per parziali obiettivi di progresso sociale, in modo da contrastare, ciascuno nel proprio paese, derive reazionarie che indebolirebbero ulteriormente le classi proletarie e accrescerebbero l’isolamento della Russia. Questa impostazione suscita però aspri contrasti: i rappresentanti dei partiti comunisti tedesco, austriaco, ungherese, bulgaro, polacco e italiano (il partito comunista d’Italia è all’epoca guidato da Amadeo Bordiga), si oppongono a Lenin perché credono che il riflusso del processo rivoluzionario sia temporaneo, e preluda anzi a un più vigoroso impulso della lotta operaia alla borghesia, e perché non concepiscono altro obiettivo politico che l’abbattimento del capitalismo.
L’XI congresso del partito comunista sovietico, all’inizio della primavera del 1922, è unanime nell’accettazione della NEP così come la intende Lenin. Viene istituita la carica di segretario del partito e affidata a Stalin, che già dal 1919 dirige il cosiddetto «ispettorato operaio e contadino», cioè una pletora di burocrati di partito che sovraintendono allo svolgimento di essenziali funzioni statali. La sua nomina non riceve alcuna attenzione dalla stampa, perché a quell’epoca la carica di segretario di partito non è una carica politica (come sarà, in seguito, quella del «segretario politico»), ma semplicemente amministrativa, per cui sembra anzi che, assumendola, Stalin abbia rinunciato ad entrare nella cerchia dei più alti dirigenti politici.
Invece è proprio dal 4 aprile 1922, data della sua nomina a segretario del partito comunista sovietico, che comincia l’ascesa di Stalin al vertice del potere, perché quella carica gli consente di crearsi un’ampia base di sostegno tra i burocrati su cui si regge l’attività del partito e dello Stato, facendo la loro conoscenza personale, dando voce ai loro interessi, promuovendo quelli che gli sono fedeli, retrocedendo gli altri.
2.1 Peggioramento della salute di Lenin
Il 25 maggio 1922 Lenin viene colpito da un attacco apoplettico che gli paralizza il lato destro del corpo e lo riduce all’afasia. Uscito di scena il capo indiscusso del comunismo, i ruoli più importanti vengono svolti da Trotzkij, che, come presidente del Consiglio di guerra, e membro dell’ufficio politico del partito particolarmente influente per aver guidato l’Armata rossa alla vittoria nella guerra civile, prende le decisioni strategiche, e da Stalin, che si fa forte del sostegno dei suoi burocrati, e che riesce a farsi nominare, il 10 agosto 1922, alla presidenza della commissione allora più importante, quella che deve decidere il tipo di vincolo federativo che dovrà unire le nuove repubbliche sovietiche emerse dall’Impero russo.
Nel settembre 1922, Lenin, parzialmente ristabilito in salute, e subito tornato alla vita politica, condanna duramente il progetto di Stalin sulla federazione, perché basato sul dominio dell’etnia russa sulle etnie non russe, e condivide l’opposizione della Georgia ad entrare in una simile federazione. Stalin, allora, nell’ottobre 1922 riformula il progetto di federazione su un piano di parità tra le repubbliche federate, ma pretende che la Georgia entri nella federazione non come tale, ma come parte di una più vasta repubblica transcaucasica, reprimendo duramente le opposizioni in quel paese. Venutone a conoscenza, Lenin si infuria e rifiuta di intrattenere qualsiasi rapporto personale con Stalin, anche perché questi in un momento d’ira ha trattato con violenza sua (di Lenin) moglie.
Nei primi giorni del dicembre 1922 si tiene il 4° congresso del Komitern, che condanna ogni forma del settarismo e indica ai partiti comunisti europei al di fuori della Russia la via del cosiddetto «fronte unico» (comprensivo, cioè, di tutte le forze democratiche) contro l’avanzata della reazione. Pochi giorni dopo la conclusione di questo congresso, Lenin viene colpito da un secondo attacco della sua malattia cerebrale, ed esce di nuovo di scena. La nascita, il 30 dicembre 1922, della federazione tra le repubbliche sovietiche, con il nome di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.), avviene dunque sì su un piano di parità, come Lenin aveva voluto, ma riunendo, secondo il progetto di Stalin, quattro sole vaste entità, e cioè Russia, Bielorussia (o Russia Bianca), Ucraina e Transcaucasia.
Lenin ha un ultimo, breve periodo di lucidità, nel marzo 1923, alla vigilia del 12° congresso del partito comunista sovietico, in previsione del quale concerta con Trotzkij un attacco al potere di Stalin. Secondo Lenin, la rivoluzione sta degenerando a causa della burocratizzazione del partito comunista, che egli combatte proponendo alcune riforme organizzative quali il trasferimento di una parte dei poteri della segreteria al comitato centrale, l’aumento dei componenti del comitato centrale con nuovi membri scelti tra gli operai, lo scioglimento dell’ispettorato diretto da Stalin e la sua sostituzione con una commissione di controllo composta da operai. Poi detta segretamente alcune note di un messaggio al congresso, impropriamente definite in seguito «testamento di Lenin», con le quali mette in rilievo alcuni gravi difetti di Stalin, soprattutto la sua brutalità, sconsigliando di lasciargli troppo ampi poteri nel partito e nello Stato.
2.2 La morte di Lenin
Nell’aprile 1923, quando si apre il 12° congresso del partito comunista sovietico, Lenin è stato appena colpito da un nuovo attacco della sua malattia, dal quale non si riprenderà più. Il 12° congresso è dunque il primo senza Lenin. Stalin ne approfitta per accrescere il suo potere, senza contrapporsi a Lenin, ma presentandosi anzi abilmente come l’esecutore della sua volontà. Proprio Stalin, infatti, porta all’approvazione dei congressisti la parte conosciuta delle proposte di Lenin, quelle cioè contro la burocratizzazione. Il suo potere non ne viene diminuito, perché i provvedimenti antiburocratici vengono gestiti dalla burocrazia, che ne stravolge lo spirito, in quanto il 65 % dei delegati al 12° congresso sono burocrati di partito (contro il 25% dell’11° e del 10° congresso, e il 15% del 9° congresso).
Così, ad esempio, l’ispettorato di Stalin viene bensì sciolto, ma i suoi membri più influenti entrano a far parte della commissione di controllo che lo sostituisce, i cui componenti dovrebbero essere operai, mentre sono burocrati di origine operaia, perché viene definito operaio anche chi lo è stato in passato senza esserlo più. Trotzkij, d’altra parte, rinuncia ad attaccare Stalin al congresso, come gli aveva suggerito Lenin, sui due punti in cui il segretario è più vulnerabile, e cioè sulla questione nazionale e sulla questione operaia.
Egli rinuncia a farlo, ed anche a portare ai congressisti il messaggio di Lenin contro Stalin, perché è intimamente in disaccordo con la volontà di Lenin di tutelare le autonomie nazionali all’interno dell’Unione sovietica, e di dare più potere agli operai, e perché sottovaluta Stalin, considerando suoi avversari soprattutto i tradizionali esponenti della destra comunista, e cioè Kamenev, presidente del consiglio dell’economia e presidente del soviet di Mosca, e Zinovev, presidente del Komitern e segretario cittadino del partito a Leningrado.
Il 21 gennaio 1924 Lenin muore. Stalin, in quanto segretario generale del partito, organizza i funerali, e ne approfitta per dare di se stesso l’immagine di «uomo di Lenin». Si fa poi promotore di un vero e proprio culto della figura di Lenin, adoprandosi nascostamente ma efficacemente perché la gloria del capo scomparso si rifletta su di lui, ed egli appaia suo erede. A maggio e a giugno del 1924 si succedono il 13° congresso del partito comunista sovietico e il 5° congresso del Komitern, che portano entrambi l’impronta di Stalin.
Benché Lenin sia morto, i pochi dirigenti che ne conoscono il cosiddetto «testamento», che contiene il giudizio negativo su Stalin e l’invito a togliergli la carica di segretario generale, decidono unanimemente, compreso Trotzkij, di non renderlo pubblico, «per non turbare i militanti comunisti». Stalin ne trae un decisivo vantaggio. Inoltre Kamenev e Zinovev, temendo, curiosamente, la possibilità dell’istaurarsi di una dittatura di Trotzkij, si alleano con Stalin, che considerano più democratico, e comunque meno forte di Trotzkij. Questa straordinaria illusione prospettica deriva dall’erronea assunzione che il prestigio storico di Trotzkij come primo artefice della conquista del potere nell’Ottobre, come vittorioso condottiero dell’Armata rossa nella guerra civile, come stretto collaboratore di Lenin, e come scrittore di teoria della rivoluzione, equivalga a potere.
Invece la base nascosta del potere sta nell’apparato militante del partito, che è bensì devoto allo Stato sovietico, pieno di energie, e impegnato nella vita sociale talvolta con generosità, ma anche incolto, rozzo e portato alla semplificazione acritica, e che si è quindi facilmente legato all’uomo da cui dipendono le carriere e che ne fa valere gli interessi, anche se la sua storia è la meno prestigiosa tra quelle dei massimi dirigenti. Grazie all’appoggio di Kamenev e di Zinovev, Stalin può accrescere il suo potere basato sull’apparato militare del partito, perché il 13° congresso gli consente di creare una «commissione centrale di controllo» come articolazione del segretariato generale (e quindi alle sue dirette dipendenze), dotata di un’incontrollata facoltà di «purgare il partito di tutti gli elementi ideologicamente nocivi o moralmente corrotti».
La cosiddetta «troika» (cioè «il terzetto») Kamenev-Stalin-Zinovev stravince il 13° congresso, sconfiggendo Trotzkij, e privandolo della sua principale base di potere, la presidenza del Consiglio di guerra (affidata allo staliniano Viktor Frunze). Kamenev e Zinovev, da anni nemici di Trotzkij (avendo questi rappresentato la posizione più a sinistra nel partito, e loro quella più a destra), ne chiedono addirittura l’espulsione dal partito. Stalin però si oppone, e gli fa conservare addirittura il posto nell’ufficio politico.
Si tratta di una mossa furba, che consolida la sua immagine «centrista» rispetto alle fazioni estreme, e di padre bonario del partito, assai utile per accrescere la sua base di consenso. Egli mostra questa immagine anche al 5° congresso del Komitern, nel quale promuove un sostanziale abbandono della strategia leniniana del «fronte unico», ma in maniera discreta, e, appunto, bonaria, stabilendo contatti personali e informali con i maggiori esponenti del comunismo europeo, ma senza interventi pubblici e organici, anche perché gli manca la necessaria preparazione di politica internazionale.
Nel 1925 Stalin propaganda l’idea, da lui esposta già l’anno prima, alla vigilia del 13° congresso, in contrapposizione a Trotzkij, della possibilità di costruire il socialismo in un solo paese, la Russia, prescindendo dalla rivoluzione internazionale. Nello stesso tempo dà il suo appoggio, nei partiti comunisti europei, alle posizioni settarie di contrapposizione «rivoluzionaria» del proletariato a tutte le altre forze sociali e politiche. Con l’idea della rivoluzione in un solo paese trasmette fiducia e autostima all’apparato del partito sovietico, e con l’appoggio alle posizioni settarie nei partiti comunisti europei isola quei partiti dal loro tessuto nazionale, favorendo la loro dipendenza dalla Russia. Nello stesso tempo, sul piano interno promuove in maniera sempre più accentuata la NEP, per favorire la crescita economica.
Questa politica gli procura l’appoggio della nuova destra del partito, che fa capo al direttore della Pravda Bucharin, e che ritiene necessaria per un’intera fase storica la presenza in Russia di un ampio settore capitalistico a fianco della produzione statizzata. Kamenev, e soprattutto Zinovev, si oppongono invece in maniera sempre più netta alle crescenti concessioni ai kulaki, nelle quali vedono un tradimento degli ideali di Lenin. Questi, infatti, aveva insegnato a pensare la NEP come una temporanea ritirata strategica, e niente affatto come una forma di vita economica da conservare e incrementare. Il 14° congresso del partito comunista, del dicembre 1925, comincia con quattrocento delegati, la maggioranza assoluta, del centro staliniano, con circa centocinquanta delegati della destra di Bucharin-Rykov, e con un centinaio di delegati della sinistra di Kamenev-Zinovev. La mozione finale del segretario generale Stalin è approvata con 559 voti favorevoli (quelli dei seguaci di Stalin e di Bucharin), 26 astenuti (quelli dei seguaci di Kamenev), e 65 contrari (quelli dei seguaci di Zinovev).
2.3 La vittoria di Stalin
La «troika» si rompe definitivamente. Stalin, ormai fortissimo, svela il suo volto, distruggendo, con un sapiente intreccio di violenza poliziesca e corruzione, le basi del potere di Zinovev a Leningrado, finché lo stesso apparato cittadino del partito non caccia Zinovev dalla locale segreteria, sostituendolo, all’inizio del 1926, con Sergej Kirov, un duro e fedele staliniano. Di fronte a tanta brutalità, che fa tornare in mente il pesante giudizio negativo di Lenin su Stalin nelle sue note del 1923, anche il moderato Kamenev passa all’opposizione, accusando Stalin di «gestione dittatoriale del partito e dello Stato», e cercando un’alleanza con Trotzkij. Nasce così, nell’aprile 1926, la cosiddetta «opposizione unificata», che unisce contro Stalin Kamenev, Zinovev, la Krupskaja (vedova di Lenin), Trotzkij, Sokolnikov, Sljapnikov e altri.
Si tratta di un’opposizione molto eterogenea, perché fino a poco tempo prima Kamenev e Zinovev si sono impegnati soprattutto ad abbattere Trotzkij, e Trotzkij e il suo seguace Sokolnikov hanno duramente contrastato Sljapnikov, fautore di un’autonomia operaia secondo loro lesiva dell’autorità dello Stato sovietico, e la Krupskaja ha considerato ideologicamente infedeli a Lenin sia Kamenev e Zinovev che Trotzkij e Sljaonikov.
Questa opposizione, inoltre, non ha una vera e propria base di appoggio. In Russia il ceto politicamente decisivo è quello dei militanti d’apparato, e costoro, pochissimo istruiti, non comprendono un dibattito ideologico né temono una dittatura, tanto meno di Stalin, espressione della loro mentalità e dei loro interessi. Quando perciò, dopo una durissima lotta di fazione, l’opposizione soggetta a vessazioni poliziesche, nel settembre 1926 fa appello alla base del partito contro Stalin, viene facilmente sbaragliata. La riunione del comitato centrale del partito nell’ottobre 1926 segna la sua totale sconfitta. Stalin la distrugge politicamente: Trotzkij e Kamenev sono esclusi dall’ufficio politico; Kamenev viene inoltre privato della presidenza del consiglio dell’economia, che va a Rykov; Zinovev cede a Bucharin la presidenza del Komitern.
A questo punto si può parlare di una dittatura di Stalin, il quale, dopo aver liquidato tutti i suoi oppositori, con un semplice provvedimento amministrativo trasforma il divieto di costruire frazioni all’interno del partito, sancito dal 10° congresso, in un divieto addirittura di sostenere idee potenzialmente frazionistiche, istituendo un controllo poliziesco su ogni forma di dissidenza. La sua dittatura viene esercitata non attraverso lo Stato (nel quale egli non ricopre alcuna carica) ma attraverso il partito sovrapposto allo Stato.
Conclusioni
Terrò ovviamente ben distinte le considerazioni che riguardano la Storia da quelle che riguardano il degrado dell’uso della Storia, da parte dei sicofanti del nostro tempo. Sono abbastanza certo che il sostantivo “sicofante” non faccia parte, giustamente, del vocabolario della più gran parte degli italiani. E quindi più avanti rinnoverò il gioco che spesso faccio con la mia amatissima nipotina Maddi. Non che Angi, l’altra mia nipotina, non sia altrettanto amata, ma non ha ancora l’età per questo tipo di gioco. E di giochi ne facciamo!
Ma, tornando alle cose serie, da studioso e non da storico, penso sia importante riassumere le caratteristiche della genialità politica di Lenin, evidenziate a più riprese nel corso di questo saggio, in stretta connessione con gli eventi più significativi della Russia dal 1887, anno dell’impiccagione di suo fratello al 1924, anno della sua morte.
1. Teorie rivoluzionarie in Russia, tra il 1860 e 1917
Abbiamo visto che, circa dieci anni prima che Lenin nascesse, lo zar Alessandro aveva abolito la servitù della gleba, con l’intento di fornire all’industria la mano d’opera necessaria al suo sviluppo. Ma sono gli interessi dell’aristocrazia feudale a costituire il fulcro dell’azione governativa e perciò la riforma non servirà né a promuovere gli investimenti nell’agricoltura, né ad avviare un processo di industrializzazione.
Di fatto, l’abolizione della servitù della gleba sostituisce la necessità economica alla costrizione giuridica come ragione per la quale i contadini debbano lavorare per i signori, e mette a disposizione di costoro braccia in grande quantità, facilmente acquistabili in cambio di bassi salari. Ma non produce la modernizzazione della Russia, finendo con l’accrescere la frustrazione dei modesti strati della borghesia e della nobiltà dedita ad attività commerciali.
I primi gruppi rivoluzionari, formati prevalentemente da giovani e intellettuali nascono negli anni Sessanta. I bakunisti o insurrezionalisti e i lavrovisti o propagandisti. I secondi che maturano la convinzione che la propaganda non sarà mai efficace senza condividere la vita del popolo e si trasformino in “narodniki“, gli “amici del popolo“, in Occidente conosciuti come “populisti“.
L’interrogativo comune riguarda la prospettiva della rivoluzione in Russia e quali possano esserne i protagonisti e gli esiti sociali, per trarne le indicazioni di strategia rivoluzionaria più adeguate alle condizioni del paese. Sinteticamente, la Russia può approdare direttamente al comunismo dal feudalesimo, saltando la fase capitalistica dello sviluppo storico, con lo sviluppo progressivo delle sue comunità di villaggio o è necessario un passaggio al capitalismo abbattendo prima il dispotismo autocratico?
I populisti propendono per la prima ipotesi.
E sono loro che, a fronte della violenza poliziesca, fondano l’organizzazione clandestina “Terra e Libertà“, che fa uso della violenza armata. Si divideranno presto in terroristi e antiterroristi, tanto da scindersi. I primi, sotto la guida di Zeliabov, danno vita a “Libertà del popolo”, ingaggiando una lotta mortale con la polizia zarista, con il sacrificio quasi totale degli adepti, ma anche con l’uccisione di diversi alti funzionari di polizia, e nell’uccisione, il primo marzo 1881, dello zar Alessandro II.
Un ultimo nucleo dell’organizzazione, guidato da Aleksandr Uljanov, fratello maggiore di Vladimir, viene catturato al completo il primo marzo 1887 mentre tentano di uccidere Alessandro III. Vengono impiccati tutti. Tramonta così l’ipotesi rivoluzionaria dei narodniki.
E questa è l’aria che respira Lenin, diciassettenne.
Plechanov, esule a Ginevra, in Socialismo e lotta politica del 1883, denuncia come utopica l’idea dei populisti e sostiene che l’unica via possibile di modernizzazione della Russia è una rivoluzione che abbatta il dispotismo autocratico, nell’interesse stesso delle classi lavoratrici russe, e che queste, entro le istituzioni capitalistiche, potranno per la prima volta organizzarsi in maniera moderna e preparare, per un lontano futuro, una nuova rivoluzione, che solo allora potrà avere un carattere socialista.
Passano quindici anni dall’uccisione di Alessandro II. Lenin ha trovato modo, dopo le vicissitudini siberiane, da esule volontario in Svizzera, di rivitalizzare il partito socialdemocratico nato nel 1898, di dar vita ad un giornale l’Iskra, di “amare e poi odiare” Plekhanov e di scrivere il suo Che fare?
Il partito socialdemocratico russo, affiliato alla Seconda Internazionale, era nato nel 1898, da un congresso clandestino a Minsk di nemici dell’autocrazia zarista influenzati dalle idee della socialdemocrazia europea e soprattutto da quelle di Plechanov. Partito al quale aveva aderito Lenin. Un partito che si caratterizza per la convinzione che il socialismo e, a maggior ragione, il comunismo, non possano scaturire che dalle contraddizioni di un capitalismo pienamente sviluppato e dalla forza di un proletariato ben organizzato nell’àmbito di un sistema politico democratico.
Di conseguenza, data l’arretratezza della Russia, l’unica rivoluzione possibile è una rivoluzione democratica nei suoi esiti politici, borghese in quelli sociali, e capitalistica in quelli economici, una rivoluzione democratico-borghese. Ed è proprio all’interno del partito socialdemocratico che, a trentadue anni, Lenin formalizza le sue idee sulla rivoluzione nel Che fare? esplicitando i contenuti politici di un partito realmente rivoluzionario, e convalidando una certa forma-partito, sempre che si caratterizzi per quei contenuti e li metta in pratica.
Secondo Lenin, un partito rivoluzionario deve essere depositario di un sapere sociale di grado superiore rispetto alla coscienza spontanea delle masse lavoratrici, e deve organizzarsi per portare questo sapere alla classe operaia. (Quando ero giovane si diceva: “La coscienza di classe viene dall’esterno”). Ma non basta. Il compito più importante del partito è quello di riuscire a far esprimere la classe sul piano della generalità sociale, a livello dello Stato. E deve rappresentare la classe operaia nei suoi rapporti con tutte le classi della società, e con lo Stato come forza politica organizzata. E questo può avvenire se il partito riesce a portare la classe operaia sul terreno della lotta politica per la conquista dello Stato, ne eleva la coscienza fino a farla diventare una forza rivoluzionaria, e la abitua a contrastare non solo l’oppressione del padrone capitalista in fabbrica, ma ogni altra forma di oppressione dell’uomo sull’uomo. Presto, all’interno del partito socialdemocratico, emerge una diversa concezione del ruolo del partito nella rivoluzione russa.
I menscevichi ritengono che, dal momento che la rivoluzione un Russia introdurrà il capitalismo, sarà la borghesia a dirigerla, assumendo la guida politica di tutte le altre classi sociali. Lenin, invece, è convinto che in Russia, anche una rivoluzione non socialista ma semplicemente democratico-borghese non possa verificarsi senza che la classe operaia sia in prima fila nella lotta rivoluzionaria, sotto la direzione politica di un partito socialdemocratico capace di assumersi anche le responsabilità di una partecipazione ad un governo rivoluzionario.
E lo dovrà fare con un partito rigidamente organizzato e disciplinato, che coincida con l’avanguardia cosciente del proletariato, capace di educare politicamente il resto della classe e costituisca il perno di un’alleanza della classe operaia con altri settori della società, in primo luogo con i contadini.
Al contrario i menscevichi, sono per un partito che rappresenti essenzialmente gli operai, e che si radichi nelle loro lotte sindacali. Convinti che inserire i contadini in un’alleanza rivoluzionaria significa deviare dal marxismo, negandone l’idea fondamentale che, dopo la borghesia, soltanto il proletariato di fabbrica sia una classe storicamente progressiva.
In ogni caso, la rivoluzione che Lenin prospetta per la Russia è, in pieno accordo con i menscevichi, una rivoluzione democratico-borghese, non socialista. E, sempre d’accordo con i menscevichi, Lenin sostiene che non esista una scorciatoia verso il socialismo che non passi prima per la piena realizzazione dei principi democratici creati dalla borghesia e che la rivoluzione democratico-borghese debba servire in Russia per sostituire un capitalismo dipendente dall’estero e colluso con l’autocrazia con un capitalismo capace di un autonomo sviluppo. Ma Lenin è anche convinto che la borghesia russa, al servizio del capitale straniero, non sia in grado di promuovere questo passaggio ad un capitalismo capace di autonomo sviluppo e ad un sistema democratico.
La tattica menscevica consistente nel lasciare alla borghesia l’iniziativa e la guida della rivoluzione democratica finirebbe con l’essere di ostacolo ad una vera rivoluzione. La rivoluzione democratico-borghese in Russia è, scrive Lenin, “più vantaggiosa per il proletariato che per la borghesia“, in quanto “la classe operaia soffre non tanto per il capitalismo quanto per l’insufficienza del suo sviluppo“.
La tattica bolscevica dovrà perciò essere quella di spingere la classe operaia a promuovere e dirigere essa stessa la rivoluzione democratica, che sarà borghese solo nel senso che “non uscirà dal quadro economico e sociale di origine storica borghese, vale a dire dal quadro capitalistico” sul piano dei risultati. In Russia “la rivoluzione non soltanto non distruggerà le basi del capitalismo, ma anzi le allargherà rendendole internamente autosufficienti“.
Questo il senso della famosa tattica del fintantoché adottata dai bolscevíchi: appoggiare le iniziative borghesi, ed un eventuale governo borghese, fintantoché avesse promosso lo sviluppo della rivoluzione, mentre, di fronte agli inevitabili compromessi ed arretramenti della borghesia, cercare di abbatterne la direzione politica e di assumere direttamente la guida della rivoluzione.
Inoltre, Lenin sosteneva l’idea che la socialdemocrazia avrebbe dovuto dirigere anche la lotta antifeudale dei contadini, per dare soddisfazione alla loro aspirazione borghese di ottenere la proprietà delle terre da sottrarre all’aristocrazia. Soltanto una simile alleanza, avrebbe consentito la realizzazione della rivoluzione democratico-borghese, permettendo alla socialdemocrazia di tenere il potere grazie all’appoggio contadino, e di guidare la Russia ad uno sviluppo moderno ed autonomo del capitalismo, cui avrebbero dato un contributo decisivo, dopo essersi impadroniti delle terre dell’aristocrazia, i contadini più ricchi, e nel cui àmbito il proletariato avrebbe potuto godere di tutti i diritti civili e politici ed organizzarsi per la tutela dei suoi interessi.
Abbiamo visto che, nell’aprile 1905, bolscevichi e menscevichi diventano due partiti distinti. Da cinque gatti che erano, e pure in esilio, diventano tre gatti i bolscevichi e due gatti i menscevichi.
Altre forze politiche sono nate all’inizio del Novecento, in Russia. I maggiori esponenti politici della ricca borghesia danno vita, nel 1905 ad un partito costituzionale-democratico, chiamato il partito cadetto, con un’ala destra, più favorevole al compromesso con la monarchia, e un’ala sinistra, più decisa nel sostenere l’introduzione del suffragio universale e del governo parlamentare.
Le forze rivoluzionarie, nel giugno 1902, fondano il partito socialista-rivoluzionario per iniziativa di un intellettuale russo, Victor Cernov. Un partito che esprime gli interessi della piccola borghesia rurale, ostile allo sfruttamento feudale delle campagne e all’autocrazia zarista che lo impone. Sostanzialmente si riallaccia alla tradizione dei narodniki, La riforma agraria di Stolypin del 1906, con l’intento di rendere sia i contadini ricchi che quelli medi alleati dello zarismo, modifica radicalmente la struttura delle campagne, scioglie il mir e suddivide le terre, in proprietà privata.
Dalle campagne emergono:
- uno strato di contadini ricchi, i kulàki, che hanno più terra di quanta ne possano coltivare tanto da dover assumere braccianti salariati, corrispondente al 15% della popolazione rurale;
- uno strato di contadini medi, che hanno una terra, coltivabile dai membri delle loro famiglie, che garantisce sia il consumo delle famiglie stesse sia la vendita di modeste eccedenze sul mercato;
- uno strato di contadini poveri che non hanno eccedenze, costretti ad andare anche a lavorare come braccianti salariati, corrispondente al 20% della popolazione rurale.
A fronte della mutata struttura sociale della Russia, tra i socialrivoluzionari emergeranno uomini sempre più orientati ad esprimere politicamente gli interessi soltanto dei più ricchi tra i contadini, e quelli, ad essi omogenei, di una borghesia urbana di piccoli industriali che stanno trovando nello strato superiore del mondo contadino un promettente mercato di sbocco.
Nel 1912, nasce il partito laburista, derivato dalla fusione del partito socialista popolare (nato da una scissione dell’ala destra del partito socialrivoluzionario) con il partito socialista nazionale (di sinistra borghese e guidato da Aleksandr Kerenskij).
2. Prima del 1917, in Russia
Il 9 gennaio 1905 decine di migliaia di operai di Pietroburgo scioperano e si recano in corteo al Palazzo d’inverno, per presentare al sovrano una petizione perché ponga fine alla guerra, abolisca le imposte indirette, introduca le libertà civili e la giornata lavorativa di 9 ore con riposo festivo per gli operai. A guidarli un giovane prete ortodosso, Georgij Gapon, che pensa di agire nell’interesse dell’autocrazia zarista. Nicola II fa sparare loro addosso. Più di 1000 morti e 2000 feriti. La “domenica di sangue“ distrugge le ingenue speranze del pope e del popolo russo sulla paterna sollecitudine dello zar.
Con la repressione all’insurrezione di dicembre a Mosca, la rivoluzione del 1905 è sconfitta. C’è una grossa novità nell’organizzazione delle masse popolari. Sono nati i soviet!
Nel 1914, scoppia la Prima guerra mondiale, la Grande guerra per la generazione di mio padre. Nell’autunno del 1916, la società russa è vicina al collasso. Manca il cibo per i soldati e per vasti strati popolari, per il crollo della produzione agricola. Manca ogni genere di combustibile, anche il legname così abbondante nel paese, perché mancano i mezzi di trasporto per farlo affluire nei centri abitati. La popolazione soffre quindi tremendamente il freddo, e diverse fabbriche chiudono per mancanza di carbone, e licenziano i loro operai, creando così altra miseria. Nell’inverno 1916-17 si comincia a morire di fame e di freddo. A Pietroburgo il governo zarista perde totalmente il controllo della sua capitale nell’arco di una sola settimana.
3. Dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione d’Ottobre
E’ proprio nell’arco di tempo marzo-novembre del 1917 che Lenin da teorico della rivoluzione, esule in Svizzera, si trasforma in rivoluzionario in Russia. Dalla teoria alla pratica!
La rivoluzione di febbraio, una rivolta plebea contro la fame, la disoccupazione e l’oppressione poliziesca e militaristica, anche se vittoriosa, apre soltanto un vuoto di potere. A Pietroburgo, nel marzo 1917, non comandano più gli uomini dello zar, non vigono più le loro leggi, ma al loro posto c’è il caos. A colmarlo ci penseranno il comitato esecutivo della Duma, emanazione del gruppo parlamentare del “Blocco progressista”, presieduto dal principe Lvov e il soviet degli operai e dei soldati di Pietroburgo, sul modello del 1905 sotto la guida del capo menscevico Ccheidze.
I due organismi si accordano per l’attribuzione del potere ad un governo provvisorio con esponenti dei soli partiti borghesi, che garantisca però la piena libertà di espressione a tutte le componenti politiche e organizzi l’elezione a suffragio universale di un’assemblea costituente. Siamo a quel dualismo dei poteri riconosciuto, dai contemporanei e dagli storici, come esito caratteristico della rivoluzione di febbraio: il potere del governo provvisorio della borghesia e il potere dei soviet degli operai e dei soldati. Il governo provvisorio viene riconosciuto dai soviet come l’istanza politica più alta. Tra il popolo molti obbediscono soltanto al soviet che hanno eletto, e il governo provvisorio funziona soltanto perché le sue direttive sono tradotte in ordini esecutivi dai soviet.
Dopo un viaggio avventuroso, sceso dal treno, Lenin dice:
“Cari compagni, la guerra di rapina imperialistica sta per essere contrastata dalla guerra dei popoli contro i loro sfruttatori capitalisti che li hanno mandati al macello… L’alba della rivoluzione socialista mondiale è spuntata“.
Quando giunge al quartier generale bolscevico di Pietroburgo, si rende conto che anche i capi cittadini bolscevichi hanno appoggiato il governo provvisorio del principe Lvov. Essenziale è l’atteggiamento di fronte alla guerra: il governo del principe Lvov è un governo infame perché vuole continuare la guerra, ed i partiti operai che lo appoggiano tradiscono, ingannandolo, il proletariato.
Nascono “Le Tesi di aprile”, “pace ai popoli!“, “smascherare il governo provvisorio“, che continua la guerra, e al quale proprio per questo, deve essere negato ogni appoggio. Per Lenin, la prima fase della rivoluzione democratico-borghese, con la borghesia a svolgere ancora un ruolo progressivo, con l’abbattimento della macchina statale zarista e la conquista del potere statale da parte della stessa borghesia, si è compiuta nella settimana della “rivoluzione di febbraio”, e occorre perciò passare alla seconda con la dissoluzione della proprietà feudale e uno sviluppo industriale non dipendente dal capitale straniero.
Questo potrà avvenire soltanto se il proletariato sottrarrà il potere statale alla borghesia. E dunque: tutto il potere ai soviet! Per Lenin, la rivoluzione democratica esige una democrazia proletaria, che si è già data le sue forme nei soviet degli operai e dei soldati. La rivoluzione democratico-borghese in Russia è dunque borghese nei suoi contenuti socioeconomici ma non nel suo soggetto politico chiamato a realizzarli, che è l’avanguardia politicamente cosciente del proletariato. Non vi sarà alcuna rivoluzione democratica senza prendere il potere politico con la confisca senza indennizzo di tutte le proprietà fondiarie dell’aristocrazia, del clero e della casa reale, e il loro passaggio sotto il controllo dei soviet.
Ed ecco la parola d’ordine: “Tutta la terra ai contadini!“. Il potere dei soviet dovrà procedere alla nazionalizzazione del commercio estero e di tutte le più importanti banche. Ma chiarisce che “l’instaurazione del socialismo non è il nostro compito immediato“, e che il proletariato, una volta assunto il potere politico attraverso i soviet, dovrà promuovere trasformazioni socioeconomiche entro limiti democratico-borghesi, rimanendo entro tali limiti finché non vi sarà una rivoluzione socialista nei paesi più sviluppati d’Europa.
E poiché il nome del socialismo è stato screditato dall’adesione dei maggiori partiti socialisti alla guerra imperialistica, le forze autenticamente rivoluzionarie dovranno chiamarsi comuniste e trasformarsi in veri e propri partiti, per dare vita alla Terza Internazionale, o Internazionale comunista.
Ma chi ha dietro di sé Lenin, nell’aprile 1917?
Di fatto, è un capo-partito isolato anche dalla maggioranza del suo stesso partito. Le sue idee non hanno fatto presa. Ma nel maggio 1917, si viene a conoscenza di un messaggio del ministro degli esteri agli altri governi dell’Intesa, per rassicurarli sull’intenzione della nuova Russia di tener fede ai patti sottoscritti con le potenze alleate. Il governo provvisorio non intende dunque porre fine alla guerra se non dopo una completa vittoria militare, e con una pace annessionista.
Gli operai delle fabbriche ed altri strati popolari, anche non affiliati ad alcun partito o addirittura menscevichi, reagiscono con rabbiose manifestazioni di protesta, perché si erano illusi che il governo provvisorio puntasse alla pace, e senza annessioni. I bolscevichi rivalutano le Tesi d’aprile di Lenin, e si rendono conto di come la parola d’ordine pace ai popoli! consentisse loro di attrarre masse popolari deluse e scontente.
Il capo del governo è costretto a formare un secondo governo di dodici ministri, sei appartenenti al partito della borghesia, quello cadetto, e sei ai partiti dei soviet esclusi i bolscevichi. Hanno cioè due ministri ciascuno i menscevichi, i socialrivoluzionari e i socialisti nazionali, questi ultimi nati per scissione da destra dai socialrivoluzionari, sotto la guida di Kerenskij.
Il nuovo governo deve sempre scegliere tra l’uscita dalla guerra contro la Germania e l’Austria, e la sua continuazione. Sceglie la seconda strada: il ministro della Guerra, Aleksandr Kerenskij, rappresentante dei soviet per conto del partito socialista nazionale, popolare tra i soldati, si appella all’idea di una guerra patriottica. Ma il fallimento dell’offensiva di giugno, con ulteriore riduzione della disciplina dei soldati, e i metodi spietati con cui i comandanti militari cercano di ristabilirla hanno come effetto quello di esasperare il malcontento nell’esercito, di moltiplicare le diserzioni, di accrescere enormemente l’influenza dei bolscevichi e della loro parola d’ordine della pace subito e ad ogni costo.
A luglio, diventa nuovo capo del governo Kerenskij. Questi, che conserva anche il ministero della Guerra, forma una sorta di triunvirato, che decide tutto da solo. Il triunvirato di governo diretto da Kerenskij crea tribunali militari contro la sovversione, vi deferisce molti capi bolscevichi e li costringe all’esilio. Alle Tesi di aprile seguono le Quattro tesi di luglio.
“la controrivoluzione si è organizzata, consolidata e impadronita del potere dello Stato [...], i comandi superiori dell’esercito, con l’aiuto cosciente o semicosciente di Kerenskij, sono diventati padroni della situazione [...], il potere statale effettivo è attualmente in Russia una dittatura militare, benché ancora mascherata da istituzioni democratiche inoperanti“.
I menscevichi e i socialrivoluzionari hanno scelto, per paura della rivoluzione, di essere “le foglie di fico della controrivoluzione“. E’ necessaria la preparazione di una insurrezione armata comunista, l’unica in grado ormai di abbattere la dittatura. I bolscevichi diventano un partito di massa, e attraggono nelle loro file migliaia e migliaia di soldati, i numerosissimi disertori che non vogliono essere fucilati, quelli di guarnigione che non vogliono più tornare al fronte, quelli in trincea che non vogliono più andare all’offensiva e quelli in licenza che non vogliono abbandonare di nuovo le famiglie.
Pietroburgo rigurgita di soldati ed ex-soldati divenuti accesissimi bolscevichi. Il tentativo dei menscevichi e dei socialrivoluzionari di ridurre i soviet a gruppi inamovibili di funzionari di partito operanti come semplici cinghie burocratiche di trasmissione degli ordini governativi non riesce, perché in molti luoghi operai e soldati impongono sostituzioni che fanno uscire dai soviet i rappresentanti più smaccatamente kerenskiani e fanno entrare nuovi rappresentanti, bolscevichi a volte, oppure esponenti critici dei partiti menscevico e socialrivoluzionario.
Lenin, in un saggio Sui compromessi, torna a riproporre uno sviluppo pacifico della rivoluzione. “Soltanto per uno sviluppo pacifico della rivoluzione“, egli scrive, “che è una possibilità estremamente rara nella storia ed estremamente preziosa“, precisa, “soltanto per questa possibilità i bolscevichi possono e debbono addivenire ad un compromesso“.
In sostanza, “I bolscevichi rinunzierebbero alla rivendicazione immediata del passaggio del potere al proletariato e ai metodi insurrezionali per far valere questa rivendicazione“, in cambio “Della piena libertà politica per i bolscevichi“. In tal modo, “I bolscevichi tornano alla rivendicazione del potere ai soviet, si forma un governo di menscevichi e socialisti rivoluzionari, senza cadetti kerenskiani, con i bolscevichi all’opposizione legale“.
Una proposta di una democrazia sovietica: una coalizione di governo tra menscevichi e socialrivoluzionari, con l’isolamento di Kerenskij. Una chiara dimostrazione di voler basare il loro governo esclusivamente sul consenso popolare. E con l’accettazione della libera propaganda dei bolscevichi tra il popolo, e che questi possano governare qualora conquistino la maggioranza.
Le rivolte contadine del settembre del 1917 rappresentano l’inizio di uno sconvolgimento violento del mondo contadino russo, accelerato dal tentativo della nobiltà russa di tornare ad imporre ai contadini le opprimenti consuetudini feudali e dalle avversità climatiche con la conseguenza di cattivi raccolti, che rendono intollerabili per i contadini le pretese dei nobili e la mancanza di terre. E soprattutto, dal ritorno nelle campagne di numerosissimi soldati congedati, o disertori, o appartenenti a reparti disciolti, con l’abitudine alla violenza omicida, acquisita in guerra, nelle loro famiglie, sollecitandole a prendersi con la forza le risorse di cui hanno bisogno.
L’eccezionale genialità politica di Lenin nel 1917 emerge in particolare proprio nel settembre, quando comprende rapidamente, unico tra i rivoluzionari, che sta crescendo in Russia una gigantesca sollevazione contadina, con un cambiamento radicale delle prospettive sociali e politiche del paese. Se le masse rurali in rivolta non vedranno le loro esigenze soddisfatte e incanalate in una nuova legalità da una rivoluzione proletaria, si determinerà un caos sociale contro il quale si leverà una repressione dittatoriale.
Che Kerenskij tenta di avviare. Scioglie il suo governo, ne forma, sempre in settembre un secondo, ancor più reazionario del primo. Esclude infatti il menscevico Cereteli, ministro della giustizia e degli interni sostituendolo rispettivamente con un menscevico di destra e con un cadetto compromesso con Kornilov, e il socialrivoluzionario Cernov, sostituendolo con un kerenskiano ostile ad ogni ipotesi di riforma agraria.
La situazione russa si è drammaticamente semplificata: dittatura borghese o dittatura proletaria. Con la scelta repressiva di Kerenskij, è venuta meno la prospettiva di uno sviluppo pacifico della rivoluzione, sostenuta qualche settimana prima: un’opposizione legalitaria dei bolscevichi, in assenza di un governo democratico fondato sui soviet, e in presenza di una rivolta contadina, costituirebbe una copertura della dittatura borghese.
E Lenin, ne La crisi è matura della fine di settembre dice:
“È indubbio che in Russia si stia sviluppando una generale sollevazione contadina [...]. Di fronte ad un fatto come questo, tutti gli altri sintomi politici, anche se contraddicessero l’imminenza di una crisi conclusiva, sarebbero privi di qualsiasi valore. Ma tutti i sintomi indicano invece che la crisi è matura nell’intero paese [...]. Insieme alla questione contadina, sta esplodendo la questione nazionale [...]. Abbiamo visto le truppe finlandesi e la flotta baltica staccarsi completamente dal governo [...]. Soldati e operai, inoltre, non sperano ormai più che nei bolscevichi [...]. Vediamo che, nelle ultime elezioni per i soviet di Mosca, 14.000 soldati su 17.000 hanno votato per i bolscevichi [...]. Il proletariato di fabbrica di Mosca, che pure, in confronto a quello di Pietroburgo, ha maggiori legami con la campagna, ed è più vicino alla mentalità dei contadini [...] ha dato ai bolscevichi 82.000 voti, corrispondenti al 47% del totale, contro i 34.000 delle precedenti elezioni di giugno“.
Lenin intende impedire la dittatura borghese con un’insurrezione bolscevica vittoriosa, capace di instaurare una dittatura proletaria: e il compito più difficile per Lenin resta, paradossalmente, quello di convincere il comitato centrale del partito bolscevico ad intraprendere l’insurrezione. Un vero e proprio colpo di genio.
L’insurrezione, affidata a un comitato militare rivoluzionario istituito dai soviet di Pietroburgo sotto la guida di Trotzskij, si compie con facilità estrema in un solo giorno con la fuga di Kerenskij e la vittoria degli insorti.
Il giorno è il 7 novembre 1917.
Lenin diventa capo del governo russo giovedì 8 novembre 1917, con un mutamento di situazione così enorme e rapido da non avere eguali nella storia. Basti pensare che l’11 novembre egli riceve nella capitale ogni sorta di felicitazioni e riconoscimenti come massima autorità del paese, e soltanto la domenica prima, era ancora, a Pietroburgo, un clandestino che la polizia aveva cercato di arrestare.
In tutta onestà, a questo punto, penso non valga la pena dedicare molte parole ai sicofanti del nostro tempo. Basterà la definizione che ne dà lo Zingarelli. Sicofante: nella Grecia antica, accusatore di professione, calunniatore, nella Roma antica, imbroglione, e oggi, come estensione letteraria, calunniatore. Ed è di quest’ultimo significato che mi sono servito nella Premessa!
La Parte prima e la Parte seconda erano contrappuntate da versi di Majakovsky, tratti dal suo poema “Lenin”. Non so trovare migliore conclusione, anzi penso che non ci sia migliore conclusione per tutto il lavoro, ricordando i versi che il poeta dedica nel suo poema alla morte di Lenin.
[…] Ma ecco, di colpo, ecco di colpo,
la notizia pesante una tonnellata:
“la morte di Lenin”.
[…] I caporioni bianchi ci timbravano a fuoco sulla schiena
la stella a cinque punte;
ci hanno interrati sino alla testa le bande selvagge di Mamontov;
vivi ci hanno bruciati nei forni delle locomotive i giapponesi:
di stagno e di piombo riempivano le nostre bocche:
«Rinnegate la vostra fede», ci urlavano.
Ma dalle gole bruciate uscivano soltanto tre parole:
«Viva il comunismo!» (1)
[…] il 22 gennaio, i bolscevichi,
uomini d’acciaio e di ferro,
entrarono nel palazzo a cinque piani del Congresso dei Soviet.
Sedettero scambiandosi un sorriso.
Lì decidevano senza indugi sui problemi del giorno.
Ecco, è ora d’incominciare.
Ma perché si ritarda?
Perché il “Presidium” si è diradato come un bosco
dov’è stata abbattuta una pianta?
Perché gli occhi sono più rossi del velluto del palco?
Perché Kalinin si mostra malsicuro?
Qualcosa è accaduto.
Ah, no! Come è possibile questo?
Il soffitto s’abbassò su di noi come un corvo.
Si chinarono le teste, si chinarono ancora.
Tremando divennero buie le luci dei lampadari;
s’incantò l’inutile suono del campanello.
Poi Kalinin si alzò, si riprese,
ma non riuscì a inghiottire le lacrime che solcavano le sue guance;
e le lacrime lo tradirono brillandogli nella barba.
Si confondono i pensieri e il sangue batte alle tempie:
«Ieri, alle sei e cinquanta minuti, è morto il compagno Lenin». (2)
Ciò che ha visto quest’anno
cent’anni insieme non riusciranno a vedere.
Il giorno entrerà nella dolente memoria dei secoli.
Lo sgomento strappò un gemito al ferro:
tra i bolscevichi passò il singhiozzo della cupa oppressione
e dalle viscere li sconvolse.
Come e quando Lenin si spense?
Sulle strade e sui vicoli navigava il Grande Teatro (3) simile a un catafalco.
La gioia si ritira come una lumaca.
Follemente corre il dolore.
Né sole né ghiaccio, soltanto neve nera,
nera neve che penetra ogni cosa attraverso la carta dei giornali.
La notizia colpì l’operaio al tornio come una fucilata;
come un bicchiere rovesciato di colpo sulla macchina
furono le sue lacrime.
E i contadini che cento volte la morte
avevano fissato negli occhi,
si vergognavano del pianto davanti alle donne
ma li tradiva l’impronta della mano terrosa sulla guancia.
Vi furono uomini di pietra,
uomini che a sangue si morsero le labbra.
Come vecchi si fecero seri i bambini
e come bambini piansero i vecchi dalle barbe d’argento.
Il vento singhiozzò sulla terra insonne,
sulla terra inquieta
che non sapeva darsi ragione di come le fredde spoglie,
nella fredda sala di Mosca,
fossero le spoglie mortali del padre e figlio della rivoluzione. (4)
Morte. Morte. Morte.
Come convincersi? Un vetro e sotto vedete…
E’ lui che portano dalla stazione
per la città ch’egli strappò ai signori.
La strada è come un’aperta ferita
tanto dolore è in essa e tanto geme.
Qui ogni pietra conosce Lenin
fin dai primi furiosi assalti dell’ottobre.
Qui tutto ciò di cui le bandiere son simbolo
è stato pensato da Lenin.
Qui ogni torre ha udito la sua voce
e con lui sarebbe balzata nel fuoco.
Qui tutti gli operai conoscono Lenin:
a lui offrirono i cuori come rami di sempreverdi gettati sulla via.
Egli guidava alla lotta prevedendo la vittoria,
egli portò i proletari al potere.
Qui il contadino scrisse il nome di Lenin nel suo cuore
con più venerazione che per i santi del proprio paese,
perché Lenin comandò di chiamare nostra la terra,
la terra che gli avi fustigati
sognano ancora nella tomba.
Sembrò che i comunardi, sotto la Piazza Rossa, (5) mormorassero:
«Fratello, amato e gentile, oh, vivi!
Ventura più grande non è necessaria,
e noi combatteremo ancora,
cento volte ancora andremo all’assalto
e torneremo nelle nostre tombe».
Ah, ora, ora dovrebbero qui risuonare le parole del taumaturgo
e noi morire e lui ridestarsi!
Ecco, così: si fendono in mezzo le strade
e gli uomini cantando si precipitano alla morte.
Ma non esistono i prodigi
ed è vano sognarli.
Ecco Lenin, ecco la bara sulle spalle curvate.
Egli era un uomo umano per ogni vena.
Portate la bara e struggetevi d’angoscia, uomini!
Un peso come questo gli oceani
non l’hanno ancora portato nei secoli,
come questa bara rossa che naviga
sulle schiene dei singhiozzi e delle funebri marce,
verso la Casa dei Sindacati.
Ancora una volta s’irrigidisce nel tributo d’onore
la severa pattuglia della guardia leninista,
ma aspetta la folla, immobile aspetta
lungo la via Tverskaja, lungo la via Dimitrovka.
Nel diciassette, alla fila del pane,
a malincuore andavano le ragazze,
nonostante la fame,
ma a questa fredda spaventosa fila tutti sono venuti,
coi bambini e con gli ammalati.
La campagna s’è fusa alla città,
insieme s’è allineata e il dolore risuona
ora virile ed ora con la voce dell’infanzia.
La terra del lavoro sfila in parata,
vivo bilancio della vita di Lenin.
Sorge il sole di lacca gialla e colpisce d’obliqui raggi la terra!
Come inchiodati, piangendo la loro speranza,
piegati dal dolore, passano i cinesi.
Vagano le notti sull’onda dei giorni,
mutando le ore, confondendo le date, come se notte non vi fosse,
né stelle nel suo buio,
ma solo le lacrime dei negri che piangono Lenin negli Stati Uniti. (6)
Il freddo morde i piedi alle suole
ma gli uomini passano i giorni accalcati.
Han persino timore di scaldarsi battendo le mani,
il timore di fare una cosa inopportuna.
Il freddo afferra e trascina,
scruta negli uomini quanto temprati essi siano nell’amore.
S’insinua nella folla, in essa si confonde,
con essa avanza nella Sala delle Colonne.
I gradini si alzano quasi ostacoli, scogli.
Con il canto si spegne il respiro.
E’ uno strazio nel cuore andare avanti.
Ora i gradini diventano un baratro un abisso di vertigini al piede.
Quattro gradini: un abisso dalle generazioni schiave
cui solo era nota la sonante ragione dell’oro.
La bara di Lenin segna il distacco.
E più oltre l’orizzonte della Comune.
Cosa vedi? Solo la sua fronte…
e dietro, nel buio, Nadegida Konstantinovna. (7)
Può darsi che ad occhi asciutti,
può darsi che senza lacrime
si possa veder meglio, ma io ho visto con questi occhi.
Le palpitanti bandiere
s’abbassano per l’estremo saluto:
«Addio, compagno, tu hai compiuto con onore
il tuo valoroso, generoso cammino.»
Un terrore mi prende.
No, non voglio guardare.
Come se camminassi sui fili del telegrafo, mi muovo;
come se per un attimo fossi solo,
sommerso in questa unica verità.
Ma ecco, io mi sollevo.
Ecco, l’acqua della risonante marcia trasporta il mio corpo senza peso.
Io so, oggi per sempre, io so che è in me questo momento.
Sono felice d’essere una molecola di questa vivente forza
dove anche il pianto è comune.
Non è possibile partecipare con più vitale purezza
al sentimento della classe operaia.
Ancora, le bandiere abbassano le ali
per sollevarsi alla lotta più forti, verso il domani.
«Noi stessi, fratello, abbiamo chiuso i tuoi occhi d’aquila».
Non si cade se si sta spalla a spalla.
Col lutto sulle bandiere, con le palpebre rosse,
s’accompagnava così Il’itch all’estremo saluto,
indugiando presso il Mausoleo.
La cerimonia si svolge, si pronunciano i discorsi
e il tempo è breve, non contiene tanto dolore.
Chi mai può coglierne la grandezza?
Passano gli uomini guardando in alto
il nero quadrante coperto di neve:
come scattano impazzite le lancette sulla torre Spasskaja. (8)
Ogni minuto è uno scatto fulmineo.
O vita, o movimento, fermatevi!
E voi che alzate il martello, restate di rigido gelo.
O terra, muori, coricati e giaci!
Qui è silenzio.
Il più grande dei cammini è compiuto.
Mille cannoni tuonarono, ma questa salve non sembrò più forte
del soldo tintinnante nella tasca del povero.
Dilatando sino al dolore la mia debole vista,
rimango intirizzito e senza respiro.
Davanti a me sta, nitido, nel riflesso delle bandiere,
l’immobile nero globo terrestre,
e sul globo, sul mondo, una bara immobile e muta.
E accanto alla bara, noi, rappresentanti degli uomini,
per moltiplicare con la tempesta delle insurrezioni,
con le opere e la poesia ciò che oggi abbiamo veduto.
Ma ecco, da lontano, la luce rossa.
Nell’aria di gelo,
verso di noi attenti e silenziosi, una voce si levò:
«Marciate al passo».
Ma quest’ordine non era necessario.
Sciogliendo con fatica il peso del corpo,
respirando più forte, insieme e più rapidi,
segnammo il passo dalla piazza in avanti.
Ora, con mano ferma, alzino sulle teste le bandiere.
Calpestio tempestoso dei piedi.
Questa forza, ah, sì! questa forza, dilatandosi in cerchi,
si comunicherà al pensiero del mondo.
Ma un pensiero comune è intanto nel cuore, nella mente
dei contadini, degli operai e dei soldati:
«Sarà più duro, per la Repubblica,
vivere senza Lenin, la sua guida».
Chi prenderà il suo posto? Come sostituire la sua forza?
Basta, dormire sul letto di piume!
«Compagno segretario, ecco, a te:
chiediamo l’iscrizione alla cellula X,
subito ed in maniera collettiva, di tutta l’officina…» (9)
I borghesi ci guardano stupiti,
dilatando gli occhietti,
sussultando allo scroscio del passo potente.
Quattrocentomila, generosi, ardenti, venuti dalle officine:
ecco la prima corona di partito offerta al compagno Lenin.
«Compagno segretario, prendi la penna…
Ho sentito che occorre sostituire… che bisogna…
Io sono vecchio,
ma c’è mio nipote, si farà onore:
iscrivilo nel “komsomol”.» (10)
[…] La morte di Lenin è diventata il primo degli organizzatori comunisti.
Riunendo in un’asta l’immane selva delle ciminiere,
in milioni di braccia,
la Piazza Rossa si solleva in alto con la rossa bandiera,
con un balzo che scuote tutto il cielo.
E da questa bandiera, da ogni sua piega,
ecco, di nuovo vivo, Lenin ci chiama:
«Proletari, serrate le file per l’ultimo scontro.
E voi, schiavi, rialzate le schiene e i ginocchi.
Armata proletaria, sorgi e avanza!
Allegra e veloce, viva la nostra Rivoluzione!»
Tra tutte le guerre che han devastato il corso della storia,
questa è l’unica grande giusta guerra.
Note
1. Majakovskij allude qui agli orrendi delitti commessi dalle truppe bianche, di cui Mamontov fu uno dei generali, e dai giapponesi, durante gli anni 1918-1922. I giapponesi, infatti, nell’aprile del ‘20, attaccarono Vladivostok e arrestarono i dirigenti bolscevichi dell’Estremo Oriente, Lazo, Lutski e Sibirtsen, i quali furono bruciati nel forno di una locomotiva. I giapponesi perpetrarono atrocità incredibili anche nelle altre città orientali.
2. La salute di Lenin era peggiorata: il 9 marzo del 1923 sopravvenne una crisi che lo inchiodò a letto; a metà maggio fu trasferito a Gorkij. Parve che si riprendesse, fece anzi una visita a Mosca, ma dovette ritornare nuovamente a Gorkij. Quello sarà il suo ultimo viaggio a Mosca. Il 21 gennaio 1924, alle sei di sera, senza che nessuno se l’attendesse, si manifestò una crisi acuta. Lenin perdette conoscenza. Alle 18 e 50 moriva di una emorragia cerebrale. Nella notte dal 21 al 22 si riunì l’Assemblea plenaria del Comitato Centrale del Partito Bolscevico. Lo stesso giorno Kalinin comunicò al Presidium dei Soviet la triste notizia. La morte di Lenin fu annunciata a tutti i lavoratori con un messaggio diramato dal Comitato Centrale.
3. Si tratta del Grande Teatro di Mosca, dove il 26 gennaio, nella seduta del Secondo Congresso dei Soviet dell’U.R.S.S., fu tenuta la celebrazione funebre di Lenin.
4. Il 23 gennaio, alle ore 10 del mattino, il feretro con le spoglie di Lenin venne portato a braccia da Gorkij alla stazione di Gerassimovo, e alle 13 il convoglio funebre arrivò a Mosca, alla Stazione Paveletski. Di qui, sulle spalle degli amici e compagni più prossimi, fra uno stuolo di bandiere e centinaia di migliaia di uomini che facevano ala, il feretro fu portato nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati. Dal 23 al 27 gennaio, durante quattro giorni, nonostante il gelo eccezionale, una folla immensa sfilò nella Sala delle Colonne per portare l’estremo saluto a Lenin.
5. Il 27 gennaio, alle 9 del mattino, le spoglie mortali di Lenin furono portate dalla Casa dei Sindacati sulla Piazza Rossa, sotto il Muro dei Comunardi, dove riposano i primi eroi della Rivoluzione. Qui il popolo salutò ancora il suo capo. Poi alle 16, alle note di una musica funebre, all’urlo di migliaia di sirene di tutte le fabbriche, al rombo dei cannoni, Lenin fu deposto nel Mausoleo. (La «Via Tverskaja» e la «Via Dimitrovka» sono oggi «Via Gorkij» e «Via Pushkin».)
6. Si tratta delle delegazioni operaie dei paesi capitalistici.
7. Nadeshda Konstantinovna Krupskaja, la fedele compagna di Lenin.
8. I lavoratori sfilano per l’ultima volta davanti alla bara di Lenin, fissando in alto le lancette dell’orologio della torre Spasskaja, che per ognuno di essi misura gli ultimi istanti dell’addio. Majakovskij supplica il tempo di fermarsi, di non battere le ore.
9. La morte di Lenin mostrò quanto il Partito fosse legato alle masse. Gli operai più coscienti e i giovani domandarono, come a colmare il grande vuoto che Lenin con la sua scomparsa aveva lasciato, di entrare a far parte del Partito. Il Comitato Centrale accolse questo spontaneo movimento degli operai e aprì la «leva leninista». In brevissimo tempo più di 240000 operai si allinearono sul fronte del Partito: «La morte di Lenin – è diventata il primo – degli organizzatori comunisti».
10. Il «Komsomol» è l’organizzazione dei giovani comunisti.