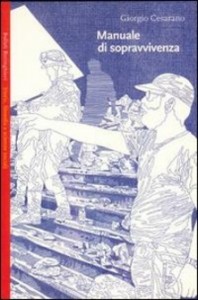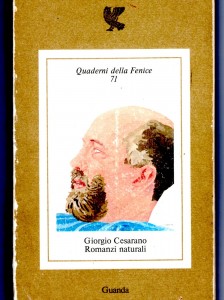Cesarano. L’insurrezione erotica
apr 18th, 2020 | Di Thomas Munzner | Categoria: Recensioni(Autocritica della corporeità metaforica)
da Manuale di sopravvivenza, Dedalo, Bari, 1974
1
“Unificazione vera, amore vero e proprio, ha luogo solo fra viventi che sono uguali in potenza, e che quindi sono viventi l’uno per l’altro nel modo più completo, e per nessun lato l’uno è morto rispetto all’altro. L’amore esclude ogni opposizione; esso non è intelletto le cui relazioni lasciano sempre il molteplice come molteplice e la cui stessa unità sono le opposizioni; esso non è ragione che oppone assolutamente al determinato il suo determinare; non è nulla di limitante, nulla di limitato, nulla di finito. L’amore è un sentimento, ma non un sentimento singolo”
Hegel, L’amore, la corporeità e la proprietà.
0.
La sensazione di pena e mancanza suscitata dai rapporti formalizzati, fa sì che l’esigenza di spezzarne i limiti, per superarne la miseria più evidente, si manifesti come desiderio di farli “saltare” mediante l’irruzione della sessualità. Ma si tratta ancora di un riflesso della miseria, un corto circuito in cui l’intolleranza immediatistica del minimo cui è ridotto il tessuto sociale gli avvicina il massimo cui riesce a tendere, in condizioni di umiliazione e di fame, il desiderio, facendo apparire i due “estremi” come e prossimi quasi comunicanti, non appena l’intenzione qualitativa spezzi la separazione. Ma si svela così l’illusione. Né ciò che manca ai rapporti degradati è la sessualità, né la sessualità così com’è, storicamente determinata, punto più alto in cui la valorizzazione isola il piacere come salario della passione addomesticata al lavoro (prestazione energetica, investimento di tempo-denaro), può concentrare in sé ogni requisito qualitativo. Il dissequestro della qualità e del piacere è il compito rivoluzionario destinato a scongelare il feticcio della sessualità e, al tempo stesso, liberandola dai suoi falsi contenuti surrogatizi, magico-religiosi, a dispiegarne la ricchezza stornata. L’erotizzazione dei rapporti, la realizzazione qualitativa del loro tendere alla totalità, non vedrà più la sessualità né come mezzo, né come fine, ma come momento significativo del rapporto essenziale tra le qualità del vivente.
1.
“È solo nella violazione — al livello della morte — dell’isolamento individuale, che fa la propria apparizione quell’immagine dell’essere amato che per l’amante rappresenta il senso di tutto ciò che esiste.” Così Bataille (L’erotismo, Mondadori, p. 28). Ma l’isolamento individuale di cui parla è la prigionia nella figura di sé — violarne il fortilizio è davvero un rischio mortale —: l’apparizione di “quell’immagine dell’essere amato” è innanzitutto l’apparire della liberazione possibile, nella coniugazione col mondo, il senso appunto di tutto ciò che esiste. Al di sotto di ogni psicodramma dell’amore, negli inferi della carcerazione in sé, questa è la tragedia: l’al di là di sé appare come una “immagine”, una cifra simbolica della totalità agognata. Essa risplende di tutta la forza cresciuta nella compressione della manque à être, non tanto perché ne sia la proiezione allucinatoria (e in questo senso fittizia), quanto perché effettivamente la manque conosce e chiama l’être che le è assente, sa che esiste fuori dal sé, lo aspetta e lo cerca da sempre. L’immagine è dunque la promessa d’essere, e, insieme, la dimostrazione della sua concreta possibilità. Essa è infatti incarnata; è, come infelicemente ma realisticamente si è abituati a dire, una “persona”, ossia la maschera di un dramma, ma la maschera indossata da qualcuno che è, o più esattamente desidera essere. Una menzogna antichissima, e un’allucinazione sempre nuova, istituisce a questo punto una simmetria perfettamente illusoria. Due “persone” si trovano l’una in presenza dell’altra, si desiderano e si amano, non gli resta che congiungersi. Ma due “persone” non possono, letteralmente, congiungersi: non appena si apprestano a farlo, ecco che si separano, tanto più sostanzialmente quanto più formalmente il congiungimento appare ricco e animato. La ricchezza è accumulazione di forme metonimiche, l’animazione è di figure, di cartoons. L’ostinazione cieca con cui due “persone” si sforzano di congiungersi è simile a quella con cui taluni animali, e i bambini, si sforzano di lottare, o di congiungersi, con la propria immagine riflessa nello specchio. A fronteggiarsi sono infatti due immagini reciprocamente speculari, e speculari particolarmente nella loro diversità (l’alterità sessuale e/o l’alterità fisiognomica, in senso lato) e nella loro specificità individuale.
2.
L’angustia — la sofferenza di cui parla Bataille (“l’amore ci impegna pertanto alla sofferenza, poiché la piena fusione è apparente; e tuttavia l’amore promette la fine della sofferenza”, ibid.) — implacabilmente soffoca il piacere in questo cozzo di due architetture o “macchine”, belliche e carcerarie insieme. Ciascuno è per l’altro ciò che non è in sé. Ciascuno, per incontrare l’altro, deve uscire da sé. Di questo è fatta l’estasi, questa sortita armata fuori dal fortilizio del sé. Ma non appena l’estasi tende a spiegarsi, ad affermarsi, negarsi come istante e cercarsi come totalità e come durata, l’altro si svela essere come una pietra o un albero, o come un idolo: un oggetto, una “cosa”, un’entità comune al mondo delle cose, una cosa del mondo in cui il fortilizio ha fondamento. In questo, l’altro indica già, nell’istante stesso dell’estasi, la via del ritorno alla prigione, segnalandosi come cosa dell’orizzonte della prigione, significandosi come la pochezza in cui si disconoscono desideri e volontà, in cui si riconoscono frustrazione e inanità. Questo è vero per ciascuno; è così che gli amanti conoscono insieme e nel medesimo movimento la gravità del progetto contenuto nel desiderio e la miseria della sconfitta espressa dalla mancata realizzazione. O meglio: dalla realizzazione della mancanza. Ma guai a chi, di questa banalità del proprio destino, fa la trappola in cui va a morire ogni destino. Chi cessa di progettare l’evasione, chi cessa di osare tendervi e di detestare la miseria della carcerazione nel sé, muore chiuso nel sé, fa di sé la storia di una morte mentre muore alla storia, pone fine alla sua via mentre resta un ciottolo della grande via.
3.
L’amore, prescrive il cinismo dei proverbi, è una lotta. Di questa saggezza miserabile si inorgoglisce il sorriso dei vili: a che vale, muoversi alla ricerca dell’estasi, quando sai che non potrai trovare se non il corpo del niente, che il desiderio della fusione e della sortita dalla prigionia si conoscerà, stravolto, come un corpo a corpo di fantasmi? Se è anche vero che l’amore è una lotta, è più vero che la lotta è di ciascuno contro la propria miseria e contro la propria prigionia. Non si lotta contro l’altro, si lotta contro il sé. Nessun manuale di strategia amorosa vede la moralità di questa lotta. È più osceno il presunto realismo delle “astuzie” d’amore che le eiaculazioni sul viso della pornografia. Bataille scrive, temerariamente: “L’essere amato è, per chi lo fa oggetto d’amore, la trasparenza del mondo. Ciò che attraverso l’essere amato appare (…) è l’essere pieno, illimitato, cui l’individualità non oppone più barriere”. L’essere amato è la trasparenza del mondo finché non si riduce ad apparire come l’oggetto d’amore, e non appena appare come l’oggetto d’amore ogni trasparenza dilegua, l’opacità spezza lo sguardo, la specularità lo fa regredire al passato. Guarda l’essere che ami nel cuore di un paese: vedrai, se l’amore è forte, quanto è grande il paese del tuo cuore, e come esso è un regno, e come la tua e quella dell’essere amato volga ad essere la signoria senza schiavitù. Ma guarda ancora l’immagine della persona che ami al centro di un paesaggio: vedi la serva-padrona che fu tua madre e il forzato-sbirro che fu tuo padre, al centro focale del tuo passato, proiettato come un incubo onnivoro e ossessivo, sopra ogni presente, contro ogni futuro. Fai del progetto amoroso un oggetto d’amore e vedrai il tuo passato come la barriera specchiante che ti separa dal presente.
4.
Sei mia sono tua, la mia donna, il mio uomo: l’essere è già sgominato, l’avere già si impone con il suo contenuto di niente. Eppure non è liquidando la fedeltà alla scelta, la temerarietà di un progetto comune, che si supera la pietrificazione e l’annientamento. Se è vero che due amanti giacciono l’uno “con” l’altro come due amuleti, o due figure di un gioco tetro, o due bracci di un congegno, è però vero che essi solo così trattengono, nella loro ostinazione a volere, e anche quando essa appare come un’immotivata coazione a distruggersi, il sogno di una cosa che è al di là della cosalità in cui giacciono, il progetto d’essere che effettivamente è la loro sola ragione d’esistere, il loro solo onore, e il solo onore che trapassi l’atrocità dell’infanzia.
5.
“È, in una parola, la fusione dell’essere visto come liberazione a partire dall’essere dell’amante” scrive ancora Bataille, e: “C’è in quest’apparenza un’assurdità, un’orrenda mescolanza: ma, al di là dell’assurdità, della mescolanza, della sofferenza, splende una verità miracolosa. Niente, a conti fatti, è illusorio nella verità dell’amore: l’essere amato equivale, per chi lo fa oggetto d’amore, e naturalmente solo per chi lo faccia oggetto d’amore (ma che importa?) alla verità dell’essere. Vuole il caso che, tramite l’oggetto d’amore, sparita la complessità del mondo, l’amante scorga il fondo dell’essere, la semplicità dell’essere”. Ciò che l’amante vede nell’amato, l’ho già detto, è la concretezza possibile esistente fuori di sé, nella generalità, di un progetto d’essere che è, al tempo stesso, suo e non-suo, squisitamente personale, individuale e unico e patentemente sovrapersonale, comunista, “storico”. L’indulgenza ipocrita con cui l’universo mondano tollera la presenza degli amanti maschera a malapena l’astio e l’intolleranza per ciò che sempre l’amore trasmette d’eversivo, e lo maschera facendosi forte sulla comicità patetica, sulla goffaggine degli amanti. Coloro che incespicano tenendosi per mano. Coloro che “si illudono”. La mondanità pregusta la vendetta storicamente preparata. Finirà, quell’amore, come tutti gli altri, nel risentimento e nel vuoto; si accomuneranno, quei comunisti, alla comunità dei relitti e della desolazione. Ah sì, l’orrenda mescolanza prepara effettivamente in anticipo una sconfitta certa. Finché la vita non sarà liberata, ogni battesimo è un memento mori, ogni abbeverata un avvelenamento.
5 bis .
La misura individuale si conclude nella morte, solo la specie, la comunità totale, possiede la misura della vita verso la quale procede. Ma la vita realizzata riscatterà dalla morte l’individuo, non appena gli consentirà di superare la dimidiazione, di fondersi, indiviso, con la totalità, nel flusso del processo.
6.
Tutto, “a conti fatti”, è illusorio nell’amore, se si tratta di fare i conti. L’essere amato equivale davvero, per chi lo fa oggetto d’amore, alla verità dell’essere: le equivale nel senso che ne è la cifra simbolica, la moneta-figura. L’oggetto è l’equivalente generale dell’essere, in una circolazione di capitale fittizio in cui l’essere ha per requisito essenziale quello di mancare. Non si capirà mai a sufficienza la portata positiva di ciò che è assenza. Ciò che manca è potente, ciò che manca si impone d’essere, di ciò che manca il processo nutre la sua dinamica inseguitrice.
7.
Si disperi chi vuole, di non avere: avrà pure saputo perché desiderava. Di tanto piangere mormorando in debolezza a margine, sulla vita che è fuggita, la vita se ne fotte, scorrendo per miliardi di esseri nuovi, fiume gonfio inarrestabile. La lotta passa attraverso i corpi accesi nella forza della passione. “Oh!, lungo il cammino delle generazioni, la luce!… che recede, recede, … opaca… dell’immutato divenire. Ma nei giorni, nelle anime, quale elaborante speranza!… e l’astratta fede, la pertinace carità. Ogni prassi è un’immagine,… zendado, impresa, nel vento bandiera… La luce, la luce recedeva… e l’impresa chiamava avanti, avanti, i suoi quartati: a voler raggiungere il fuggitivo occidente… E dolorava il respiro delle generazioni, de semine in semen, di arme in arme. Fino allo incredibile approdo.” (C.E. Gadda, La cognizione del dolore, Einaudi, pp. 84-85).
8.
A chi si lascia spegnere non resta che il suo piagnucolare. Io, io, io. “… Il solo fatto che noi seguitiamo a proclamare… io, tu… con le nostre bocche screanzate… con la nostra avarizia di stitici predestinati alla putrescenza… io, tu… questo solo fatto… io, tu… denuncia la bassezza della comune dialettica… e ne certifica della nostra impotenza a predicar nulla di nulla,… dacché ignoriamo… il soggetto di ogni proposizione possibile…” (C.E. Gadda, op. cit., p. 124) Il cazzo piccolo, la fica frigida, il pene-clitoride, la famiglia assassina, gli amici bastardi: fosse andata altrimenti, si fosse potuto avere! E potessero riuscire a parlarsi: come vedrebbe quanto nessuno ha, come si è tutti identici nella deprivazione e nella “sventura”, come a ciascuno accade lo stesso mortificante gioco di tarocchi truccati, grazie al quale non uno riesce più a scorgere ciò che realmente vive, o potrebbe vivere non appena sorreggessero passione incarnata, desiderio concreto, volontà di realizzarsi. Contempla invece affamato le illustrazioni dello splendido Altro, immensamente profuso di tutto ciò che gli manca. A questo almeno, ed è molto, gli amanti sanno brevemente scampare. Essi si guardano, dunque sanno vedersi. Si desiderano, dunque si riconoscono. Si deludono, dunque sanno che cosa cercano. Si odiano, dunque sanno di non bastarsi.
9.
Tramite l’oggetto d’amore, sparita la complessità del mondo, l’amante scorge il fondo dell’essere, la semplicità dell’essere? Addomesticato al feticismo religioso, Bataille non distingue tra l’essere e il simbolo, la “figura”. È vero che la complessità del mondo — il labirinto in cui indementisce ognuno, perdendosi nella propria architettura — sparisce nella contemplazione dell’oggetto d’amore. Ma è, questo, l’istante e lo spazio che coniuga due mondi, il sito-tempo in cui simbolo e essere coesistono, liturgia e verità si combattono compresenti. È quando l’oggetto d’amore — il feticcio dell’essere — si fa trasparente fino a svelare d’essere una via, un movimento, una sovra-agnizione, un’iniziazione, quando perde la sua opacità d’oggetto e fascinazione di feticcio, che veramente l’amante scorge, non il fondo, ma il principio dell’essere possibile, e la sua semplicità luminosa e terribile. È in questo istante che l’amante conosce la gravità dell’impresa, è ora che vede l’amore come conquista e superamento, come comunione al di là del sé, lotta per la vita, come comunicazione concreta e pragmatica del possibile, come insurrezione.
10.
Gli amanti corrono per mano verso un’acqua lustrale, esattamente come negli shorts pubblicitari verso un sale da bagno o una cocacola. Gli amanti si accaniscono a spillarsi l’uscita da sé, esattamente come nei coiti della pornografia. Ma nessun mercenario della regia riuscirà mai a profanare la sacralità di quella corsa, la solennità di quella lotta, per quanto si incanaglisca a dilapidarne le immagini, ad affogarle nel gorgo della mercede che lo strangola, fecale. In questo ogni immagine conserva una sua innocenza: nel potere resistente dell’evocazione, e al tempo stesso, nell’evanescenza manifesta della sua natura di simulacro.
11.
Il capitale ha creduto di liquidare facilmente la resistenza millenaria dei contenuti radicali manifesti nella sacralità delle situazioni topiche. Non ha potuto che saccheggiarne l’iconografia. Sorprendentemente, neppure questo gli è riuscito senza danno. Schiacciata sotto i rulli delle macchine da stampa, l’immagine dell’uomo futuro, racchiusa nella corporeità di ogni essere, è sempre capace di resuscitarsi. In un brivido, per un istante, come per equivoco, in un colpo d’occhio distratto, a tradimento, tra una trivialità e uno sbadiglio, tra l’una e l’altra parola del vuoto, un occhio improvvisamente ti fissa, un seno respira, una mano pulsa, un ventre trasale. Un secondo sguardo non troverà che la patina della carta, la lattescenza dello schermo; uno slogan si precipiterà a suturare la fêlure minima aperta nella corteccia del cinismo d’obbligo. Non è accaduto niente, e il lutto si rassicura: sei morto come sempre, in uno sterminato campionario di illustrazioni ferali. Ma non è mai vero del tutto, e lo è sempre meno. È tempo di invertire la prospettiva, di saper vedere l’estrema fragilità della catalessi imposta dal capitale. È tempo di capire che l’ineroe nihilista, questo egotista dell’autodistruzione e dell’annientamento, ha i nervi a pezzi, e che persiste con crescente difficoltà. Nessun ottimismo è lecito sulla facilità dell’impresa, ma è tempo di non lasciare accidiosamente ingrassarsi il verme del pessimismo.
12.
Se due “persone” non possono mai veramente congiungersi, ma soltanto vieppiù separarsi, è dunque vero un altro proverbio della “realpolitik”, secondo il quale l’estasi dell’uno comprende necessariamente la disillusione dell’altro? Si tratta ancora una volta della consumazione di un sacrificio? Da quando la schizofrenia è una condizione del sociale, ciascuno si guarda vivere sentendosi morire. Innanzitutto, chi è il soggetto reale: l’io che guarda? L’io che “agisce”? Alla soglia dell’estasi, uno dei due deve morire. È questo, il sacrificio necessario. Ogni sortita dal sé, è un’uccisione di sé.
13.
A trattenerci dal soccombere è la medesima dimidiazione che ci trattiene dal vivere: due nemici mortali si guardano con reciproco terrore all’interno della segreta dove il sé dubita senza fine. Sortirne, significa sboccare nella certezza. Uscire da sé significa conoscersi senza alcun dubbio. La fusione di cui parla Bataille, la fusione che ti fa individuo, essere indiviso, è innanzitutto la scomparsa sanguinosa dell’altro che è in te. L’amato è la comparsa prodigiosa dell’altro fuori di te l’occasione magica di un rapporto reale. Ma come è questo, è anche la “comparsa”, in senso teatrale, di un alter-ego.
14.
“Provami che non esisti solo nella mia immaginazione”: ossia provami che non sei una figura di me. Perché se lo sei, devi morire. Nessuno può tollerare un altro sé, fuori di sé. Dunque è vero: “Nel sacrificio non c’è solo il denudamento, ma c’è anche l’uccisione della vittima, o almeno l’eliminazione, il bruciamento di un oggetto inanimato.” (Ibid., p. 29). Ecco: l’oggetto inanimato è la “cosa” che l’estasi sacrifica, e che nell’estasi scompare. Nell’estasi “muore” la morte. Non ho motivo, qui, di inventariare casistiche intorno alle combinazioni possibili. Sapere che sono numerose basta a spiegare perché l’estasi simultanea di due amanti è un evento di difficile realizzazione. Occorre specificare che non si sta parlando di “orgasmo”?
15.
Chi parla di fusione estatica pensando che si tratti di sincronizzazione degli orgasmi può seguitare a credere che nelle rubriche dei sessuologi si tratti d’amore, ma chi d’altra parte ne parla come qualcosa che non riguardi il venirsi reciproco degli amanti, non sa di che cosa parla.
16.
Si sta dunque parlando anche di orgasmo. Per quanto vi si trattiene di pertinente alla conquista della totalità, alla fusione unitaria, flusso liberato e dissequestro della corporeità. Tuttavia, Reich non ha avuta tutta la ragione. Solo una condizione storica di estrema miseria ha fatto sì che l’orgasmo apparisse come l’unica estasi possibile; ricorresse, nel ciclo della “rareté” come l’esclusivo riferimento concreto e corporeo alla fusione e alla conquista di una dimensione totalizzante. Ma è proprio concretamente che l’orgasmo si rivela come un valore sancito dalla penuria, rispetto al progetto di essere dal quale è pur vero che scaturisce. Come ogni limite o soglia, partecipa di due spazialità. Dalla segreta del sé alla totalità del corpo, eppure non è un uscio che si apre, quanto uno specchio che fonde. Il prigioniero diviene re, un re nudo, ed è il vero re; poiché è nudo, non si può che riconoscerlo. Troppo brevemente. Il freddo annuncia il ritorno degli incappucciati.
17.
“La vittima muore, gli spettatori partecipano d’un elemento che ne rivela la morte.” (Ibid., p. 29) Ma sono loro, gli spettatori, sono essi i sicari. Ognuno conosce, nello strangolamento dell’ultimo e già remoto spasmo, queste presenze di esecutori. La fine dell’orgasmo è sempre un’esecuzione capitale. La testa cade nella cesta dei giocattoli, il recipiente da cui sortirono ab initio gli spettri del pavor nocturnus. Non finisce mai di riprodursi la medesima tragedia preverbale. Tutto qui? Soltanto a voler essere più realisti del re spodestato.
18.
Se Reich redivivo vedesse la “liberazione sessuale” tremerebbe annientato nell’angolo. La vittima muore, dunque, e gli spettatori partecipano d’un elemento che ne rivela la morte. “Quest’elemento è ciò che potremmo definire, usando la terminologia cara agli storici delle religioni, il sacro. Il sacro è esattamente la totalità dell’essere rivelato a coloro i quali, nel corso di una cerimonia contemplano la morte di un essere frammentario.” (Ibid., pp. 29-30). Sappiamo chi sono, gli spettatori. Va detto una volta per tutte che non esistono in nessun luogo spettatori innocenti di uno spettacolo, ma sempre esecutori di un rito: liturgia, sentenza, linciaggio. Sempre è uno spettacolo di morte. Ancora sempre sono tutti a morire. E ognuno muore in atterrita solitudine, ucciso da tutti gli altri. Ogni morte solitaria è insieme un massacro, ogni massacro un suicidio.
19.
“Si determina, a causa della morte violenta, una rottura della frammentarietà di un essere: ciò che sussiste e che nel silenzio che sopravviene provano gli spiriti ansiosi è la totalità dell’essere, alla quale è ricondotta la vittima. Solo una messa a morte spettacolare, operata in condizioni a loro volta determinate dalla gravità e dalla collettività della religione, è suscettibile di rivelare quel che di regola sfugge all’attenzione.” (Ibid., p. 30). Stiamo in guardia: attenzione a questo insinuarsi della negatività, attraverso l’ipnosi religiosa di Bataille. Come ognuno che veda remota nei cieli la terra promessa, ogni volta che parla di vita è un doganiere che riscuote il trapasso. Ma chi sono questi “esseri” assorti, “spiriti ansiosi”, e che totalità dell’essere provano, cui è “ricondotta” la vittima? Questa assise di carnefici, incadaveriti, questa orrida eucarestia del non-essere qui, per “essere” non-qui. L’orgasmo pone fine all’ansia, sentenziano i sessuologi, e la ragione che possono avere è quella sancita dagli incubi di maggioranze di frigidezze, di eiaculationes precoces, cui l’ansia di giungere alla fine dell’ansia strangola in limine ogni decollo verso la potenza. L’ansia di questa assise di morti caccia ogni presente lontano dalla gioia. Essi sono, dunque, i sicari che presenziano l’uccisione di ogni estasi, essi gli esecutori. Nessuno ignora questo venire a morte nella spettacolarità, questo lasciarci la pelle al centro della piazza. “Mi fai morire”, dice, tentata a vivere, la ragazza che viene. Letto a due piazze, appunto. Lite di condannati. Questo soltanto?
20.
Il corpo è forte. La sua caparbietà, il resuscitare inesausto della fame, non è qui una dialettica? La scherma magistrale del desiderio ne è una lezione. La sacralità del piacere: la promessa. Nessuno, si dice, è capace di ricordare la sensazione dell’orgasmo. Là dove si verifica la fusione istantanea di corpo e mente, la memoria brucia come una valvola. La memoria è il terminale dell’apparato che disgiunge il corporeo dal mentale. La sensazione dalla riflessione. È il custode vigilante del non-essere coatto. La memoria è la funzione del dimenticare, non del ricordare. Ogni censura, ogni rimozione, ogni rimozione della censura, è opera della memoria. Ogni oblio del proprio senso. La memoria è il sigillo di garanzia del memento mori. Il sacro, questo apparire disparendo. Apparire dell’essere nella sostanza, disparire nella forma che la memoria cristallizza, per celarlo. Per farlo morto. Il senso vivo nascosto dalla forma che il senso morto immobilizza per occultarlo. Tutto questo “sesso” nel dominio apocalittico del capitale. Tutte queste forme denudate di cazzi e fiche. Come sognare, ancora, freudianamente, spade, scrigni? Rupi, polle? In tutto questo filo spinato di peli pubici. Sperma glacé, glandi tostati, ostii brasati, alla mensa ufficiali dei cresimati. Questo il mio corpo, questo il mio sangue: Vostro Padre Capitale.
21.
E tuttavia davvero può essere il tuo corpo, il tuo sangue. Come sa la trivellazione vertiginosa dell’onania. Al di là dell’immagine, ancora la freudiana polla, lo scrigno. Nell’ombra della morte. Non sai se sta per scomparire o per incombere. Se sei stato per resuscitarti o per ucciderti. L’acredine della lotta si essica odorando. Te ne lavi le mani. Tornerà. Ti inebrierai di nuovo al sentore di te. Procederai galoppando. Immagini dietro immagini. Ma la folgorazione, lo spasmo e la delizia: irrevocabili, e immediatamente revocati. Quanto competente cinismo nell’iconografia patinata, e brutale cognizione del dolore. E quanto simmetrico terrore inane, nell’iconoclastia sessuofobica dei gauchisti. Non voler vedere, non voler sapere. L’ideologia della polla, come l’ideologia della natura, giusto al momento storico in cui ogni polla schiuma di tossici, ogni natura germoglia profitto e spine. Attenzione, neoadamiti, la vipera è tornata.
22.
Mai così cedevoli le vagine, e mai così immemori. La rosa mistica, il bocciolo promesso al di là della battaglia contro il drago. Ad esso procedeva il cavaliere inastato. Chi ricorda più questi sensi dell’incedere sacro verso il piacere quale conquista? Il principe che si suscita, baciato, dal rospo; la beltà dormiente nella foresta; la prigioniera della torre e la sua treccia… I miti fiabeschi ci mentivano, ma quale menzogna è più disarmante della nudità scevra di magia? Questi corpi desolati. Grami come aree edificabili. C’era più passione nel maniacale libertino che collezionava dessous, di quanta non se ne trovino in cuore questi trasognati neoadamiti, nudi della nudità dei lager.
23.
Almeno, non se ne inorgoglissero. Covi, in taluni, la “morbosità”, resista il bilico del “peccato”: qualcuno seguiti a sapere che la via attraversa l’“inferno”, se dall’inferno vuole uscire. I più timidi. Nel batticuore dell’erezione azzardosa, nella trepidazione della vagina difficoltosa. Guai alle slot-machine dell’orgasmo, guai ai flipper dell’eiaculazione. Nessuno restituirà loro l’avventura e la conquista scialacquate. La dialettica è nell’ambivalenza dei desideri e dei terrori, nel porsi in dubbio del sangue, nel negarsi-profondersi dei corpi. Ogni ritualità ha oltrepassato, verso l’interno, i confini delle scorze, cortecce, epidermidi. La drammaturgia è ormai viscerale. Un ciclo sta per concludersi: all’origine, il corpo sacrificato proiettò la pena della manque e la premonizione dell’intierezza su tutte le figure in cui il sacro prese forma; ormai l’eclissi del sacro preannunzia la sintesi dello scontro ultimativo, conquistata dalla corporeità prossima all’essere, al di là dell’alienazione istintuale e al di là della alienazione razionale. Hic Rhodus, hic salta. Ma il piede che si carica dello slancio conoscerà, prima di lasciare la proda dello Stige, la forza contenuta nella forma della sacralità: l’orma profonda del lunghissimo slancio, verso la conquista reale dell’essere nella vita, oltre. Tra gelo e febbre, sentiamo tutti che questo è un tempo solenne. Siamo noi gli assorti “spiriti ansiosi”, quando l’attesa è della forza, quando il sacrificio che si prepara è quello della morte. Siamo noi i sicari, i giustizieri, finalmente i vendicatori: cerchiamo la gola, i testicoli della morte. Sono nostri l’urlo, il salto, il colpo che stronca o eviscera, dobbiamo rivendicarli. Corri, corri, spettacolo (1), alla tua morte nel tuo fine.
24.
“L’esperienza mistica legata a certi aspetti delle religioni positive, si contrappone a volte a quest’approvazione della morte fin dentro la vita, in cui vedo il senso profondo dell’erotismo. Ma la contrapposizione non è mai necessità. L’approvazione della vita fin dentro la morte è una sfida, e ciò tanto nell’erotismo dei cuori che nell’erotismo dei corpi: una sfida alla morte lanciata dall’indifferenza. La vita è accesso all’essere; se la vita è mortale, la totalità dell’essere non lo è. La vicinanza della totalità, l’ebbrezza della totalità, domina la considerazione della morte. In primo luogo, il turbamento erotico immediato ci conferisce un sentimento che supera ogni altro, per cui le cupe prospettive connesse alla condizione dell’essere individuale cadono nell’oblio. Poi, al di là dell’ebbrezza connessa alla giovinezza, ci è dato il potere di contemplare la morte in faccia, e di scorgervi infine l’apertura alla totalità inintelligibile, inconoscibile, che è il segreto dell’erotismo, e di cui solo l’erotismo possiede la chiave.” (Ibid., pp. 31-2). Rifletta ciascuno da par suo di fronte a questa parole di Bataille. Ha la potenza ieratica di un esorcismo. E ne ha la debolezza terrorizzata. È la parola di un nemico, raccolto in positura di combattimento dinnanzi al varco che intende nascondere. Immediatamente al di là di questo servo-soldato di Cristo, si apre la via per comprendere, per iniziare ad accedere. Sappia ciascuno vedere questa figura di guardiano, così vicino allo spazio della luce da esserne compenetrato e scolpito. Scelga ciascuno il punto dove colpire. Questa parole che esorcizza l’amore, questa figura illuminata del divieto alla luce, è in ciascuno di noi (nei migliori dei casi). Facendola fuori, si procede.
25.
“Come ho detto, l’erotismo appare ai miei occhi come quella condizione di squilibrio in cui l’essere pone se stesso in forse coscientemente. In un certo senso, l’essere si smarrisce oggettivamente, ma allora ecco che il soggetto si identifica con l’oggetto che si smarrisce. Se è necessario, potrei dire che, nell’erotismo, IO mi perdo.” (Ibid., p. 37). Certo: è necessario. Ma l’Io che si perde nell’erotismo, l’Io che tenta di perdersi, è forse il soggetto reale? E chi è colui che si identifica con l’oggetto che si smarrisce? Quelle bataille! Chi vuole perdersi? Chi conquistarsi? Liberarsi dell’Io, questa è la battaglia. Perdere le proprie catene, corpi di tutto il mondo, di tutta la preistoria. In quel getto minimo? In cui il cinismo dei proverbi vuole ravvisare il pianto (omne animai post coitum triste)? Ma dov’è, dove è stato nascosto lo scatto, il golpe dialettico che rovescia come una clessidra i termini del tempo, mentre l’impresa è in corso, e fa sì che più proceda, più torni sui suoi passi? Il soggetto è colui che conquistando l’estasi, realizza il potere di esserci. Colui che si fonde, coniugandosi con la totalità. Che importa, per un istante, se tutto oggettivamente si raggruma in un poco di umore sparso, se di tanta vastità e di tanto fulgore non resta che l’affanno di chi, ritrovandosi, si sta perdendo? Ma si sta perdendo: fu un istante. La continuità è il non-essere, il tempo di ferro e di carta del capitale, l’obbligazione contratta e che contrae, il Nome del Padre, l’affermazione della morte continua nella vita intermittente, l’Io tuo signore nella schiavitù ignominiosa, l’animale che si raggrinza, la pudenda che si imbavaglia, la nevrosi l’ossessione la paranoia la melanconia la ciclotimia: la diagnosi che “spacca il cuore della gnosi”. L’Io è colui che non può.
26.
“Ma la volontarietà della perdita implicita nell’erotismo, è flagrante: nessuno penso ne dubiterà.” (Ibid., p. 37). Di questa certezza indubitabile si armarono i divieti: che non si perdessero, gli IO miserabili, o il tempo sarebbe esploso. Sorsero le figure assorbenti dei numi. A dio, a dio! Ma addio, numi e dei: siamo al dunque. Più miserabili e più sperduti che mai, perché così vicini alla perdita liberatoria dell’Io, così vicini ad essere, corpi fusi nell’aurora della totalità. Come rideranno, i liberi, i finalmente uomini, della goffaggine d’ogni “signore”, essi che saranno la signoria e la conoscenza, la potenza creatrice e il fine manifesto.
27.
“L’esperienza conduce alla trasgressione compiuta, alla trasgressione riuscita, la quale, se mantiene la proibizione, la mantiene per trarne piacere. L’esperienza interna dell’erotismo richiede, da parte di colui che la compie, una sensibilità per l’angoscia che fonda il divieto altrettanto grande che per il desiderio che induce a infrangerlo. È questa sensibilità religiosa, che sempre lega strettamente desiderio e timore, piacere intenso e angoscia.” (Ibid., p. 45). Aufheben, ma degradato alla balbuzie della coazione a ripetere. Abbiamo dovuto impararlo — inorridendo — che le cose (le “cose” della sessualità, le miserabili cose) stanno anche così. Ma per sapere che non è solo così, saperlo con il furore eversivo del corpo insorgente, nella ribellione alla ratio livellatrice; saperlo nel sogno, nell’incubo, nello struggimento con cui sentiamo l’estasi abbandonarci, l’essere recedere, il volto amato, lo sguardo amato, ricoagularsi, la vicinanza allontanare, l’affermazione negare, la verità smentirsi, la certezza rovesciare lo stomaco del dubbio. Tutti inchiodati alla “macchina” dove il divieto s’incrocia col desiderio? Tutti appesi alla ruggine e alla cancrena di questa parodia della dialettica? Militari di Cristo, tenetevi la vostra squadra euclidea, i perpendicoli retti, da sempre la croce ortogonale sbarra la curvatura degli spazi. Chi può soffrire l’angustia di questa ragioneria, come ridurre l’onore del vero a questa equivalenza da bottegai francesi? La “sensibilità religiosa”: ma può religare davvero qualcuno a un tariffario siffatto dell’Eros? Certo, essere è trasgressione: spezzatura dell’ingorgo, dell’occlusione. Ma l’infrazione-effrazione, l’uscita dalla prigione del sé, la perdita volontaria dell’Io, l’accesso battagliato all’essere, l’uccisione dello sbirro negatore, l’insurrezione, la sortita: a che varrebbero, se non immettessero immediatamente in una dimensione inequivalente, se non annientassero d’un colpo ogni ratio compulsiva, se non cancellassero ogni misura (se non smisurassero), se non irrompessero nella totalità, oltre ogni limite, ogni meccanica causale ed ogni suo sistema, ogni bilanciamento speculare, ogni nozione di ritorno, di ricaduta, di ripetizione, di riciclazione, di identità, di contrari? Se non introducessero alla dimensione sovra-preistorica del processo, se non rivelassero il senso unitario dell’incedere, se non dimostrassero lo splendore, irriconducibile a qualsiasi pretio, dell’individuo totale, inequivalente, l’individuo-mondo, l’essere invisibile dalla “mondanità” degli “individui” dimidiati?
Come il don Juan Yaqui di Castaneda (C. Castaneda, A scuola dallo stregone, Astrolabio), Bataille non vede la grandiosità di ciò di cui parla e di ciò che sperimenta (2), ma vede la regola: il senso del procedere s’acceca così al suo stesso fine, proiettando innanzi a sé, per non vedersi, l’immagine speculare della liturgia donde prese avvio, nella mondanità ormai remota (e così restituendosi, religato, alle ceneri da cui era sortito). Coerentemente, Bataille procede, nel campo minato dell’erotismo, affermando di cercarvi ciò che asserisce d’essersi lasciato alle spalle: lo spiritualismo, la religione. Procede infatti in un’armatura di crociato. Non mente, e torna a suo onore. Nessuno che sia radicale (che abbia attinto alle radici del dramma, disfacendosi di ogni psicodramma) consente senza porsi in guardia a un uso neutrale della parola religione. Esca Ulisse dal cavallo di Troia, lo riconosciamo all’odore. Scopra il volto, respiri lo zolfo, affronti il rischio della lacerazione a ogni passo. Ogni astuzia è denudata per sempre.
29.
“L’esperienza interna dell’uomo ha luogo nel momento in cui, rompendo la crisalide, l’uomo ha coscienza di infrangere se stesso, non già la resistenza oppostagli dall’ambiente esterno. Il superamento della coscienza oggettiva, che delimitava le pareti della crisalide, è legato appunto a questo rovesciamento.” (Bataille, op. cit., p. 46). Ab initio, la resistenza non è dell’ambiente esterno, ma dell’oggettività interiorizzata, della regola che ti commette implacabilmente in una costellazione oggettiva, separandoti innanzitutto da te, e facendo sì che ti “senti” e ti “guardi” come l’altro che sei tu. L’ambiente esterno, nel vissuto, viene dopo: è la catena (la concatenazione) causale, la “machina” (per chi vi si appende, la croce), il “dato” (cui sei dato, consegnato), lo pseudo-destino. Se ciascuno non fosse innanzitutto prodotto come il prigioniero nella crisalide — la larva dell’essere denegato, la larva che deve e non può, la “larva d’uomo”, seme del futuro detto non tuo, seme dell’al di là mediato dalla morte, seme del valore vigente nel disvalore — nessun “ambiente esterno” riprodurrebbe, per un istante di più la regola del divieto. Inutile cercare, nella catena causale, il punto d’origine: il pensiero lineare semplicemente non può rendersi conto delle strategie del processo, in quanto ne è il divieto prodotto a percepirle. La dialettica, sa intuire il processo, la sua dinamica ciclica, il gioco delle interazioni e delle retroazioni. Non qui intendo parlare di ciò. Ogni bambino sa, d’altronde, di che parlo: ogni bambino ucciso che resiste a spiegarsi nei sogni, rifacendosi strenuamente al principio, che è il principio della sua fine d’uomo. Si nasce alla morte, questa è la “vita”, questa la catena micidiale dei giorni, la quotidianità del non-essere. L’introibo è il sacrificio di sé. La continuità il lutto di sé. L’intermittenza dell’essere, l’insurrezione, la resistenza, la vera guerra civile, all’interno del palazzo dell’Io. Nessun Io gode nessun piacere. Al piacere — sintomo dell’essere — l’Io è sempre l’altro. Nessuna liturgia, nessun cerimoniale schiude all’Io l’accesso della gloria, nulla introduce il nulla nella totalità manifesta. “Esteriorità” e “interiorità” collimano nella scorza riflettente della crisalide, corteccia e corpo straniato. Il piacere, la gioia, la gloria dell’essere, negazione della negazione, affermazione della soggettività denegata, spezzano in un solo movimento i sigilli alla cella della corporeità, le mura dell’edifizio-Io e le porte del Palazzo d’Inverno; la regola interiorizzata e la legge, sua caricatura; il Nome del Padre e l’icona di dio; il forziere dei pubblici segreti e il tabernacolo delle banalità più esclusive. C’è ben altro nella dialettica reale, di quanto lo speziale Bataille voglia far intendere, con le sue equazioni e valenze derisorie, nihilista coerentemente cristiano.
30.
Per Bataille, dall’Australopiteco all’Homo faber, dall’Homo faber all’Homo sapiens, il farsi della specie coincide con il rifiuto della violenza (cfr., in op. cit., il capitolo II, Il divieto e la morte, pp. 47-56), rifiuto terrorizzato e fascinazione solenne insieme. Che la specie sui generis degli uomini si fondi su un inaudito rimando della vita, e che immediatamente la violenza stia a realizzarlo nel sistema più pragmaticamente annientatore mai conosciuto nel regno animale, il crociato non sospetta. Resta da intendere come possa, a partire dal rifiuto della morte, capire quale enigmatico rovesciamento presieda al divieto d’essere, da cui per trasgressione procede a suo dire esclusivamente ogni incedere nell’estasi. La violenza perpetrata contro la soggettività totale (e totalmente fusa nella presenza corporea) dell’infante, non è forse l’evidenza più certa di una devozione al non-essere che coniuga immediatamente ogni sussistenza alla perdita del sé totale, della presenza corporea, alla morte, la morte-in-vita, mentre, e nella medesima stasi (il raffrenamento coatto di ogni incedere), proprio nella morte si indica con tutta l’enfasi della religione necrofora l’estremo passo che immette alla totalità, alla comunità cherubica degli scorporati?
L’evidenza dispiace a chi non ha l’animo di affrontare davvero la bataille. Ciò che il raccapriccio per il cadavere (3) suggerisce ai vivi , è la colpa dell’uccisione continuata di cui sono vittime e correi, nella violenza biofoba della “vita” quotidiana, nell’“ordine” del lavoro penitente, produttore del tempo nato perso e degli spazi delineati dalla carcerazione. Le salme che la specie comincia e non finisce più di seppellire sono la testimonianza insopportabile di quanto i vivi seppelliscono ogni giorno in sé: di quanto resta di ogni “vita” erogata, salma-statua eloquente del tempo perduto. Qui sì, “funziona” una facile simmetria; qui l’allegoria ha l’evidenza di un materialismo storico innestato direttamente sulle braci inconsumabili dell’istintualità, sotterrata ma persistente: sulla sapienza sotterranea della corporeità che matura il suo lungo salto al di là dell’“animalità” e della “civiltà” insieme.
32.
Perché non sia più una necropoli, occorre che la comunità umana cessi di identificarsi con i “suoi” morti. Che la colpa di non-essere venga inumata con essi nella fine della preistoria, nella fine del tempo di produzione. La corporeità enigmatica della salma, vista dall’orrore di sussistere scorporati, alienati alla presenza in-stante, fu la figura di dio, l’idolo archetipo. Il terrore fu di chi restava, abbandonato al sopravvivere. Del quale guardava il senso freddato, irrevocabile.
1. Run, Run, Show (corri, corri, spettacolo) è il nome “d’arte” che si è dato Show I Fu, il produttore cinese dei film della violenza e dei massacri, dove l’antichissima arte marziale del Kung-fu viene utilizzata come spettacolo del corpo che uccide.
2. Diventare un “uomo di conoscenza”: “Un uomo va alla conoscenza come va alla guerra: vigile, con timore, con rispetto, e con assoluta sicurezza. Andare alla conoscenza o andare alla guerra in qualsiasi altro modo, è un errore, e chiunque lo farà vivrà per rimpiangere i suoi passi”. (Castaneda, op. cit. p. 42)
3. Cfr. Bataille, op. cit.
2
“...fin che l’amore toglie, in piena assenza d’oggetto, la riflessione, strappa all’opposto ogni carattere di un estraneo, e la vita trova se stessa senza ulteriore difetto. Nell’amore è ancora il separato, ma non più come separato: come Unificato; e il vivente sente il vivente. ”
Hegel
33.
[Premessa. La « famiglia » è uno strumento di produzione, storicamente delimitato, della soggettività fittizia. Una superficiale conoscenza della storia basta a rivelarla come una funzione accessoria e di secondo grado, rispetto alla produzione originaria dell'alienazione della soggettività reale alla « persona (maschera) sociale », produzione radicata a partire dalla creazione dell'utensile-linguaggio, in cui la specie realizzò materialmente l'inizio del movimento che la separò dalla condizione animale. La costellazione familiare è dunque già un prodotto culturale. Il suo apparire, ai sensi stessi, come l'origine e la cosmogonia, procede direttamente dalla lacunosità dell'immaginazione alienata. Il superamento dell'alienazione non consisterà semplicemente nell'abolizione della famiglia, ma nella capacità conquistata di demistificarne la tenacissima opacità di feticcio dell'origine apparente. Qui e oggi, la lotta è ancora, ancora per poco, contro il potere della sua seduzione all'annientamento.]
34.
Il desiderio di superare la miseria della coppia è un’evidenza che emerge non appena inevitabilmente ogni coppia si aliena dalla cognizione dialetticamente vissuta dell’estasi, quanto basta a riprecipitare ciascuno dei suoi componenti nel vuoto problematico del suo « sé ». Non altrimenti da come la caduta individuale nel carcere della presenza alienata al suo senso, coincide sempre con una restaurazione storicamente imposta dell’architettura dell’Io, (il « sopravviversi », dopo un movimento vitale, esprime sempre l’alternativa reale della sua ambiguità sensibile: la presenza come suicidio immanente e come premessa a ulteriori movimenti vitali), il serrarsi della clausura « nuziale » attorno agli amanti, che con tanta efficacia, mostrandoli come un « pieno plastico », li svuota di ogni sostanza, è un prodotto automatico della macchina sociale: nessuno può sperare di sfuggirvi definitivamente senza che sia stata prima distrutta la macchina, definitivamente.
35.
Illudersi di superare la miseria claustrofobica della coppia aprendo l’« in sé » della coppia come un barattolo, e aprendolo dal basso, significa accontentarsi dello sgorgare melanconico di qualche liquido seminale, per svenderlo al primo acquirente come l’elisir della gioia socializzata. Non c’è coppia che possa resistere alla clausura del suo « in sé ». O vi muoiono entrambi i componenti, divenuti oggetti del vincolo che li contrae alla necrosi, o vi impazzisce almeno il meno morto, dando mano allo strumentario del sacrificio fallico, più o meno metaforicamente. A ragione Cooper afferma che prima di amare un altro, ciascuno deve riuscire ad amare se stesso. Ma, dell’impresa di amare, fa un torto, quando, da questa banalità di base, estrapola un’apologia della separazione che ne liquida in limine ogni senso di superamento dialettico.
36.
« Tutto ciò che dobbiamo fare è sperimentare quanto più completamente possibile un amore estatico in una completa separazione. » (Cooper, op. cit., p. 118). « Nel secondo capitolo di questo libro ho definito l’amore come basato su un’azione corretta tesa a stabilire una separazione. » (Ibid., p. 107). Il passo più rivelatore in questo senso, contenuto nel secondo capitolo è il seguente: « Il consueto stato di cose è che l’Io brancola vacillando nel mondo familiare che è sia dentro che fuori della sua mente, e poi entra incespicando nel mondo che è al di fuori della sua famiglia. Trova che questo mondo cerca di essere il più possibile simile al mondo familiare che ha precedentemente conosciuto, proprio come il mondo familiare cercava di uniformarsi il più possibile al mondo esterno. Sembra che non ci sia alcuna differenza degna di nota tra i due, a meno che l’Io, l’individuo, non sia capace di inventare questa differenza. Se l’individuo si rende conto di questo, che in realtà l’essenza dell’essere una persona noiosa consiste nel non aver oltrepassato con l’immaginazione per lo meno, i limiti orizzontali della propria famiglia, e nel ripetere o colludere con ripetizioni di questo sistema restrittivo al di fuori della famiglia; che, in breve, essere una persona noiosa significa essere membro di una famiglia, trovare la preminenza della ‘loro’ esistenza nel riflesso dello specchio anziché in ciò che vi si riflette; allora l’individuo può ritornare dove era partito e cercare di incontrare se stesso, corteggiare se stesso, e sposare se stesso. [Segue schema topografico.] Naturalmente quando l’individuo ritorna al suo Io la sua visione è distorta da una serie di rifrazioni attraverso gli altri prima al di fuori e poi all’interno della famiglia, e, sempre attraverso gli altri, all’interno come all’esterno della sua mente (sempre accompagnata dalla percezione di una differenza se non da una determinante consapevolezza). Infine, tuttavia, quando questo progetto è stato portato a termine, l’Io incontra se stesso in un deserto mondo interiore - tutti gli altri sono avvizziti per le irradiazioni del suo spirito, ed egli vaga da solo nel deserto, trovando sostentamento nella pietra che succhia e nella cenere che assorbono i pori della sua pelle. Poi, se vorrà un’oasi, ne costruirà una tra le collinette della sua sabbia con le lacrime che versa. Allora potrà invitare un’altra persona a raggiungerlo per trovare in lei sostegno e per fornirglielo. Ma rimarrà sempre nel deserto perché questa è la sua libertà. Se un giorno non avrà più bisogno della sua libertà, allora anche questa sarà la sua libertà. Ma in ogni caso il deserto rimane ». (Ibid., pp. 41 – 42).
37.
La superficialità tutta mondana di Cooper – in confronto al quale la feroce ideologia del profondo di Lacan appare come l’alta statura di una maîtrise monumentale - si tradisce nella frivolezza dei termini di cui fa uso: « Se l’individuo si rende conto di questo, che in realtà l’essenza dell’essere una persona noiosa… »; (corsivo mio); « in breve, essere una persona noiosa significa essere membro di una famiglia, trovare la preminenza della ‘loro’ esistenza nel riflesso dello specchio anziché in ciò che vi si riflette (corsivo di Cooper); allora l’individuo può ritornare dove era partito e cercare di incontrare se stesso, corteggiare se stesso, e sposare se stesso. » Lo specchio, in simile contesto, non è quello tragico e lampeggiante di Lacan. E’ proprio lo specchio del salotto-comune, dove un Io così privo di immaginazione da sentirsi « individuo » (essere indiviso) può cogliersi in tutto e per tutto come « persona noiosa », e in questa lussazione della presenza pensare che la colpa sia tutta di papà e mamma, interiorizzati al punto che lo specchio li rimanda in primo piano, anziché riflettere la desolazione, assai più tragica, del salotto-comune in cui lo psicodramma ha il suo luogo
« naturale ». Non può meravigliare che quest’Io, ritornato donde era partito a cercare di incontrare se stesso, non trovi che la consolazione di « corteggiare » se stesso e « sposare » se stesso. Né meraviglia il fatto che « quando questo progetto è stato portato a termine, l’IO incontra se stesso in un deserto interiore – tutti gli altri sono avvizziti per le irradiazioni del suo spirito [lo 'spirito' doveva pure tradirsi, onnipresente com'è in ogni psicagogia], ed egli vaga da solo nel deserto trovando sostentamento nella pietra che succhia e nella cenere che assorbono i pori della sua pelle. Poi, se vorrà un’oasi, ne costruirà una tra le collinette della sua sabbia con le lacrime che versa. Allora potrà invitare un’altra persona, ecc. ». Questo deserto da turismo del malessere, non poteva finire che con un « invito ». Tuttavia « l’Io rimarrà sempre nel suo deserto perché questa è la sua libertà. Se un giorno non avrà più bisogno della sua libertà, allora anche questo sarà la sua libertà. Ma in ogni caso il deserto rimane ». E’ tempo che ciascuno si assuma le responsabilità del « materialismo» delle metafore e delle immagini di cui fa uso. Al linguaggio è dovuto questo riconoscimento di verosimiglianza concreta, oltreché un doveroso scavo nelle sue stratificazioni archeologiche. Dietro il deserto « turistico », c’è la spiaggia infantile, ma dietro e «sopra» entrambe c’è la più seria e consapevole reviviscenza dell’anacoresi, dell’ascetismo religioso. Il film neo-cristiano si scenneggia secondo queste sequenze: ai tremori dell‘Io, della persona « noiosa » (dove l’attenzione è puntata sul fatto che risulta annoiante, piuttosto che al fatto di come e perché si annoi), dell’individuo, significativamente indicati come sinonimi (nel «nome del padre», tutti i figli sono alter ego), fa, nello specchio, da sfondo l’incombente coppia parentale dei fornicatori castratori, in una prospettiva che conduce, attraverso l’uscio schiuso della casa paterna, a scorci di un paesaggio di stato disposti a svelarsi come la collusiva e ripetitiva dilatazione di quell’interno familiare. Che fare? Imboccare incespicando quell’uscio, beninteso attraversando lo specchio. Verificato che tra « esterno » (in senso filmico) e « interno » non vi sono differenze degne di nota – « a meno che l’Io, l’individuo, non sia in grado di inventarne qualcuna » – l’Io-individuo-persona-noiosa torna a casa a cercarsi, si trova, si corteggia, e si sposa con se stesso. Avvengono naturalmente distorsioni visive e rifrazioni attraverso gli altri, secondo il canone psichedelico. A questo punto, il protagonista si trova nel deserto – gli altri sono avvizziti, per quei fiori che erano, irradiati dallo spirito, evidentemente santo, dell’eroe – e di fatto l’Io é l’anacoreta che sopravvive prodigiosamente in modo fachiresco. E’ in grado, se vuole, di costruirsi un’oasi fra le collinette della sua sabbia con le proprie lacrime. E’ in facoltà di invitare un’altra persona a raggiungerlo per trovare in lei sostegno, e per fornirglielo. Ma il deserto è irreversibilmente la sua libertà. A meno che non senta di non averne bisogno, il che costituirà una libertà di secondo grado. Comunque, il deserto rimane il luogo sacro all’avvento. E’ tutto.
38.
« Al di là della distruzione futura, che ricadrà pesantemente sull’essere quale io sono oggi, che ancora si aspetta di essere, il cui senso anzi, piuttosto che quello di essere, è quello di attendere di essere (quasi che non fossi la presenza che sono, ma l’avvenire del quale sono in attesa e che tuttavia non sono), la morte annuncerà il mio ritorno alla purulenza della vita. Così posso presentire (e vivere nell’attesa) quella purulenza moltiplicata che, per anticipazione, celebra in me il trionfo della nausea. » (Bataille, op. cit., p. 65). Assolutamente geniale, questa proposizione erompe inattesa dalle pagine in cui Bataille rimastica il bolo indigeribile dell’equivalenza tra interdizione alla violenza e interdizione all’erotismo. E’ qui che pronuncia il suo proprio oracolo, qui trae somme che non sono d’evasione fiscale. L’essere che ancora si aspetta di essere, il cui senso anzi, piuttosto che quello di essere, è quello di attendere di essere (quasi che non fossi la presenza che sono, ma l’avvenire del quale sono in attesa, e che tuttavia non sono): costui è l’Io fallimentare che vive di credito, erogando la propria presenza devalorizzata al riscatto di una riscossione sempre fuggente – come non vedere, in sintesi, nel flash mirabile, l’autoritratto del cristiano e l’identikit del capitale fittizio? – finché « la morte, annunciando il mio ritorno alla purulenza della vita », rende così possibile « presentire (e vivere nell’attesa) quella purulenza moltiplicata che, per anticipazione, celebra in me il trionfo della nausea. » Ecco che cosa, orripilato, seppellisci. La vita pullulante dei vermi, dalla dissoluzione del tuo corpo, ti appare melanconicamente come l’irrisione oscena a tanto perdurare in aspettativa, cumulando meriti valorizzati dai dubbi. (Cfr. passo successivo, Ibid., p. 65).
39.
Eccola, la vita, brulicare quando l’Io è dileguato. Miserere nobis. In hoc signo. Sic transit. Il disordine ferino, o il brulicare purulento: contro questo, l’«ordine», la regola. Per non vedere, in quel transire di animali in vita, la coerenza impietosa ma rigorosa del bios, il limine da superare traversando, vincendo angustia e orrore, l’ordine insufficiente all’agognata signoria di sé, cui opporre, in un lungo corso di messe a prova, sanguinose e temerarie architetture di disordine, verso la sortita al sommo, nell’ordine superiore della coerenza totale conquistata. Ma la ratio, la produzione, il valore, l’accumulazione, la signoria edificata sulla povertà, le miserabilia: questo è il disordine. Il dominio del morto sul vivo. La prigionia del desiderio, la schiavitù del bisogno stravolto, l’orribile storpiatura degli infanti, la legge della rapina, del sacrificio, dell’assassinio, la guerra, l’orrore dell’umiliazione e della menzogna: questo destino generalizzato di violento disordine, di violazioni alla coerenza organica, questa fabrica contro natura di biopatie.
« Troppo spesso dimentichiamo gli sforzi che abbiamo dovuto compiere per imporre ai nostri figli le avversioni che ci hanno costituito quali uomini » (1) . « I nostri figli non partecipano nelle nostre reazioni da soli, spontaneamente. Possono provare avversione per un alimento, e lo rifiuteranno: ma dobbiamo insegnare loro, mediante una precisa mimica, e se occorre mediante la violenza, quella strana aberrazione che è il disgusto, aberrazione che ci tocca al punto di esserne sconvolti e il cui contagio ci è stato trasmesso dai primi uomini, attraverso innumerevoli generazioni di bambini sgridati. » (Ibid., p. 66). L’oscenità degli organi genitali. « Inter faeces et urinam nascimur. » Di tutti questi sacri e imposti disgusti, ne sanno qualcosa le meretrici.
41.
Come piangono, gli « uomini », nel gorgoglio del piscio chiamando la mamma. Come si allattano all’orifizio. Ma ormai, è cosa pubblica: i produttori del vizio surgelato in rappresentazioni (che più sacre di così mai ne ha vedute il mondo) hanno saccheggiato tutti i Kraft-Ebing, gli archivi di polizia criminale, i confessionali, gli schedari degli psichiatri; ed eccole, le « vergogne », fotografate a colori, patinate, ecco in controluce il rivolo quasi georgico di piscio, fin nel bacile di plastica, eccola la nascita prodigiosa dello stronzo, nel caramello della ceramica e del nylon. Dov’è più la nausea? Cosa ne vanno facendo del mistero, del divieto, che messa celebrano questi pii maîtres? Run, run show! Al cinema accanto, teste volano in un bengala di sangue, mani di principesse strappano, in un sol gesto gratiae plaenum, stomaci, fegati, quindi si leccano le dita con lingue rosee, di gattine. Le stesse, sui glandi. I rivoli di sangue e sperma convergono. Proiettate, proiettate, qualcosa ne rimarrà. Persuasi di giocare con la sacra merda (feci-oro), giocano col fuoco. Che cosa vanno imparando i figli di questi fedeli della nuova messa spettacolare? Dove troveranno la forza del disgusto? In nessun luogo: è finita, sta finendo, la regola del divieto. E’ cominciata, sta cominciando, la coerenza del voler vedere. Il sesso è il sesso, la morte la morte. Il processo, doppiato un limine, avanza a ritroso. Dalla rappresentazione verso la nuova verità. Nel tempo enormemente dilatato del pornoshow ciascuno scopre di assistere alla tortura di tutta la propria
« vita », inchiodato alla sedia della sua perpetua astanza finalmente rivelata.
42.
La scoperta della dissacrazione introduce lentamente ai contenuti celati dietro le figure fittizie della sacralità. Nel momento storico in cui tutto trapassa nel mercato, l’anticipazione del vero che ivi sta caricandosi la trovi sul banco del mercato. Il capitale, divelta ogni ambiguità, gioca di planimetrie, stampa ogni sorte in piano. Sbudella, spreme fuori, spiaccica, pressa. Ogni « vita » è un imbuto che scodella il terrorizzato « figlio » in quel deserto, in quella piattitudine. Ma pur sotto i colpi quotidiani del maglio, pur nella pressione rotativa della continuità, i corpi ritrovano spessore. Solo le cose restano quello che erano: simulacri di falsa dimensionalità. Squartata, spiaccicata, dissezionata, esibita, la miseria di essere solo così si impara. Niente è più efficace della contiguità manifesta. Niente fa scattare più rapidi nessi e sintesi delle analogie disvelate. Crollano a perdifiato quinte, scenari; si eviscerano i sogni e le memorie più segrete; e doppi fondi, scantinati, passaggi segreti, cantine, soffitte, cessi, sgabuzzini, sottoscala, cellette, cabine, biscanti, vialetti, androni, angoli di giardini, forre, cespugli, dune, tutto è come da una potenza centripeta risucchiato sul posto, violentemente convocato, strappato alla memoria, dissacrato, disvelato, estirpato dall’unicità, dall’angosciosa prelibatezza garantita dall’unicità, e qui pubblicato, rovinosamente, impudentemente. E’ fatta violenza indicibile al più violento dei «sentimenti»: la vergogna di sé. Non dico sia questo il migliore dei modi di procedere, dico che è il modo storico, concreto, materiale, con cui la logica del profitto attinge alla banalità terribile della prigionia e del dolore, e dico fermamente che non poteva esimersene, e che ne pagherà le conseguenze.
43.
Il dissequestro della sessualità operato dal capitale non poteva non avere questo aspetto di stupro glaciale. Non poteva che rivelarsi devastante e ammorbante. Ma perché tale era la materia. La fedeltà obiettivante è indiscutibile. E’ proprio questa fedeltà, che agghiaccia e violenta. E’ questo
« no, no » di disconoscimento, questo assistere irrigiditi come condannati ad ascoltare la diagnosi, che dimostra l’onestà paradossale dell’operazione. « E’ altrimenti, è di più, è di meno »: non è mai vero. E’ così. La materia: è questa. Ed è bene che si veda, in tutta la sua « miseria » e « ricchezza » insieme, stampate in piano. Certo che c’era di più. Anche nel culto dei morti c’è di più che la morte. Ma è tempo che finalmente si sappia: la prigionia è fra quelle figure del lutto e dell’angosciosa deprivazione. Quanto manca, è venuta l’ora di conquistarlo altrimenti che nel cullarsi nel culto vergognoso del sogno proibito.
43 bis.
Guardino, i radicali, tutto il campionario. Vi riconoscano la propria debolezza e i punti di partenza dei propri desideri. Ve li troveranno, l’una e gli altri. Ma guardino senza tremare. Niente sogghigni, niente tentazioni di classificazione. Al di là dell’ira, della vergogna, del disprezzo; dell’estetica, del « buon gusto », della mistificazione. La collera è un’altra da quella che fa stornare lo sguardo. La collera scenda a far luce negli scantinati. Si trovi, la collera, si riconosca. Riporti su il bambino che frigna. Su, alla faccia, su, agli occhi. Su a vendicarsi e vendicare. Su, a dire il vero, finalmente.
44.
Seme e sangue confluiscono. Il morto attizza la nostra colpa e incarna eloquentemente il nostro credito; il vivo-morto sequestra nella torre-teatro dell’IO la chiave dell’estasi. Sentiamo tutti di avviarci verso una resa dei conti orgiastica, verso uno spasmo dei destini che è esecuzione e liberazione. Il morto che fu dio, perché il vivo s’impietrisse, nell’attesa di un proprio avvento, finché morte non ne svelasse la scaduta illusione. Ma il morto di oggi, dissacrata ogni traccia del procedere, al terminal nihilista del progressismo, disvelata ogni orma d’onore dai Verbi spesi, il morto di giornata, la salma quotidiana gravida di tutti i sensi morti, chi è, se non la « machina », l’ordigno in noi interiorizzato, che si ricarica di noi, il capitale giunto alla sua putredine? E che può fare ormai, se non ostentarsi, potente solo della sua sterminata oscenità e barbarie, della sua incredibile (e perciò non creduta e non vista, non ancora intiera) banalità spalancata, immane vuoto a perdere, a fronte di millenni di dolori. Spalancarsi, indicarsi come il gorgo, il vuoto, la fine. Rivelarsi. Prodursi come sbigottimento, e inanità. Come il trionfo dell’impotenza maniacata. Di questo sono vuoti anche gli occhi degli angeli, i militari disarmati del « Beautiful People »..
39.
La distruzione realizzata dal capitale è irreparabile. Niente di ciò che esso ha devastato né può né deve essere restaurato. Tutto si troverà, cercandosi. Ma perché possa farlo, occorre che il senso di tutto il cammino preistorico si ricapitoli nella cognizione della manque. Ciò che ci manca, indica la via. Le mutilazioni sono i segni. Nessuna pacificazione col presente è possibile. Coloro che osano amarsi, scoprono il labirinto in cui si addentrano. Tutto ciò che un momento di vero conquista, un momento di incertezza revoca, un momento di viltà capovolge. « Prendersi » è una sfida continua alla perdita: di sé nella pietra desertica dell’altro, dell’altro nel gorgo paludoso di sé. L’amplesso, è un duello tra pieno e vuoto, e non certo nel senso codardo della virilità fallica e della femminilità avviluppante. Ben altra la dialettica!
46.
« La falsa coscienza… emblematica di quel segreto patto suicida stretto dal nucleo familiare borghese, quel nucleo che si autodefinisce ‘famiglia felice’. » (Cooper, op. cit., p. 9): Già non più. Da quando l’autocritica è il bisturi castratore del terrorismo terapeutico, l’autodefinizione è, senza equivoci apparenti, di « famiglia infelice », affinché con l’infelicità gli ergastolani, identificando la propria genesi con quella delle loro catene, sempre più si familiarizzino. La via dell’ospedalizzazione generalizzata procede da questo capolinea: la costellazione della genesi diventa sigla, e sintesi liquidatoria, del periplo infernale. A morte quei dubbi astronauti dell’estasi dai cui orgasmi, se mai ci furono, precipitò l’extraterrestre nella culla di Procuste. La luna era di fiele. Purché si inumi più profondamente nell’oblio colui che era pur nato. Il vivo, finalmente, prende il luogo del Morto, del Sacrificato, da quando siamo tutti popolo di crocefissi. Il dubbio ortogonale alla disperazione: questa la croce.
47.
« Che la morte sia anche la giovinezza del mondo, ecco un’affermazione che l’umanità è concorde nel respingere. A occhi bendati, ci rifiutiamo di vedere che soltanto la morte assicura senza posa un rinnovamento, in mancanza del quale la vita declinerebbe. » (Bataille, op. cit., p. 67.) Ed è il contrario che si è avverato. E’ l’aver visto la morte sopra tutto, la morte come fine, è questo che ha vibrato gli uomini, in un movimento non di ripulsa e di fuga, ma di aggressione armata, di volontà di superamento. Insinuando nei quali, certamente, l’orrore, il contrappeso dialettico, il «prezzo». Ma orrore essenzialmente del limite, indicato senza posa dalla prigionia d’ogni animale nella sua identità di dipendenza; dipendenza dall’habitat, dalla sua « natura » e struttura, dagli stereotipi istintuali, dalla cecità dei somatismi. Questo era, ed è, avere la morte come destino. Questa economia stretta, avara, che avviliva la pienezza del senso istante, questa prigionia nella termodinamica della sussistenza, degli estri riproduttivi, dell’orizzonte metabolico. Questa pochezza della vita, questa imperfezione del bios. Questo essere nel processo, ma cieco alla totalità del processo. Questo sotto-essere, sussistere in un sotto-insieme. Questa coerenza miniata al sussistere, ignara della generalità delle coerenze. Questa istintualità accecata ai propri limiti. Le mutazioni della vita, sintesi eloquenti della dialettica reale in atto tra invarianza e teleonomia, marcano una differenza qualitativa che assegna alla morte il ruolo di zero (anche in senso aritmetico: di moltiplicatore e di riduttore). Il livello di organizzazione è il segno del senso vivo. La complessità: la ricchezza. Anche (e soprattutto) materialmente: habitat (Umwelt) più vasto, attività più articolata, con-prensione. Come confondere il senso di vita complesso di un primate vivo, col senso di vita elementare espresso dai vermi che brulicano nel suo cadavere? Come non vedere lo scarto qualitativo, non coglierne il significato?
48.
Et tout se tient. Chi vede l’origine come soggezione atterrita alla morte, non può vedere che
la morte dietro ogni fine: non può essere che religioso. Ogni religione colloca le chances dell’essente al di là della morte. E’ così che l’essere coincide con la fine; il fine, con il cessare di esistere. Avere la fine come fine. In un sistema chiuso che suggella al di qua della morte il sussistere come un periplo vacuo, un automatismo che ignora il suo fine; dacci oggi la nostra preghiera quotidiana affinché il lavoro appaia meno insensato, si faccia accettare come un accento dell’insensatezza, un attributo della pena del sussistere, un « dovere » che persino ne riscatta e solleva, accumulando meriti-crediti, per la festa dei morti, di là da venire.
49.
La religione occulta l’incedere del processo, nella materialità; si accanisce a stornare l’evidenza dialettica. Chiudendosi come una pietra sepolcrale su ogni presente schiaccia nella tenebra del non-senso ogni istante che proceda verso l’essenza. L’essenza è interdetta al sussistere. E’ questo il divieto religioso. Tutto deve venire nel pretesco al di là. Il modo più efficace di combattere la trascendenza materiata del processo: in nome della « trascendenza », dell’immaterialità. Accecare all’evidenza, puntando tutto sulla lentezza efferata dell’evidenza, sull’arco doloroso dell’iter – nascita vita e morte – per riconoscere, in un flash troppo spesso flebile, il senso dell’inganno subito e, nel medesimo istante, l’incedere certo del disvelamento, il passo della storia contro la menzogna. Di questo spreco che è la vita incatenata al lavoro, comporre il feticismo dello spreco.
50.
« Se si considera la vita umana nel suo complesso, si constaterà come questa aspiri fino all’angoscia allo spreco; fino all’ angoscia, fino al limite in cui l’angoscia non è più tollerabile.(…)Poiché al culmine della convulsione che ci forma, la testardaggine dell’ingenuità la quale continua a sperare che quella cessi, non può non aggravare l’angoscia, per cui la vita tutta intiera, condannata com’è al movimento inutile, aggiunge alla fatalità il lusso d’un goduto supplizio. Poiché se per l’uomo è inevitabile essere un lusso, uno spreco, che dire di quel lusso che è l’angoscia? » (Ibid., p. 68-69). La flessuosità « dialettica » di un passo come questo, e la sua «beltà», non potrebbero stornare più efficacemente la dialettica reale della vita come esperienza angosciosa della manque, e come lotta non inane contro la stasi. Ecco che pur di azzerare il senso del processo e del movimento, storicamente evidente nell’iter della specie e nel superarsi, opponendosi dislocate rispetto allo specchio dell’inessenza, delle generazioni che si succedono (sempre significativamente diverse nel dolore), ecco l’angoscia scivolar fuori dall’alveo della manque in cui pulsa, anticorpo in lotta contro l’intossicazione della stasi, venire a collocarsi sull’«accadere», con la connotazione adornativa del «lusso». Che dire di questo detournement «lussuoso» del movimento che è l’angoscia?
51.
« La vita tutta intiera, condannata com’è al movimento inutile, aggiunge alla fatalità il lusso d’un goduto supplizio. » Chi può godere di questo lussuoso supplizio, se non colui, falso uomo, che sa di aver patria altrove da questa « valle di lacrime »? Chi deliba il calice fino alla feccia? Chi trionfa inastato cadavere, nel livore del supplizio? Chi se non il « rospo crocefisso », il corpo di morte, il cadavre exquis? Questo non-uomo. Il figlio di dio che viene, a dissacrare la pena, la storica e non inane pena umana di resistere, di desiderare, di sussistere angosciosamente, di conoscersi imperfetti e mutilati nella mancanza, e di lottare e da capo lottare, perché al di là di sé, e non al di là della vita, la mancanza maturi la pienezza, la vita erompa dalla sopravvivenza, il sogno concreto si realizzi, contro la concretezza sempre più fragile dell’incubo reificato. « Al culmine della convulsione che ci forma, la testardaggine dell’ingenuità la quale continua a sperare che quella cessi, non può non aggravare l’angoscia… » La testardaggine dell’ingenuità. A questo, pur di fugare il senso della storia, e delle « storie », il verminoso « pensiero » religioso riduce l’esperienza combattuta, la sapienza della lotta, la sola vera e sanguinosa conoscenza. Del non mai inutile movimento che è l’angoscia, dentro la stasi della non-vita. L’albero della conoscenza, il serpente. Questa la trasgressione: conoscersi, disconoscendo la fatalità.
52.
La fatalità è la stasi. La « personalità » vissuta come il giudizio inappellabile, la condanna all’ergastolo. Per sempre entro i muri eretti dall’alterità. La definizione in negativo, per esclusione. La costellazione delle presenze, in cui ti conosci come assenza, come involucro del vuoto. L’IO dettato in nome del padre, sentenza e croce: il dubbio ortogonale alla disperazione. Il nome e cognome. La fisionomia impietrita nello specchio. Il viso che tasti tremando, nell’angoscia. L’angoscia-madre, l’angoscia-travaglio, il premere contro le pareti per nascere: per nascere, finalmente. Lungo tutta la « vita ». Il movimento spastico, il movimento-cuore. Nel silenzio, nauseato e atterrito dalle parole. La parola dis-conoscente. I nomi che negano. La neutralità omicida delle frasi, gli sguardi che negano il vedersi. Gli occhi che ti inchiodano a ciò che non sei. La figura di te: l’altro. Riconosciuto senza fine - ogni « tu », ogni « ciao » – mentre si disconosce e rivolta, senza fine. Gli occhi del padre, della madre, gli occhi dei fratelli, gli occhi dei figli. L’oggettificazione. « Che cos’hai? Parla! » La prigionia, la negazione ineffabile nel linguaggio. E la prigionia, la negazione eloquente nel silenzio. Di cui ciascuno è l’auscultazione raccapricciata. L’intelligenza sbarrata dalle parole. Dalle parole tradite, monetizzate, depauperate. Fatte cadere. Schiacciate. Le parole-schegge. Le sfere frantumate. Il bagliore sbriciolato. « Come stai? » « Che cos’hai? » « Spiegati. » « Non capisco. » « Perché mi guardi così? » Tra intendere tutto, a un millimetro, a un istante, e non voler capire, in un sempre che è la stasi, che è la fatalità. Ma rotta, divelta, a spasmi, in ciascuno, in un segreto che è di tutti, velato appena dall’interdizione, sempre più trasparente, sempre più imminente, nel movimento-angoscia, nel desiderio-angoscia, nel patire che matura il sommovimento, nell’intendere che si avvicina, che si vuole. Altro che lusso. Altro che spreco. L’angoscia è l’incedere gigantesco della storia, miniato nella peripezia di ciascuno. La bancarotta imminente del credito, dell’attesa. La crescita del desiderio che esige, la lotta dell’istante che rifiuta di sacrificarsi. L’erezione appassionata del presente. L’insurrezione silenziosa ma sterminata dei corpi. Tanto più forte, quanto più clandestina. Tanto più certa, quanto più occultata dalle forme dirotte della derelizione. A mano a mano che il niente sembra trionfare. Più l’insurrezione si fa potente, più incombe la desolazione. Il nihilismo è la fragilità trasparente del fittizio. La traslucidità dello schermo vicino a spezzarsi. Il disgregarsi dello specchio, in cui il passato dilegua, col suo potere. L’assottigliarsi dei muri. L’indebolirsi e il disperarsi della fatalità, scudiscio ormai snervato d’ogni tirannia. L’impallidire dello sbirro: l’agonia dell’angelo custode. La timidezza, anche, della potenza che si scopre, incredula, dello spazio che cede, della catena che si allenta. Il vizio duro a cedere dell’umiliazione. L’oscenità dell’assuefazione. La coazione a ripetersi il divieto.
53.
L’angoscia è il memento vivere della corporeità. La testardaggine della intelligenza naturale: il diniego a concludersi in quella costellazione di apparenze oggettive. La consapevolezza
insepolta di un destino superiore. La denegazione dialettica della fatalità negatrice del movimento. Il movimento estatico, uscita dal sé fittizio, uccisione del custode-Io, è il contrario della fuga dal corpo. E’ la conquista in atto della corporeità realizzata, e della totalità coerente come suo contesto naturale. Quando la corporeità riconosce il potere trascendente del proprio senso in processo - materialmente trascendente – è allora che nell’azzardare (nelle carezze in cui dilegua il vetro della separazione, negli sguardi disaccecati, negli atti temerari della passione) la pienezza attraversa i confini del soma, trabocca irrompendo nel mondo, colma col proprio pulsare ogni spazio e tempo, conquistandoli a sé, realizzandoli come i suoi. E’ così che il corpo dell’essere amato si rivela come un territorio, un paese, un’era. Schiude la ricchezza, antichissima e futura, della sua vastità; si smisura, abbandona la segregazione rattristata dei « connotati », dei contorni umiliati della propria figura, aggricciata nel respiro breve dell’angoscia, impedita a espandersi dalla corazza della sua
« identità », che è identità necrotica con la comunità familiare dei carcerieri e con il loro tempo, scandito dalla ciclotimia produttrice dell’impossibile.
54.
In limine all’estasi, è l’incredulità. L’impossibile esercita una resistenza feroce. Trafigge, schidiona ogni impulso, lo trae alla cucina del sarcasmo, dove ogni carnalità trapassa in macelleria, ogni sangue in salsa, ogni linfa in untuosità di brodi. Ogni uccisione sacrificale è sempre finita in una digestione. Fuori dal corpo il fuoco, a rosolare il morto. Questo il tuo corpo. Il vassoio delle delizie estirpate. Non viverle, consumale. Lenisciti, al di qua dell’azzardo. Rimpicciolisciti, nel desiderio ridotto ad appetito. Cibati, digerisci, defeca: sii nel ciclo, nella quotidianità e nella liturgia.
55.
Al cuoco di visceri, il desiderio sa avventarsi, riconoscere il suo possibile sul varco, scorgere, nel corpo-a-corpo, in un colpo d’occhio, la grandiosità della sortita. E’ già al di là. Non appena osa vederlo, lo spazio-tempo dell’estasi è già il suo presente. Ogni gesto apre, dissuggella, sprigiona, riconosce, libera, comincia. Per breve, per minacciato che sia dai più imperativi divieti e dalle labilità e impotenze, riconosciamo il senso insurrezionale dell’estasi. Disimpariamo a misconoscere i sensi. Crediamo, infine, ai nostri occhi, quando l’impossibilità osa negarsi.
56.
La magia entusiasmante del potere dell’estasi, che è potere e magia di sintesi, di risoluzione. L’irrompere spiegandosi e sciogliendosi di ogni passato-nodo, il disparire del tempo della prigionia. Dileguarsi della quotidianità. Esplodere del sé-oggetto. Fuggire della cosalità. La presenza lampante della corporeità superantesi, scatenata verso il di più e l’oltre, sfuggita alla morsa dell’alterità, nella potenza del desiderio. L’evidenza irrevocabile del trascendersi dell’«animale» e della «persona». La pienezza che attraversa il chiuso della pelle, l’attraversa come si entra in una luce, in un’acqua, in un bosco, incedendo senza resistenza, solennemente, fondendosi. Questo conoscere aprendolo l’essere suggellato. Questo senso vivo del corpo d’amore, chiaro a tutti i sensi, sontuoso. Questo superamento attraversante e inverante, questa abolizione solenne della separazione, dell’alterità, dell’angustia, della prigionia. Questa identità rivelantesi dell’« interiorità » con l’« esteriorità »: il loro perdere senso, il perdere senso dell’«identità» carcerata nell’Io, stampata nel vuoto del sé dalle forme ossessive delle assenze, dalle « persone », dagli « altri », l’identità-intimità con l’uccisione, con il divieto ad essere e a sentire. Questa dimostrazione « per assurdo » della possibilità d’essere. Questa conquista armata del presente, affinché in essa la volontà potente si risponda esaudendosi, sgominando l’assise del passato, decapitando giudici e sgherri, rovesciando re e regine, strangolando sacerdoti, spie e metafisici. Questo far giustizia in sè della famiglia regale, e questo disparire del palazzo, delle sue aule e stanze, dei suoi usci del pianto, dei suoi mormorii e orecchiamenti di gemiti, delle sue camere di tortura, dei suoi corridoi labirintici, delle sue cantine, dei suoi topi dei suoi insetti dei suoi pipistrelli dei suoi vermi dei suoi draghi. Questo profondo respiro dell’altrove, in cui il soggetto si rivela a sé. Questa guarigione senza terapia, questo lenire resuscitando, questa morte della pietà e del pianto. Questa vittoria.
57.
Troppo breve. Troppo assediata. La vendetta del tempo, della quotidianità desertica, contro l’istante. L’ironia, e peggio, il suo contagio: l’autoironia. Il contagio dell’incredulità. L’astio, pronto a infiltrarsi, nel rivolo del risentimento. « Ma è stato vero? » « Ma anche tu? » « Ma come me? » Proprio perché l’estasi può essere quella vittoria, quando il procedervi cade prima di toccarla, quando viene meno al suo progetto e alla sua premessa, il dubbio inquina la presenza vicendevole degli amanti, ne indebolisce il potere, fa sì che riappaia come feritoia nella prigione. Spasmi di dubbio: il cui veleno si annida nella labilità con cui si profilano, nell’apparire-disparire, sfuggendo l’affrontamento, conservando l’immunità del perdurare irrisolti. Scarti spastici di prospettiva. Il corpo che si avviava ad espandersi, a farsi mondo, come in una zumata si raggrinzisce. Il sentire-capire sanguigno, il confluire dei sensi col senso, regredisce a « pensiero », a incertezza. Il respiro è riconquistato dal progresso dell’ansia. Si cessa di trans-crescere, di procedere, con la pelle (premendola nella forza dall’interno, attraversandola-affermandola) al di là del suo delimitarsi. Ci si distacca, col venir meno della propria presenza corporea. Si giace nel proprio-corpo. Dovunque non qui, comunque purché non in presenza. L’altro è già l’Altro. La presenza è del boia alieno che giace castrando, raggrinzendosi, non sai se in te, nell’altro, che si equivalgono, immiserendosi, carcerati nell’identità del non-essere, definiti nell’alienità.
58.
La caduta può essere peggiore della perfidia dei custodi. Quando il corpo, perduta la « grazia » dell’incedere, nel fuoco interno, verso l’uscita dal sé, sconfitta la gloria dell’insurrezione, smarrisce l’onore del vero fino a convertirsi, al di là del brivido, nel proprio simulacro, e precipita nella vergogna di mimare l’avventura, sopprimendo financo l’avvertimento sinistro dell’assenza di piacere: allora a muoversi, a galoppare, è la macchina, il fallo-coltello, la vagina-tagliola, alacri a contundersi, a negarsi ferendosi, mentre le mente, specchio della mancanza, evoca dalla castrazione infantile le icone gessose delle più remote ossessioni onanistiche, nella luce chirurgica dell’assassinio primario. L’irrisione è pronta a svuotare i corpi come circhi evacuati. Gli atleti-attori, i gladiatori clowns, cui senza mistero e senza magia sono ridotti gli esseri che mossero verso le clarine dell’estasi, trovano, nell’eiaculazione « liberatoria », il fischio dell’arbitro che pone fine alla partita. E nella delusione risentita, scoprono d’essere stati essi stessi gli spettatori disincantati, i barbari masticatori di farse. L’Io riconquista così, non appena gli si conceda uno spiraglio di dubbio, lo spazio-tempo dell’estasi, immediatamente convertendolo in scena, e immediatamente rappresentandosi nei corpi, che cessano di muoversi realmente. Pulcinella, rimanga un segreto.
59.
E’ di questa competenza dell’oscenità, che la « cerchia », la riproduzione mondana del lager familiare, intesse la sua intimità. Ogni raro apparire della passione, suscita la folata dell’astio, a scuotere ogni spina nelle anime-pruni, a sollevare sabbie disseccate e a scagliarle, con tutta la violenza dell’odio per il «disordine» della passione, nell’intollerabile dolcezza di chi ha un mondo a fior d’occhi. Mai l’amore incede incolume, nella cerchia. La cerchia: che è l’accerchiamento, in cui ciascuno è a un tempo volpe e membro indistinto della canea. L’uso della parola oggettivante è il fissativo che connette gli amanti, fatti « coppia », nella comunità fittizia: famiglia, cerchia, racket, milieu. Essere nel gioco: preso, « dato », in pegno, in ostaggio. Il patto esplicito è di non
« trascendere »: non trascendersi come identità opaca, non smentire la connotazione. Pena la perdita d’ogni connotato. L’essere-o-non-essere nell’ambito della cerchia è sospeso a questa oscillazione: essere (dato e preso) nella connotazione oggettivante, o venire espulso dal circuito connotante, gettato in quello sfondo raccapricciante che è la « cosalità » del « fuori », l’oggettificazione dei vuoti a perdere; dei consumati o non più consumabili, dei deteriorati, dei rifiuti.
60.
Ciascuno, nella cerchia, è parlato. Detto. Descritto. In presenza o in assenza. Sempre in un sotteso terrore. L’economia politica, trapassata corpo ed anima in psicologia politica, produce la personalità come la Cosa che è Detta, la rappresentazione coniata del valore creditizio, la carta di credito che torna, a ogni giro-girone circolatorio del giorno-ciclo, accresciuta di un profitto d’assenza. Essere nella cerchia: sussistere nella figura di sé, erogarvisi co-edificandola, questo prodotto collettivo che è la personalità dell’assenza.
61.
II « lavoratore combinato » ha toccato le radici del patto sociale, si è identificato nella matrice del valore personificato; l’oggetto per eccellenza è il soggetto fittizio, la merce sublimata nel mero contenersi, in una forma, del vuoto. Un corpo, è un supporto. Un vuoto, la marca del sé. L’eloquio è il sound, la colonna sonora della produzione di vuoto. Con o senza chitarre, ogni chanson è la sigla che promuove l’assenza, che celebra l’onnipotenza del passato e del non-stato, indissolubilmente dall’apologia del credito futuro. L’essere così si pronuncia / produce esclusivamente nella commemorazione, che introduce senza soluzione di continuità, saltando a piè pari il presente, nella promessa. Tra commemorazione e promessa si tende lo schermo in cui le figure di sé vengono proiettate a celare il vuoto nel quale sgorga silenzioso, come da una tubatura che perda, il presente, cui è fatto divieto di avvertirsi. Si parla di ciò che non si è: per prodursi concatenati nel non-essere, nella liturgia del commentario.
62.
Mai la society fu così assorbita dal cerimoniale del « problema » e mai così democraticamente uniforme, in ogni sfera della sopravvivenza socialmente garantita. Mentre gradatamente tendono ad eclissarsi le distinzioni tra le classi, nuove generazioni « fioriscono » sul medesimo stelo della tristezza e dello stupore che si commentano, in una generalizzata e pubblicizzata eucarestia del «problema». E mentre il gauchismo più « duro » (e a suo modo più coerente) rivendica un salario per tutti, sempre più il capitale accarezza il sogno di saperlo accontentare: depurarsi dalla pollution produttiva fino al punto da consentire agli uomini semplicemente di prodursi come le sue forme piene di vuoto, come i suoi contenitori, dinamizzati dal loro stesso enigma: perché ci sono?
Agosto-dicembre 1973
1. Torna il passo di Lacan: “Giacché l’uva verde della parola con cui il bambino troppo presto riceve da un padre l’autentificazione del nulla dell’esistenza, e il grappolo della collera che risponde alle parole di falsa speranza con cui sua madre l’ha ingannato nutrendolo con il latte della sua disperazione, legano i suoi denti più che se fosse stato svezzato d’un godimento immaginario, od anche fosse stato privato di certe cure reali”. (J. Lacan, op. cit., Einaudi, pp. 217-18).