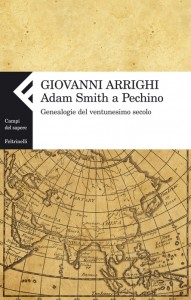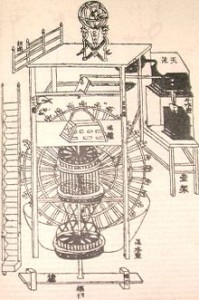Giovanni Arrighi, “Adam Smith a Pechino”
nov 4th, 2019 | Di Thomas Munzner | Categoria: Teoria e critica
ALESSANDRO VISALLI
Prima parte
L’ultimo libro di Giovanni Arrighi[1] conclude un lungo percorso nel quale il sociologo ed economista italiano passa dall’adesione al marxismo e vicinanza all’operaismo, alla svolta sistemica degli anni ottanta, quando insieme ad altri si sforza di generalizzare il punto di vista della ‘teoria della dipendenza’[2], che aveva contribuito a fissare nel decennio precedente insieme a Gunder Frank[3] e Samir Amin[4], ed al contempo di superarlo in una teoria molto più comprensiva dei “sistemi mondo”[5]. In questo sforzo Arrighi, lavorando sulla traccia di Braudel e in associazione a Immanuel Wallerstein[6], tenta di produrre delle generalizzazioni che pensa come feconde. Ovvero teorie e modelli in grado di gettare una luce nuova sul passato ed il presente, ed immaginare possibili futuri. La sua fama diventa larga dalla pubblicazione de “Il lungo XX Secolo”[7] nel 1994, e poi di “Caos e governo del mondo”[8], con Beverly Silver, nel 1999, ma le sue prime pubblicazioni sono sul sottosviluppo in Africa[9], quindi alcuni studi di diretta ispirazione marxista sull’imperialismo[10], alcuni studi sul mezzogiorno italiano[11], e relativi alla svolta[12].
Questo testo chiude il percorso e la trilogia di studi sui “sistemi-mondo”, a pochi mesi dalla morte dell’autore, e ne è sia un seguito sia una rielaborazione. Il tema chiave è il tentativo, compiuto dall’amministrazione Bush, di reagire alla minaccia di declino che si era presentata sin dalla crisi sistemica degli anni settanta con una forte proiezione imperiale in grado di aprire un nuovo “secolo americano”, essenzialmente tramite il controllo diretto, manu militari, delle regioni chiave per le economie industrializzate. Come si dice sinteticamente, “guerre per il petrolio”, ma in realtà “guerre per il mondo”. Il primo tema è dunque il lancio, prima, ed il fallimento, poi, di questo progetto di “dominio senza egemonia”.
Il secondo è l’affermazione, o meglio il ritorno, della Cina in posizione centrale nel mondo.
Questo tema, la rinascita economica dell’oriente asiatico, è l’effetto di una serie ininterrotta di “miracoli” economici: il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, la Thailandia, infine la Cina.
Ma l’oriente asiatico, in ombra nella prima parte del secolo scorso (anche se il Giappone già fa eccezione), non era sempre stato considerato una parte sottosviluppata del mondo. In effetti ancora Adam Smith, nel settecento, ne aveva un’immagine altamente positiva. In particolare della Cina come del centro sviluppato del mondo e del luogo di maggiore ricchezza, se pur connotato da una forte stabilità. Questa immagine degrada molto rapidamente durante l’ottocento, e alla fine della seconda guerra mondiale la Cina era arrivata ad essere ormai una delle nazioni più povere del mondo.
Una situazione che inizia a cambiare di nuovo quando negli anni sessanta in Vietnam gli Stati Uniti alla fine sono sconfitti e devono scendere a patti; è da allora che accelera e prende sempre più forza quello che alcuni hanno chiamato “l’arcipelago capitalista” nell’oriente asiatico.
Il libro di Arrighi, come lo stesso titolo mostra, utilizza una lettura non convenzionale del capolavoro di Adam Smith “La ricchezza delle nazioni”[13] per interpretare il particolare tipo di mercato impiantato con enorme successo in Cina come “non capitalista” e continuo alla lunga tradizione del paese. Smith, del resto, sperava che potesse impiantarsi una società di mercato globale basata su una maggiore equità e rispetto per le diverse aree mondiali di civiltà; una società non fondata sulla forma a suo dire “innaturale” di sviluppo che il mercantilismo della sua epoca stava impiantando. Secondo il modo di leggere il filosofo morale (la sua prima specializzazione[14]) scozzese che propone Arrighi questi non è stato affatto un teorico dello sviluppo capitalistico, o il suo difensore. Smith intendeva i mercati come strumento di controllo e di governo dell’avidità e ciò riveste importanza per comprendere le economie di mercato non capitaliste, come quella cinese prima che venissero incorporate in posizione subalterna nel sistema globalizzato di stati guidato dall’Europa.
Ma cosa è “un’economia di mercato socialista”, che si vorrebbe creare in Cina, e cosa, invece, la “economia di mercato elitaria” (secondo la denuncia di Liu Guoguang nel 2006) che si rischia di creare? Tra il “socialismo con elementi cinesi” dei discorsi ufficiali e la realtà di capitalismo selvaggio che si registra spesso c’è, per Arrighi, un vasto lavoro da fare, nelle lotte del popolo cinese e nella sistemazione delle idee. Questo secondo compito, ambizioso, è quello che si dà.
Adam Smith e la nuova era asiatica
Il libro prende le parti dunque di una sorta di “marxismo neosmithiano” che lavora entro la frattura, ben ricordata nelle prime pagine, tra il marxismo de “Il Capitale”, concentrato sullo sviluppo delle forze produttive nei centri più avanzati e che assegna ai relativi lavoratori il compito di guida in quanto testimoni della maggiore contraddizione, e quello delle periferie del mondo, concentrato sulla questione del potere e della lotta nazionale di liberazione.
Come scrive Arrighi: “Non ci sono dubbi sulla distanza che separa la teoria del sistema capitalistico di Marx dal marxismo di Castro, Amilcar Cabral, Ho Chi Min, o Mao Zedong, una distanza che si poteva superare solo con un atto di fede nell’unità storica del movimento marxista” (p.32). Un tema fondamentale, recentemente ripreso con grande energia da Domenico Losurdo[15].
Questa frattura, continua, Arrighi:
“fra marxisti essenzialmente interessati all’emancipazione del Terzo Mondo dall’eredità dell’imperialismo neocoloniale e marxisti che si preoccupavano principalmente dell’emancipazione della classe operaia. Il problema era che se Il Capitale avesse rappresentato effettivamente un’adeguata chiave di lettura del conflitto di classe, i presupposti di Marx a proposito dello sviluppo capitalistico su scala mondiale non sarebbero sembrati reggere a un’analisi empirica. I presupposti di Marx richiamano molto più la tesi del ‘mondo piatto’ che Thomas Friedman è andato diffondendo negli ultimi anni.” (p.33)
Un punto importante.
Alcuni anni prima, del resto, anche David Harvey, in un libro citato ed utilizzato da Arrighi, sottolineò lo stesso punto:
“L’impresa multinazionale, con la sua capacità di spostare rapidamente capitale e tecnologia da un posto all’altro, di sfruttare risorse diverse, mercati del lavoro, del consumo e opportunità di profitto, organizzando la propria divisione territoriale del lavoro, trae gran parte del suo potere dal comando spaziale e dall’utilizzo di differenziali geografici in modi non consentiti all’impresa familiare. In ogni caso le implicazioni delle grandi trasformazioni avvenute nella geografia della produzione, del consumo e dello scambio attraverso la storia del capitalismo sono di per sé, sicuramente, degne di essere studiate.
Il confronto diretto con questo compito potrebbe aiutare a curare gli scismi e le ferite all’interno della tradizione marxista. Lo stesso Marx ha coraggiosamente abbozzato una teoria della storia capitalista basata sullo sfruttamento di una classe da parte dell’altra. Lenin, dal canto suo, ha sviluppato una tradizione differente, in cui assume centralità lo sfruttamento delle persone in un luogo da parte di quelle che sono in un altro (la periferia da parte del centro, il Terzo Mondo da parte del primo).
Le due retoriche dello sfruttamento coesistono in modo non facile e la loro relazione resa oscura. Il fondamento del marxismo-leninismo è quindi ambiguo e ha scatenato aspri dibattiti sul diritto all’autodeterminazione, sulla questione nazionale, sulle prospettive del socialismo in un solo paese, sull’universalismo della lotta di classe, e così via”[16].
Secondo la valutazione di Arrighi la cosa si può vedere da questo lato: l’analisi empirica mostra che il mondo, nella globalizzazione in qualche modo prefigurata anche da Marx, non si è affatto “appiattito”. Al contrario è andato soggetto ad una sempre maggiore divergenza. Negli stessi anni in cui le sinistre occidentali si innamoravano dei luoghi più “avanzati” del “laboratorio della produzione”, ricorda l’autore, Andre Gunder Frank “varava la metafora dello ‘sviluppo del sottosviluppo’[17] proprio per descrivere e spiegare quella vistosa divergenza”. Un modello[18] che fu peraltro criticato da molti proprio dal punto di osservazione del “marxismo occidentale”, perché “ridurrebbe i rapporti di classe a semplici epifenomeni della relazione centro-periferia”. In questo senso va, ad esempio, la critica di Brenner nel 1977[19], in un articolo della “New Left Review”, nel quale pur riconoscendo senso alla posizione di Frank ne contesta la pretesa conseguenza per la quale la classe sarebbe solo una sorta di “riflesso”.
Come inizia Brenner:
“la comparsa di barriere sistematiche all’avanzamento economico nel corso dell’espansione capitalista – lo ‘sviluppo del sottosviluppo’ – ha posto problemi difficili alla teoria marxista. È emersa, in risposta, una forte tendenza a rivedere bruscamente le concezioni di Marx in merito allo sviluppo economico. […] Sosterrò qui che il metodo di un’intera linea di scrittori nella tradizione marxista li ha portati a spostare le relazioni di classe dal centro delle loro analisi sullo sviluppo economico e il sottosviluppo. La loro intenzione è stata quella di negare il modello ottimista di progresso economico derivato da Adam Smith, in base al quale lo sviluppo del commercio e la divisione del lavoro determinano senza sosta lo sviluppo economico. Tuttavia, poiché non sono riusciti a scartare i presupposti del meccanicismo individualista sottostante di questo modello, hanno finito per erigere una teoria alternativa dello sviluppo capitalista che è, nei suoi aspetti centrali, l’immagine speculare della tesi ‘progressista’ che desiderano superare. Quindi, molto simili a quelli che criticano, concepiscono le relazioni (mutevoli) di classe come emergenti più o meno direttamente dai requisiti (mutevoli) per la generazione di eccedenze e lo sviluppo della produzione, sotto le pressioni e le opportunità generate da un mercato mondiale in crescita.
Solo, mentre i loro avversari tendono a vedere tali processi determinati dal mercato come innesco, automaticamente, di una dinamica di sviluppo economico, loro li vedono come rafforzamento dell’arretratezza economica. Di conseguenza, non tengono conto né del modo in cui le strutture di classe, una volta stabilite, determineranno in effetti il corso dello sviluppo economico o del sottosviluppo su un’intera epoca, né del modo in cui emergono queste stesse strutture di classe: risultato di lotte di classe i cui risultati sono incomprensibili in termini di sole forze di mercato”.
L’accusa a Frank e compagni è quindi di una sorta di meccanicismo che, in effetti, tale potrebbe anche essere inteso dalla dinamica del testo (ed in particolare dalla parabola complessiva della scuola). In particolare giova prestare attenzione alla polemica Frank-Amin seguita alla pubblicazione nel 1999 di “Re-Orient”[20]. Mentre Amin prende la direzione esattamente opposta e riformula in termini più ampi i concetti della vecchia “teoria della dipendenza”, ribadendo la necessità di una, almeno parziale, “disconnessione” per acquisire autonomia e autogoverno, Frank ormai guarda alla totalità e considera quindi ogni sviluppo come effetto non di un movimento interno (ad esempio di sviluppo delle forze produttive nella dialettica tra le classi sociali, dalla quale si può verificare storicamente l’insorgenza del capitalismo), ma di una rete di influenze e determinazioni sempre estesa a livello mondiale. Una rete nativamente estesa a livello mondiale. Segue una conseguenza non intenzionale: se tutto dipende dall’economico, ma questo è sovradeterminato dall’insieme totale delle relazioni internazionali, allora la lotta, che pure continua a rivendicare nella forma dei “movimenti antisistemici”, non può più avere alcun progetto possibile.
La tesi circa l’insorgenza storica del capitalismo di Brenner riformula invece in modo più tradizionale quella di Marx evidenziando le condizioni, contingenti, per le quali paesi esposti al commercio internazionale, ed in esso quindi incorporati, sviluppano le condizioni dello sviluppo capitalistico (concentrazione dei mezzi di produzione fuori dei ceti produttivi e competizione causata dallo spiazzamento dei ceti dirigenti). A questo modello marxiano contrappone quello, che definisce “Neosmithiano”, basato su specializzazione e divisione del lavoro sotto la spinta della messa in contatto commerciale del quale quello di Frank sarebbe solo un caso particolare.
Arrighi utilizza questa distinzione, accettando la qualifica che non condivide fino in fondo di “neosmithiano”, per segnalare la differenza tra processi che costituiscono mercati non capitalistici e processi di sviluppo capitalistico. Secondo la sua ricostruzione i primi processi erano sviluppatissimi nell’oriente fino al diciannovesimo secolo in assenza del secondo; quindi, mentre, come vedremo, la Cina restava in qualche modo intrappolata in un “equilibrio di alto livello”[21], l’Europa ne venne liberata dalla scoperta dell’America. E’ per questo che mentre al tempo di Smith la Cina era considerata più avanzata, ad un certo punto partì una “grande divergenza”[22], ma, bisogna notare, malgrado l’Europa non avesse affatto mercati più efficienti né per le merci né per i fattori di produzione. Secondo Pomeranz, infatti, nel 1789 i principali mercati europei erano meno aperti alla concorrenza, nei termini delimitati da Smith, di quanto lo fossero quelli cinesi.
Le questioni teoriche e pratiche che derivano da questa “riscoperta di Smith a Pechino” sono diverse: occorre spiegare le cause del salto energetico che impiega l’occidente, passando al carbone fossile, presente in abbondanza ma non usato nella stessa maniera anche in Cina, e, seconda cosa, bisogna spiegare perché la globalizzazione a regia inglese, nel diciannovesimo secolo, porti con sé la divergenza. La prima domanda vede enfatizzato da Wong[23] il salto di intensità dato dall’uso del combustibile, invece da Frank[24] l’opposta condizione di relativa scarsità di capitale e lavoratori[25], e la Pomeranz[26] la diversa dotazione di risorse insieme al rapporto centro-periferia “ossia al fatto che i paesi chiave dell’Europa nordoccidentale ricavano dal continente americano materie prime e vi esportano manufatti in misura considerevolmente maggiore di quanto i paesi guida dell’Asia riuscissero a fare con le proprie periferie” (p.41). Naturalmente ciò che fa la differenza è specificamente il nuovo tipo di periferia che crea la conquista dell’America, con la tratta degli schiavi e il sistema coloniale europeo, l’imposizione di forme mai viste di agricoltura intensiva ad altissimo sfruttamento (nella piantagione di Cortez lavoravano quindicimila indios in condizione di schiavitù[27]). Inoltre un ruolo molto importante, in questo scambio, lo gioca l’argento americano, estratto in miniere-lager e reinvestito in commerci di lunga percorrenza, in particolare con l’Asia. Anzi l’Asia per tutto il diciottesimo secolo in pratica lo drenava quasi tutto (tra l’altro, come vedremo, questo facile drenaggio è uno dei fattori che convince i Qing che non è indispensabile munirsi di forti flotte e autonoma capacità di commercio di lunga distanza).
Un modello che tenta di spiegare tutti questi fattori nella loro complessa relazione è quello tentato da Karou Sugihara[28] il quale pone l’accento sulla “rivoluzione industriosa”, che si sarebbe verificata in oriente dal sedicesimo al diciottesimo secolo insieme a tecnologie ed istituzioni ad alto contenuto di lavoro, a causa della scarsità relativa di risorse coltivabili. L’insieme di questi fattori ha comportato una notevole crescita della popolazione e anche del tenore di vita. Mentre in passato la popolazione cinese aveva oscillato entro la “trappola malthusiana” dalle parti dei cento milioni di persone, all’improvviso giunse infatti a quattrocento milioni. Nel 1800 quindi, su basi di mercato, ma senza alcuna evoluzione in direzione industriale, si sviluppa una economia forte ed autosufficiente, fortemente introversa, basata sulla famiglia e la comunità di villaggio. Si tratterebbe in parole semplici di un sentiero di sviluppo del tutto diverso da quello seguito dall’occidente e che Marx inclinava a vedere come necessario[29]: la proletarizzazione e creazione delle classi contrapposte degli operai e dei capitalisti. Il modello antropologico che si impone predilige chi sa fare più lavori diversi ed è abituato a cooperare e di inserirsi armonicamente nel lavoro della fattoria, affrontando e risolvendo insieme gli imprevisti. Complessivamente il modello prediligeva l’impiego di risorse umane invece che di risorse materiali.
Su questo modello, ad esempio nel caso giapponese, si innesta la spinta tecnologica che viene dall’occidente, creando un modello ibrido, ovvero una “industrializzazione ad alta intensità di manodopera”. Un modello che iniziò ad essere competitivo solo nel secondo dopoguerra nelle sue particolari condizioni.
Ci sono quindi due modelli distinti di crescita economica:
1- Quello smithiano, nel quale “lo sviluppo si dipana in un contesto sociale dato, sfrutta in funzione della crescita tutti il potenziale che quel contesto racchiude, ma non arriva mai a modificarlo in misura significativa”,
2- Il modello marxiano in cui “lo sviluppo economico su basi di mercato invece, tende a distruggere il contesto sociale che lo ospita e a creare le condizioni per l’affermarsi di una nuova struttura sociale (che non necessariamente diventare realtà) caratterizzata da un diverso potenziale di crescita” (p.56).
Per Smith il mercato è del resto un vero e proprio strumento di governo e l’economia politica è un ramo delle scienze dell’uomo di stato. La sua presenza presuppone l’esistenza di uno stato forte, “capace di creare e riprodurre le condizioni necessarie per l’esistenza del mercato stesso”. Si tratta di essere quindi molto lontani dalla pretesa fiducia dogmatica negli effetti benefici di una riduzione dell’intervento statale e nel mercato autoregolato.
Insomma, Smith, per Arrighi, “sarebbe stato d’accordo con Karl Polanyi”[30].
In relazione al tema della caduta del saggio di profitto[31] (come noto idea che Marx preleva da Ricardo e Smith), il compito dello stato è quindi esattamente creare la competizione e proteggerla per ridurre i profitti al minimo. Ovvero, per contenerli nei termini che siano socialmente accettabili. Lo stato deve operare per superare le contraddizioni che lo sviluppo economico produce.
Un punto molto rilevante nella trattazione di Smith è quando viene messo a confronto il tema della divisione del lavoro. Distinguendo tra divisione tecnica del lavoro (la “fabbrica di spilli” all’inizio del libro di Smith) e divisione sociale del lavoro (la relazione tra unità produttive indipendenti), il filosofo scozzese si concentra sulle relazioni tra settori, o tra territori, e i relativi scambi di mercato. Quindi “sulla concorrenza come agente di ulteriore divisione del lavoro e specializzazione fra vari comparti del commercio e della produzione; e in conseguenza su cosa debba fare un governo per promuovere, regolare e sfruttare la sinergia fra concorrenza e divisione del lavoro” (p.65). Secondo la lettura di Arrighi Smith, anche quando si concentra esclusivamente sulla divisione del lavoro lo fa principalmente per evidenziarne i difetti (nel ridurre l’uomo a una sola dimensione).
Venendo ai sentieri di sviluppo nell’opera di Smith si trovano contrapposti uno sviluppo “naturale”, graduale e per linee interne, attribuito alla Cina, che passa gradualmente dagli investimenti sull’agricoltura, poi alle manifatture ed infine al commercio estero. Ed uno sviluppo “innaturale e retrogrado”, e quindi “completamente rovesciato”, attribuito al caso olandese. Qui si parte dal commercio estero, che induce lo sviluppo di manifatture di lusso e raffinate, di qui allo stimolo all’agricoltura con il surplus guadagnato.
Tornando alla questione del modello “smithiano” verso quello “marxiano”, e quindi alla discussione con Brenner, autore marxista con il quale Arrighi si confronta in tutto il libro, è riconosciuto che Marx sviluppa un programma di ricerca completamente diverso da quello del filosofo scozzese (di cui ha, comunque, grandissimo rispetto). Ad esempio, rispetto allo sguardo verso i governi che esprime il suo predecessore Marx esprime una prospettiva che guarda alle “classi sociali”; non gli interessa se una “nazione” si impoverisce o si arricchisce, ma chi, all’interno di questa, lo fa. Quindi al centro della ricerca non c’è più la concorrenza (che pure è accuratamente modellata, ma con uno sguardo che potremmo dire “micro”), ma “il conflitto di classe e il progresso tecnologico sui luoghi di produzione”. Ancora, c’è il “segreto laboratorio della produzione” e non la circolazione tra i luoghi di produzione (è chiaro che ognuno di questi elementi è presente in Marx, e su ognuno la sua analisi è accurata ed efficace, ma la narrazione che li tiene insieme è in qualche modo rovesciata).
Diamo da parola ad Arrighi:
“Questo spostamento nella natura e negli argomenti della ‘narrazione’ ha finito per creare una gran confusione relativamente alla teoria implicita di Marx dello sviluppo nazionale. Dico implicita perché di una simile teoria non v’è traccia esplicita nel pensiero di Marx. Vi si trova invece una teoria dello sviluppo capitalistico su scala mondiale che coglie, anticipandoli, i tratti di quella che oggi chiamiamo ‘globalizzazione’ ma sbaglia nel predire che lo sviluppo capitalistico avrebbe ‘appiattito’ il mondo, nel senso in cui Thomas Friedman usa questa espressione.
In effetti l’aspettativa di un imminente appiattimento del mondo era così viva in Marx da spingerlo a basare interamente la sua teoria dello sviluppo capitalistico sull’assunzione di un mondo senza confini, in cui la forza-lavoro è totalmente spossessata di ogni mezzo di produzione e tutte le merci, ivi compresa la stessa forza-lavoro, vengono liberamente scambiate, a un prezzo all’incirca pari alla sua riproduzione” (p.88)
Si tratta di una rappresentazione piuttosto semplificata[32], ma fondamentalmente corretta.
La differenza tra le teorie dello sviluppo economico nazionale di Marx (implicita) e di Smith (espressa) sono principalmente connesse con la critica dello scopo della trasformazione in merci fatta propria dal capitalista. Per Marx lo scopo è l’accumulo di denaro (D-M-D’) mentre per Smith di utilità (si potrebbe dire M-D-M’). Naturalmente il processo di circolazione completo è una stringa di M-D-M-D’-M’’-D’’-M’’’,…) e quindi si tratta di focalizzazione. La seconda differenza è che entrambi identificano nel commercio di lunga distanza l’elemento cruciale del decollo capitalista dell’Europa, ma per Smith è “innaturale”, mentre per Marx è semplicemente il capitalismo. Ne deriva una svalutazione radicale di tutto ciò che si oppone al pieno dispiegarsi della logica della borghesia, e quindi in primo luogo del “modello asiatico”. Modello che sarebbe sconfitto dalla maggiore efficienza e quindi dal minore prezzo delle sue merci[33].
Ma il centro della critica che Marx svolge all’economia politica di Smith è che i cambiamenti tecnici ed organizzativi che interessano la società non sono originati essenzialmente dalla concorrenza che induce la nascita di nuovi settori specializzati e stimola la divisione del lavoro, ma dall’incessante conflitto tra il lavoro ed il capitale per la divisione del surplus. Ne segue che i capitalisti scaricano la pressione della concorrenza sui lavoratori (come scrive già Engels nel 1844[34] mettendo in concorrenza i lavoratori anziché concorrere con gli altri capitalisti) attraverso la continua innovazione e quindi, al suo tempo, ampliando dimensione e concentrazione delle unità produttive. L’aumento della dimensione delle unità produttive e della divisione tecnica del lavoro sono quindi le condizioni essenziali della crescita della classe dei capitalisti e della stagnazione di quella dei lavoratori spossessati dei mezzi di produzione. Cioè, come si può dire, “i mutamenti tecnici ed organizzativi non sono neutri ma hanno un segno di classe”. Naturalmente gli effetti anche per Marx, come per Smith, sono deleteri per le qualità morali ed intellettuali dei lavoratori.
Altre differenze sono nella nozione di tendenza alla crisi, presente nell’uno e assente nell’altro (che, casomai vede una tendenza alla stabilizzazione, ovvero alla stagnazione di alto livello); per Marx la crescita della concorrenza e la riduzione del tasso di profitto non sono dirette ad uno stato stazionario, ma piuttosto ad una “distruzione creatrice” che in Arrighi ha tre possibili dimensioni: aumento delle dimensioni dei capitali e riorganizzazione del sistema di aziende; creazione di un sovrappiù di popolazione e di un nuovo schema di divisione del lavoro internazionale; comparsa di nuovi epicentri di accumulazione capitalistica. Nel suo insieme il capitalismo ha quindi una spinta immanente a infrangere i suoi limiti, superando le fasi di sovraccumulazione con l’allargamento.
Questa posizione di Marx è fatta propria da Giovanni Arrighi ma solo a livello globale, invece secondo lui a livello dello sviluppo nazionale, o dell’intera Europa, non è adeguato a dare conto della insorgenza del capitalismo stesso, o della rivoluzione industriale. In questo punto si allinea alle tesi dell’ultimo Gunder Frank o di Hosea Jaffe[35], “le differenze tra i processi di sviluppo dell’economia di mercato in Europa e nell’Oriente asiatico non sono riconducibili alla presenza o all’assenza di specifiche istituzioni politiche o economico-commerciali, ma piuttosto alla loro combinazione in due differenti strutture di potere”. In altre parole non si trattava di avere più o meno “capitalisti”, ma del potere di imporre il proprio interesse di classe a scapito dell’interesse nazionale.
Come scriveva lo stesso Braudel:
“Si può parlare di trionfo del capitalismo solo quando esso si identifica con lo stato, quando si fa stato. Nella sua prima grande fase, quella delle città-stato italiane come Venezia, Genova e Firenze, il potere era saldamente nelle mani di una élite di ricchi. Nell’Olanda del diciassettesimo secolo, l’aristocrazia che esprimeva i Reggenti, governava a beneficio, e spesso sotto la direttiva dei mercanti, imprenditori e banchieri. Analogamente, la Gloriosa rivoluzione del 1688 in Inghilterra segnò l’accesso al potere degli imprenditori sull’esempio olandese”[36]
Questo fenomeno va connesso con la tendenza a reagire alla caduta del tasso di profitto con l’espansione finanziaria e con la competizione interstatale per attrarre questi flussi finanziari.
Seconda parte
Abbiamo dunque fondamentalmente definito la prospettiva teorica dalla quale è inquadrato il declino dell’egemone americano e la crescita dello sfidante cinese. In primo luogo appare la pertinenza di una frattura entro la stessa tradizione marxista, cui l’autore per buona parte della sua esistenza si è riferito. Frattura che può essere letta con gli occhiali di Losurdo come conflitto di paradigmi tra il “marxismo occidentale”[37] e “orientale”, rispettivamente risalenti a Marx, Engels e seguaci, ed a Lenin, Castro, Ho Chi Min, Guevara, e via dicendo. La decisione dell’autore in proposito è di accettare la definizione di “marxismo neosmithiano” proposta criticamente da Robert Brenner nel 1977 (contro l’ultima versione del secondo genere di marxismo espressa nella “teoria della dipendenza”), ma di ribadirne invece la validità come chiave di lettura dei fatti.
Richiamandosi ad elementi della lettura del grande filosofo scozzese, si tratta per Arrighi di comprendere quindi che cosa volle proporre effettivamente, al di là della semplicistica vulgata della “mano invisibile”, Adam Smith nel 1776 e misurare la fecondità delle sue intuizioni, mettendole in relazione con le ragioni del successo cinese. Questo sarà il compito della Seconda e Terza Parte del lungo testo. Utilizzandole si può rovesciare la percezione, che coinvolse in fondo anche Marx, di una sorta di naturalità del sentiero di sviluppo occidentale, mettendone in luce anche più di come comunque fece il grande tedesco la violenta natura. Riconoscere quindi la fondazione del capitalismo nell’estrazione di valore dalle periferie coloniali (per ma verità sia esterne sia interne[38]) e la capacità di alimentare e nutrirsi degli squilibri e delle dissimmetrie che esso stesso coltiva[39].
Riepiloghiamo, ci sono due tradizioni, e secondo quanto ritiene anche Harvey non facilmente armonizzate, nel marxismo:
- quella che risale allo stesso Marx[40], e anche più alla sistemazione tardo ottocentesco condotta da Engels e dai suoi successori (Kautsky[41] in particolare), e vede una linea di sviluppo endogeno, interno, del capitalismo nel continuo rivoluzionamento delle forze produttive che conducono pro motu proprio ad una maggiore efficienza e razionalità. Quel che si chiama normalmente “progresso”[42].
- la seconda, alla quale biograficamente ed emotivamente aderisce l’autore, che vede nel capitalismo un dispositivo di oppressione soprattutto delle periferie deboli del mondo, dei suoi popoli, e di estrazione delle loro risorse. Non c’è quindi progresso, ma “accumulazione per espropriazione” (Harvey), e, soprattutto, c’è una valutazione per molti versi opposta della resistenza alla modernizzazione, al “progresso”, quando non è prodotto dallo sviluppo autonomo e coerente con la propria natura e tradizione.
Abbiamo dunque:
- “Sviluppo del sottosviluppo” (Gunder Frank) verso creazione di un mondo “piatto” e progressista.
- “Disconnessione” verso “integrazione”.
- “Commonwealth” verso “Impero”.
La tesi, spostandosi sul piano storico, come adesso vedremo è che nello sviluppo orientale c’è stato a lungo un “mercato senza capitalismo”[43], capace di produrre molta più ricchezza della controparte occidentale, ma anche di intrappolare, in qualche modo, la società in una sorta di equilibrio che ha limitato l’innovazione (anche tecnica) o la sua diffusione e utilizzo. Non è sempre stato così, ma lo è stato nel momento decisivo, quello dell’incontro con l’occidente.
Sulle tracce della turbolenza globale
Nella Parte Seconda del libro, per comprendere come tale meccanismo si dispieghi e come d’uso in tutti i libri della “trilogia”[44], viene prodotta un’ampia ed estremamente interessante ricostruzione della successione storica delle crisi, a partire dalla lunga depressione dell’800, vivente Marx e che ha il suo termine negli ultimi anni dell’ottocento, quando con la morte di Engels si aprì nel socialismo tedesco, che svolgeva un ruolo di guida di quello europeo, la controversia Bernstein-Kautsky[45] e il revisionismo. Quasi improvvisamente una lunga fase di aspra competizione intercapitalistica, che aveva prodotto prezzi calanti e frequenti crisi locali, con brevissimi intermezzi, termina e i prezzi ricominciano a salire. Si impone allora un clima euforico nel mondo degli affari che passerà con il nome di Belle Époque. Un’epoca nella quale, tuttavia, le ineguaglianze crescono vertiginosamente e i benefici si ripartiscono a vantaggio di pochi. Sul piano internazionale riguardarono soprattutto l’Inghilterra e su quello di classe soprattutto quelle renditiere. La lunga crisi era stata una fase di scarsi profitti, ma di crescente benessere dei lavoratori, mentre la “Belle Époque” è stata, al contrario, una fase di profitti, ma non per i lavoratori. Crisi e benessere dipendono sempre dai punti di vista.
Anche il lungo boom degli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, che sfocia al termine in una crisi dei profitti, deriva da una forma di “sviluppo ineguale” tra aree economiche. Ovvero di differenti stati di crescita nel senso proposto da Brenner[46]; un senso ben applicabile a Germania e Giappone. Paesi ritardatari che infine riescono a raggiungere i paesi guida nella corsa alla frontiera capitalistica. Bisogna anche ricordare che in tutto il trentennio che segue alla fine della seconda guerra, e agli Accordi di Bretton Woods la crescita era stata impetuosa nei paesi guida dell’occidente, ma debole nei paesi “sottosviluppati”. Le cause erano state molteplici, come sempre capita, tra queste la lotta tra i due blocchi, che tendeva ad esasperare le ragioni di sfruttamento dei satelliti periferici, e accentuava, appunto, la “dipendenza” e lo stretto controllo politico dei flussi di capitale. Quell’assetto crebbe, raggiunse i suoi limiti, e andò infine in crisi (una crisi che fu contemporaneamente geopolitica, sociale, economica). La svolta si produsse nel 1965-73 e fu resa in ultima analisi necessaria da una sempre più aspra lotta commerciale, dall’irruzione nelle economie guida di prodotti e merci a basso costo e dalla riduzione del rendimento degli investimenti anche del 40% negli Usa. A questo attacco, a partire dai primi anni settanta gli Stati Uniti reagirono con una drastica svalutazione del dollaro e con la distruzione del regime di Bretton Woods. Una distruzione anticipata da molti segnali e forse prevista.
A questa maggiore competizione Germania e Giappone reagirono cercando di conservare la competitività contraendo la domanda interna. Seguì una fase confusa, caratterizzata da manovre dette di “stop and go”, da parte dell’Inghilterra e in qualche misura anche di tutte le principali economie del mondo (per evitare il progressivo indebolimento delle ragioni di scambio e l’instabilità monetaria anche l’ultimo Johnson ed il primo Nixon cercarono di provare una stretta creditizia, ma la sconfitta alle elezioni del 1970, convinse quest’ultimo a riaprire lo stimolo[47]). Ma in quel contesto le politiche espansive a metà dei settanta determinavano tassi di interesse in caduta e fuga dei capitali verso i tassi più alti di Germania e Giappone, e, conseguentemente la tendenza dei deficit della bilancia commerciale ad andare fuori controllo. Dopo un’altra svalutazione del 7,9% allo Smithsonian Agreement del 1971, nel 1973 tutti si arresero. Complessivamente tra il 1969 ed il 1873 il dollaro si svalutò verso il marco del 50%, cosa che consentì per un poco di recuperare la competitività delle merci perduta, ma trasferì gli impulsi di crisi in Europa.
Al termine di questo primo periodo di aggiustamento lo sviluppo ineguale nel senso dell’inseguimento tra grandi potenze industriali fu parzialmente ridotto, ma quello tra queste ed i paesi “in sviluppo” rimase simile. Ciò determinò una tendenza endemica all’eccesso di capacità produttiva a livello mondiale che ridusse per tutti i tassi di profitto. Quindi lo schema interpretativo proposto (che Arrighi riprende, accettandolo, da Brenner) è di “sovracapacità e sovraproduzione” (tendenziale). Questa condizione di stagnazione in effetti rimase persistente dal 1973 al 1993, per venti anni, durante i quali si completò la trasformazione del sistema economico internazionale. Una dinamica che fu attraversata da tre momenti principali:
1- la rivoluzione monetarista degli anni ottanta, che produsse come effetto principale l’inversione della svalutazione del dollaro e dei flussi di capitale che tornarono, impetuosi, verso l’economia guida (devastando i germi di crescita che si erano nel frattempo aperti nel mondo “in via di sviluppo”). In questo contesto si ebbe la resa della Francia di Mitterrand, dopo il biennio di politiche keynesiane[48].
2- il “Plaza Accord” del 1985, che svalutò il dollaro verso lo Jen, ponendo bruscamente fine alla crescita Giapponese, che stava seriamente preoccupando le élite americane;
3- il “Reverse Plaza Accord”, del 1995, che, al contrario, lo rivalutò. Questo secondo accordo intervenne a salvare il settore manifatturiero giapponese, spingendo verso l’alto il valore del dollaro e rendendo in conseguenza, in un contesto nel quale il settore manifatturiero americano era in ripresa e quindi i valori azionari erano buoni, la borsa americana estremamente attraente per gli investitori stranieri.
Quel che seguì è, come sottolinea Brenner nel 2002[49], una “messa in libertà di un torrente di liquidità proveniente dal Giappone e dall’Oriente asiatico e in generale dall’estero che si riversò sui mercati finanziari americani, provocando una brusca riduzione dei tassi di interesse che spianò la via a una forte crescita dell’indebitamento della grandi società che prendevano a prestito per comprare azioni di borsa”. Peraltro, a dimostrazione del carattere di forte progettualità geopolitica (il contesto primario è sempre il dominio del capitale occidentale, ed anglosassone in particolare) le autorità monetarie giapponesi facilitarono molto il processo continuando politiche di espansione monetaria e mitigando le limitazioni per gli investimenti all’estero. Partì così la bolla di fine secolo.
Il rovescio della medaglia fu che le grandi aziende, che furono il motore principale della fase, entrarono ovunque in un periodo di forte indebitamento. Una condizione che per essere risolta in modo definitivo rendeva necessario passare per una fase di deflazione dei debiti (privati) che non si fece allora, non si è fatta alla data del libro, non si è fatta ancora.
Secondo Brenner le teorie che invece vedono nella forza del movimento operaio nella contingenza degli anni sessanta e settanta, il fattore decisivo nel comprimere i profitti e minacciare le basi del meccanismo dell’accumulazione capitalista individuano un fattore ma gli attribuiscono una forza eccessiva. In effetti il fattore decisivo non fu la pressione “verticale” entro il sistema produttivo, ma quella “orizzontale” della competizione tra capitalisti e tra sistemi. Arrighi accetta solo fino ad un certo punto questa ipotesi e attira l’attenzione “sull’intera foresta di quella crescente marea multinazionale di conflitti sui salari e le condizioni di lavoro culminata fra il 1968 e il 1973”, la quale spinge verso l’alto i salari reali più dell’incremento della produttività. Questa esplosione ebbe effetto sulla contrazione del saggio di profitto, come ovvio, ma ebbe anche un effetto marcato e di lunga durata sull’andamento della competizione intercapitalistica. In questa crisi, al contrario di quella del 1870-90, ci fu anche un effetto inflazionistico rilevante (mentre in quella fu deflazionistico) e la rottura monetaria (mentre in quella dominò il gold standard). Il motivo fondamentale per gli Usa sarebbe che i costi politici di una politica deflazionista (che è quella standard nell’assetto capitalistico) erano troppo alti, data la situazione di alta conflittualità interna e relativa alla guerra del Vietnam. A Nixon serviva invece una qualche espansione per frenare la rabbia popolare. Peraltro la forza contrattuale dei lavoratori, come una delle cause per l’abbandono del gold standard è ancora più evidente in Francia, dove De Gaulle lasciò andare le politiche per evitare che la protesta studentesca del 1968 si saldasse con quella dei lavoratori. Insomma, per come la mette il nostro:
“Come suggerisce l’esperienza degli Stati Uniti e della Francia, la capacità di pressione del movimento operaio durante la transizione dal boom alla relativa stagnazione della fine degli anni sessanta e dei primi anni settanta non era un semplice riflesso della competizione intercapitalistica come era stato il caso durante l’inizio della svolta recessiva alla fine del diciannovesimo secolo. Al contrario essa fu sufficientemente forte da esercitare un’azione significativa non solo sulla stretta dei profitti che caratterizzò la transizione, ma anche nell’indirizzare la svolta recessiva lungo un percorso inflazionistico piuttosto che deflazionistico. Certo, sui profitti agiva contemporaneamente anche la concorrenza tra le aziende e certo dall’indirizzo inflazionistico dato dalla recessione i lavoratori non trassero particolari vantaggi né per loro né per la loro capacità di pressione” (p.147).
Alla fine la tesi fondamentale di Arrighi è che, semplicemente, l’inflazione funzionava meglio della deflazione per usurare la capacità di lotta dei lavoratori che caddero sotto i colpi della controrivoluzione di Reagan e Thatcher. Un ruolo, tuttavia altrettanto importante in questo passaggio lo giocarono le relazioni nord-sud del mondo e quindi l’impatto della decolonizzazione. Questa fu influenzata dal clima della guerra fredda e dalla crisi egemonica americana susseguente alla guerra persa in Vietnam. Il fattore che fu determinante non fu quindi la pressione dei lavoratori, o il conflitto concorrenziale, ma “gli effetti diretti e soprattutto indiretti dell’escalation del Vietnam sulla bilancia dei pagamenti negli Stati Uniti” (p. 153). La variabile di sistema fu la lotta per la supremazia e per contrastare nazionalismo e comunismo nel terzo mondo.
È questo il contesto nel quale la svalutazione del 1969-73 del dollaro finì per far cadere il peso della crisi dei profitti, causata da questo complesso di fattori, su Germania[50] e Giappone, provocando una redistribuzione degli oneri come sottoprodotto di misure per recuperare margini. Questo assetto di politiche giunse al suo massimo al termine degli anni settanta.
A questo punto accelerò la svolta finanziaria e per evitare il “macello dei capitali” che avrebbe curato la tendenza alla sovrapproduzione però al prezzo della perdita di egemonia di troppi (sia ceti e aziende sia nazioni) il capitalismo si ritirò nel suo “quartier generale” (Braudel), ovvero, appunto, nei mercati finanziari.
La svolta monetarista ha questo senso, si tratta di una inversione: “gli Stati Uniti sono passati dal ruolo di principale sorgente mondiale di liquidità e di investimenti diretti all’estero che avevano coperto durante gli anni cinquanta e sessanta, a quello di principale nazione debitrice e di pozzo di liquidità che non hanno più abbandonato ormai dagli anni ottanta” (p.165).
È dai mercati finanziari che in ultima istanza gli Stati Uniti ottennero quel che non avevano ottenuto né con le armi né con l’industria, ovvero la sconfitta dell’Unione Sovietica e, insieme, il disciplinamento del sud del mondo. Svolse un ruolo la corsa degli armamenti, il crescente indebitamento di tutti i paesi satelliti dell’Urss (che crolleranno in pochi anni), la crisi messicana del 1982, la recessione e liquidazione ideologica e politica dello Stato Assistenziale come parte di un vasto progetto di ricostituzione “dell’esercito di riserva industriale” e quindi dei margini della produzione (p.168).
Ma se questo fu lo scheletro della svolta, l’interpretazione di Arrighi, come nei suoi precedenti libri, passa per la nozione di crisi di egemonia[51] degli Stati Uniti, che aveva visto un suo momento alto nel New Deal Rooseveltiano e nella sua ipotesi di estensione al mondo, tramite le Nazioni Unite; poi nel consolidamento negli anni del keynesismo militare e nella politica di contenimento della sfida sovietica sulla base di più poli industriali dominanti (Germania, Giappone in primis), che dovevano restare sempre dominanti[52] e quindi l’appoggio strategico alla Comunità Economica Europea come necessario contrappeso al socialismo sia esternamente sia internamente. Ne segue una diagnosi, “lo sviluppo ineguale [nel senso di Brenner] all’ombra dell’egemonia prodotta dagli Stati Uniti non fu dunque un processo spontaneo prodotto dall’azione ‘dal basso’ dei capitalisti impegnati nell’accumulazione ma un processo incoraggiato dall’alto” (p.173). Un processo, dunque, non solo “capitalistico” (nel senso di Marx e di Brenner), ma anche “politico”, o meglio, naturalmente “geopolitico”.
Gli obiettivi che si poneva l’egemone americano erano infatti politici, nel mettere in piedi il sistema di potere del dopoguerra, e fallirono non tanto nel lasciar emergere Germania e Giappone come nuovi competitori, quanto nel riuscire a garantire benessere e pace sociale (gli anni sessanta e settanta sono anni di asprissimi conflitti sociali nelle “periferie interne”) e dominio sul resto del mondo emergente.
Sarà la “controrivoluzione monetarista”, insieme al dilagare dell’economia finanziaria che ne è causa ed effetto, a ottenere infine i due risultati. Si trattò di un punto di svolta complesso, nel quale ebbe un ruolo “l’eurodollaro”[53] ed una massa di capitali mobili che quadruplicò tra il 1967 ed il 1970. Dominarono due fenomeni paralleli: l’esplosione salariale, con conseguente erosione relativa dei profitti, e la massa di capitali parcheggiati. Si trattò di una enorme massa di manovra ed un fiume in continua crescita che finì per fare concorrenza alle istituzioni monetarie e statunitensi.
Ci furono per Arrighi in sostanza tre tendenze che si rafforzarono a vicenda:
1- La rottura del sistema di parità fisse,
2- Una posizione più aggressiva dei paesi del terzo mondo,
3- La mancanza di domanda di impieghi.
Questo processo ebbe un successo enorme, l’intera struttura della società si rivoltò, la direzione e qualità dei consumi passò da una trazione da parte dei consumi di massa ad una trazione condotta dai consumi “distintivi”. L’egemonia della classe sociale “affluente”, che esibisce i propri consumi facendone elemento del prestigio, della legittimità a dirigere, e della stessa propria qualità morale, si impose sulla precedente semi-egemonia “popolare”. Il processo trovò i suoi cantori e trovò i suoi critici, ma fu praticamente irresistibile.
Si trattava di una nuova Belle Epoque fondata su un meccanismo che, in basso, era sostenuto da una continua anticipazione di futuro, una costante espansione finanziaria e quindi delle strutture del debito e che, secondo Arrighi, nel lungo periodo avrebbero potuto portare ad un “nuovo crollo sistemico” (è in realtà molto più vicino, dato che il libro esce nel 2007). Si affermò, insomma, un modello nel quale domina la riduzione della concorrenza attraverso l’estensione delle relazioni clienti-fornitore ‘captive’, basate sull’associazione di monopoli e monopsoni, e l’interconnessione internazionale per sfuggire, o per arbitrare, ai regimi di regolazione. È il modello Wall Mart degli anni novanta, sulla base del quale, generalizzandolo, si imporrà nel nuovo millennio il modello della “gig economy”[54] e di “Amazon”.
Ma se l’egemonia americana, pur con questa enorme ripresa di centralità (ovvero incremento del dominio) è per Arrighi comunque in disfacimento, la fase imperiale si affermò invece come puro e brutale dominio solo dal 2001. A seguito dell’opportuno attentato delle Torri Gemelle (occasione presa al volo) Bush lanciò infatti un nuovo programma imperiale ripetendo la mossa fortunata di Roosevelt (che usò l’attacco di Pearl Harbor per fare la guerra di cui aveva bisogno per risolvere la crisi del New Deal) e di Truman (quando costruì la “guerra fredda” per poter proseguire le politiche espansive al livello necessario senza che i capitali si opponessero[55]). Considerando la persistenza del trauma della sconfitta del Vietnam, però, lo fece attraverso la “dottrina Powell”: colpire subito con una enorme sproporzione e disimpegnarsi. In Afganistan e soprattutto in Iraq la prima parte andò bene, ma la seconda fu uno spettacolare fallimento. Gli Stati Uniti si ritrovarono ancora una volta in un pantano, e con una continua emorragia di capitali.
Alla fine fu un fallimento ancora più grave, anche perché il resto del mondo rifiutò la guerra americana e si rifiutò di sostenerne i costi.
In conseguenza anche l’idea di un ordine mondiale riformato per mano militare, anziché con il “dolce commercio” come voleva Clinton nel suo entusiasmo democratico per la globalizzazione, fallì.
Restava quindi il dilemma di come finanziare la guerra:
1- Attraverso un aumento delle tasse,
2- Aumentando l’indebitamento con l’estero,
3- Rendendo la guerra autosufficiente,
4- Sfruttando il ruolo del dollaro.
In effetti furono tentati tutti, ma alla fine fu soprattutto il dollaro a svalutarsi, del 35% (come accadde peraltro dopo la guerra del Vietnam). Naturalmente si tratta di una politica rischiosa perché funziona solo fino a che la fiducia reggeva. Precisamente una politica che danneggiava tutti i detentori di dollari fuori casa e, in particolare, le riserve valutarie sovrane[56] in dollaro, ovvero il ruolo dello stesso come “valuta di riserva”.
Ma c’è soprattutto un altro lato della cosa: fino a che gli Usa restarono invischiati nella guerra del golfo crebbe anche la dipendenza dalle importazioni e dal credito estero a buon mercato. In queste condizioni non si poteva infatti cercare di ostacolare la crescita del nuovo paese che stava emergendo a sfidare il ruolo centrale americano: la Cina. Infatti in queste condizioni lo squilibrio della bilancia commerciale non poteva essere combattuto con i dazi, in quanto avrebbero potuto far aumentare l’inflazione a causa della necessaria sostituzione delle importazioni a basso prezzo cinesi con altre comunque più care. Ma allora, fino a che non si scioglie questo nodo, l’aumento dell’influenza cinese, che estende i suoi rapporti con paesi decisivi come l’Iran ed il Venezuela, o con parte dell’Africa, resta difficilmente contenibile.
Nel seguito del libro Arrighi guarderà molto più da vicino questa crescita.
Terza Parte
Abbiamo fino ad ora descritto il modo in cui l’autore dà conto dell’intervallo tra la “crisi spia” degli anni sessanta, connessa con il doppio deficit statunitense, l’esaurimento del predominio industriale e il termine con successo dell’inseguimento dei paesi sconfitti della seconda guerra ed aiutati a rialzarsi in chiave antisovietica nei confronti degli Usa, l’evento scatenante epocale della sconfitta in Vietnam.
Come abbiamo visto l’approccio del libro è molto largo e profondo, nel tentare di spiegare i lunghi percorsi della transizione in corso, e gli assetti di forza che di volta in volta si susseguono in essa, pone in questione l’idea che il capitalismo sia una sorta di destino del mondo, una tappa di un processo necessario di autosuperamento dell’umanità, che di qui, e necessariamente di qui, potrà infine giungere alla condizione pacificata del socialismo. Chiaramente questa critica viene svolta e diventa pertinente in considerazione della questione che è al centro del libro: può lo sviluppo imponente cinese costituire la base di un nuovo ciclo egemonico che sia significativamente diverso dal capitalismo anglosassone al quale succede (in caso succeda)? Non è, in altre parole, il modello cinese in effetti una pura e semplice mimesi del capitalismo occidentale senza neppure l’apparenza di libertà liberale? Ovvero, non è il peggio dei due sistemi?
Arrighi risponde di no. Ma nel farlo è costretto a chiedersi per quale ragione anche nella cultura marxista, ovvero nelle tante e diverse culture marxiste, in genere il capitalismo sia considerato contemporaneamente inevitabile e progressivo. Produce quindi un’interpretazione del modello di regolazione cinese, come ora vedremo, e della sua storia (le due cose non possono essere separate) che, come abbiamo letto, muove da un’interessante interpretazione del capolavoro di Adam Smith e ne recupera la proposta interpretativa ancorata su un modello di sviluppo “naturale” di tipo cinese, al quale si contrappone un modello “artificiale” di tipo occidentale. Il giudizio è quindi rovesciato. Come specificano inoltre gli autori con i quali si confronta, qui c’è una vera e propria frattura entro la stessa tradizione marxista. Una frattura che Brenner individua nella “scuola della dipendenza”[57] (definita “neosmithiana” (appunto), e Losurdo nella coppia “marxismo occidentale/orientale”[58], e che come ovvio contrappone il corpo principale (per noi) della tradizione che risale a Marx, dalla reinterpretazione che, sulla spinta delle necessità storiche e della situazione, ne forniscono i rivoluzionari effettivi nel terzo mondo (Lenin, Castro, Guevara, Ho Chi Min, Mao, …) pur nelle loro enormi differenze.
Rimettere in questione, anzi rovesciare, la naturalità del sentiero di sviluppo capitalistico-occidentale implica valorizzare in modo più accentuato elementi di critica che erano e sono pur presenti nell’intera tradizione marxista: la dipendenza dell’accumulazione capitalistica non tanto dalla creazione di valore, quanto dalla sua estrazione da periferie “coloniali” (si badi bene, sia esterne sia interne). Quindi la capacità di alimentare e nutrirsi ad un tempo delle dissimmetrie e degli squilibri che esso stesso coltiva[59].
Nella ultima parte del libro, al fine di ancorare in un solido argomento fattuale questa intuizione, Arrighi si sforza di mostrare che nel suo sviluppo storico, e come vide lo stesso Smith, nello sviluppo orientale ed in particolare cinese è stato creato e si è mantenuto a lungo stabile un “mercato senza capitalismo” che è stato capace di produrre molta più ricchezza della controparte occidentale. Lo svantaggio è che, per una serie di ragioni storiche proprie dell’area, questo modello ha -anche per il suo successo e la sua stabilità- in qualche modo intrappolato la società cinese in un equilibrio (di alto livello) che ha limitato e inibito l’innovazione (anche dove veniva prodotta) o, almeno, la sua diffusione ed utilizzo.
Questo equilibrio stabile si è dato in almeno due lunghe fasi, prima delle quali ci sono stati secoli di grande dinamismo ed innovazione (che, secondo alcuni, erano sul punto di far nascere un capitalismo cinese), e sfortunatamente l’ultima (la fase terminale della dinastia Qing) è coincisa con l’arrivo in forze del capitalismo occidentale.
La logica territoriale nella storia del capitalismo
Dopo aver compiuto una lunga carrellata sulla concatenazione delle crisi che hanno portato alle condizioni della transizione di potenza che è il vero tema del libro, Arrighi scrive un capitolo nel quale è ripresa la posizione di David Harvey[60] sull’imperialismo “di tipo capitalistico” come fusione di una logica che cerca il potere attraverso il controllo di un territorio, ovvero accumulando spazio in qualche modo, e una controllando il capitale economico che si muove tra gli spazi. La prima è la “logica territoriale del potere”, la seconda la “logica capitalistica del potere”. Entrambe sono in una relazione dialettica. Molte azioni apparentemente sproporzionate come l’enorme quantità di risorse impiegate nel sud-est asiatico in Vietnam, e l’intero contenimento dell’Unione Sovietica rispose a questa doppia esigenza, controllare gli spazi perché restino aperti all’accumulazione ed all’estensione degli scambi.
Recuperando la nozione di Lefebvre[61] di “produzione dello spazio” Arrighi mette in evidenza che la riorganizzazione spaziale è normalmente un processo che accompagna i momenti di crisi della accumulazione illimitata di capitale. Per cui molto spesso per risolverle deve intervenire lo Stato creando nuovo spazio, infrastrutture, reti.
La questione cruciale è dunque il rapporto tra relazioni spaziali e forze produttive, inclusa la produzione di sicurezza. La relazione con il keynesismo militare, la produzione delle guerre, il controllo della liquidità.
“Riassumendo, la rivalità tra stati per il controllo delle risorse mondiali è stata una componente fondamentale della competizione intercapitalistica che ha spinto verso l’accumulazione senza fine di potenza e di ricchezza lungo la traiettoria europea di sviluppo. La corsa agli armamenti è stata infatti la fonte primaria dell’infinita serie di innovazioni che hanno portato alla continua formazione, nei commerci e nella produzione, di nuove configurazioni spaziali di dimensioni e differenziazione crescenti e alla distruzione di quelle preesistenti. A fare del percorso europeo un percorso specificamente capitalistico era il fatto che il controllo sulle risorse finanziarie mondiali conferiva agli europei un vantaggio decisivo nella competizione per tutte le altre risorse. Sebbene l’industrialismo abbia costituito sin dall’inizio una componente importante di tale percorso, la Rivoluzione industriale come tale fu più una variabile ‘intermedia’ che una variabile ‘indipendente’: fu il risultato di un’interazione, durata due o tre secoli, di capitalismo finanziario, militarismo e imperialismo sfociata in quel periodo in un formidabile potenziamento della miscela. Per di più, non appena l’industrializzazione si fu rivelata come l’elemento chiave della potenza militare, il circolo virtuoso di aumento della ricchezza e della potenza che fino ad allora aveva caratterizzato il percorso europeo cominciò a mostrare di essere vicino ai suoi limiti. In Europa la lotta per la conquista dello spazio considerato vitale per la creazione e il mantenimento di complessi militari-industriali competitivi andò fuori controllo creando dei varchi per le rivolte ‘anti-occidentali’ della prima metà del secolo che improvvisamente fecero lievitare i costi deprimendo contemporaneamente i benefici dell’espansione territoriale oltremare. Contemporaneamente questa competizione determinò una migrazione dell’epicentro del potere dall’Europa dell’ovest verso Est e verso Ovest, in direzione della Russia e degli Stati uniti, cioè dei due stati di dimensioni continentali che erano già riusciti ad acquisire tutto lo spazio territoriale necessario a creare e mantenere complessi militari-industriali competitivi.” (p.303).
A questo assetto, nel quale si era chiusa la seconda guerra seguirono lunghi anni di “duopolio” e di “l’equilibrio del terrore”. Ma negli anni ottanta gli Stati Uniti, alzando progressivamente la posta della competizione, alla fine riuscirono a mettere in bancarotta i loro rivali. Dunque a sconfiggerli.
Il retroterra storico della nuova era asiatica
È a questo punto che, dopo un avvio in sordina nelle prime riforme di Deng Xiaoping, dagli anni ottanta ad oggi la Cina sembra essere impegnata in una “pacifica ascesa” apparentemente irresistibile e all’inizio ben sostenuta dagli stessi Usa, che all’inizio con tale spostamento spaccano il campo socialista e pongono sotto pressione da sud il rivale storico. Ma dopo la caduta del comunismo sovietico, tra il 1989 ed il 1991, questa crescita continua ed accelera e con il tempo diventa una chiara minaccia per la conservazione del primato americano sul mondo. Primato dal quale dipende in parte la stessa ricchezza ed il tenore di vita statunitense[62].
Allo stato nel quale il libro viene scritto, il primo decennio del nuovo millennio, ci sono ormai tre linee di pensiero strategico entro il sistema istituzionale americano per avere a che fare con la Cina:
1- Venire a patti.
2- Contenerla con un circuito flessibile di base, accordi, alleanze. Quindi fare accordi e compromessi.
3- Uscire dal quadro strategico e cercare di fare “il terzo che gode”, lasciando che sul treno si ammazzino.
La seconda strategia, proposta da Kaplan, ha in effetti funzionato molto bene nel circondare, contenere ed infine battere l’Urss, ma, ricorda Arrighi, la Cina non è affatto come l’Urss. Questa propone una dottrina dell’helping joeqi che prevede di “emergere velocemente in modo pacifico” (p.326).
La prima e la terza sono altrettanto complesse da implementare, e spesso anche solo da comprendere.
Si tratta, chiaramente, di “una grande muraglia di incognite”, nella quale è chiaro solo che nell’attuale assetto della mondializzazione le multinazionali occidentali prendono tutti i vantaggi e gli Stati Uniti, in quanto ente collettivo molto meno.
Nella Quarta Parte, intitolata ad una “era asiatica” che viene in qualche modo data per certa, viene messo in evidenza il punto cruciale, molto discusso in quegli anni, per il quale gli Stati Uniti soffrono di una cruciale dipendenza dagli acquisti cinesi in dollari (indispensabili per conservare il predominio monetario) e d’altra parte di merci a buon mercato (per sostenere il loro declinante stile di vita per la massa di una popolazione che non dispone di un reddito commisurato alle sue aspettative). Il secondo fattore rende estremamente problematico reagire efficacemente alla mancanza di competitività delle merci prodotte in patria in stabilimenti americani (anche se buona parte delle merci importate è, in effetti, prodotta sempre da aziende americane o su licenza, ma, appunto in Cina o nei paesi del sud-est asiatico) con dazi o altre forme di protezione.
In quello che è un nodo successivamente affrontato da Trump, viene indicato il circolo vizioso socio-politico che deriva da questo schema depressivo: merci importate vs meno lavoro solo temporaneamente rinviato dalla finanza[63]. Un circolo che fa, come reazione, emergere la “rivoluzione conservatrice” (come la chiama Thomas Frank[64]) ovvero di “bianchi, operai e classe media, che reagiscono alla perdita di prestigio sociale e di reddito rafforzando la propria identificazione con valori religiosi, forze armate e partito repubblicano più che con i propri interessi di classe, le proprie organizzazioni sindacali e il partito democratico” [65] (p.342).
Questo grumo di sentimenti politici viene inizialmente tradotto in mandato politico da George Bush (2001-9), che è colui al quale pensa Arrighi, ma poi in qualche modo trasformato nel “we can” di Barack Obama (2009-17) e finalmente preso di petto e portato in piena luce, insieme al problema della “Rust belt” (quindi del midwest e del sud con il loro profondo rancore), dalla sorprendente campagna di Trump[66]. In essa i temi dell’egemonia americana, attraverso i fondamentali produttivi, sono posti come centrali e quindi lo sono quelli del confronto con gli ex inseguitori, con Giappone, Germania (e, per estensione, Unione Europea) e soprattutto Cina. Ma anche Messico e Canada (con la revoca dell’accordo-chiave di Clinton, il padre della globalizzazione neoliberale, e la successiva ridiscussione su basi più convenienti per il reshoring[67] delle industrie americane).
Del resto l’incoerenza della politica di Bush, ma per certi versi anche quella di Obama, era che al contempo cercava l’appoggio della “rust belt” e del capitalismo monopolistico fortemente finanziarizzato e internazionalizzato che la generava. Per come la mette Arrighi, “si tratta insomma di una mancanza di coerenza che esprime la necessità dell’amministrazione Bush di coniugare la volontà del capitale americano di trarre profitto dall’espansione cinese con i sentimenti nazionalistici e militaristi della propria base elettorale”.
Dal punto di vista del progetto di potenza anglosassone, dunque, bisogna cambiare passo nel confronto con la Cina e passare a focalizzare il contenimento intorno a lei. Ma della Cina, in ultima analisi, i decisori americani non sanno nulla. E quindi non riescono a prefigurare le conseguenze della sua ascesa. A partire dalla leggenda che vede nascere lo Stato Nazionale in Europa, quando molti stati del sud-est asiatico hanno secoli di precedenza (il Giappone, la Corea, la Cina stessa, il Vietnam, il Laos, la Thailandia e la Cambogia). Oppure dalla questione dei traffici marittimi privati: anche questo fattore decisivo non è prerogativa esclusiva dell’Europa infatti durante la dinastia Song (960-1276) ci fu una grande fioritura di traffici non inferiore a quella coeva occidentale.
La Cina, insomma, non viene dopo. Non è una appendice dell’occidente e da questo interamente determinata.
Ci sono grandi differenze:
1- La dinamica del sistema europeo era caratterizzata dalla competizione militare fra le singole entità nazionali e da una tendenza all’espansione geografica del sistema di dominio. L’evento di pace più lungo (1815-1914) è stato infatti senza precedenti e peraltro caratterizzato da una intensa attività di lotte di espansione competitive. Invece il sistema asiatico si distingueva per la sostanziale assenza di scontri militari di rilievo (anche nella “pace” europea ci furono numerose guerre minori per procura o frizionali, da alcune di queste nacque lo stato italiano). In Asia ci furono, al contrario, trecento anni di pace ininterrotta tra due eventi bellici, entrambi provocati dal Giappone (il più militarista tra gli stati orientali), le due invasioni della Corea nel 1592-98 e nel 1894-95, che finirono in entrambi i casi per coinvolgere i cinesi.
2- L’assenza di ogni tendenza alla costruzione di imperi oltremare e della corsa agli armamenti.
E’ possibile che tra le due differenze ci siano relazioni di interna necessità (l’impero oltremare viene sviluppato per la pressione competitiva, anche se nel caso europeo è mosso dall’imprenditoria privata, tuttavia protetta e coperta dalla nazione di riferimento), ma restano estremamente rilevanti.
Per lo più, oltre tutto, le guerre orientali non sono avvenute tra stati nazionali, ma alla frontiera. In particolare negli ultimi anni dei Ming e nei primi centocinquanta anni della dinastia Qing. la grande strategia dell’impero cinese fu sempre di cercare di trasformare una frontiera difficile (quella con le tribù seminomadi mongole) in una periferia pacificata abilitata a fungere da cuscinetto. A riprova di ciò bisogna ricordare che non appena questo obiettivo sembrò ottenuto (intorno al 1760) cessò immediatamente l’espansione territoriale (p.354).
Ma c’è anche un’altra fondamentale differenza per Arrighi, e questa potrebbe fungere da spiegazione, insieme alla minore competizione, per spiegare l’assenza di una spinta coloniale (ovviamente un’altra è il carattere molto più “pieno” delle aree limitrofe all’estremo oriente): la dinamica delle risorse. Mentre in Europa si estraggono, con qualsiasi mezzo, risorse dalle periferie conquistate, in Cina, al contrario, nelle periferie si investe per conquistarne l’amicizia e/o la subalternità[68].
Ne consegue, da questo insieme di fattori, che mentre lo sviluppo europeo è fortemente estroverso quello estremorientale è più introverso. Inoltre il peso degli scambi commerciali sulle lunghe distanze resta sempre molto più rilevante per il sistema europeo, che in termini di sistema-mondo era periferico[69], che nel sistema orientale, nel quale gli scambi a breve raggio, interstatali o infrastatali, sono preminenti. È in questa dissimmetria che affonda il basso rendimento immediato delle famose spedizioni di Zheng He nell’Oceano Indiano nel quindicesimo secolo.
Questa dissimetria a svantaggio europeo è fatta saltare dalla scoperta, non accidentale ma sistemica (ovvero espressione della ricerca di sbocchi e della competizione tra le corone europee), dell’America e soprattutto dalla costosa spinta alla sua colonizzazione. Questa ha finito per offrire agli stati europei sia nuovi mezzi per la penetrazione nei mercati asiatici sia una nuova fonte di ricchezza e potere.
In sostanza si può riassumere la cosa in questo modo: “l’estroversione della lotta per il potere in Europa era una caratteristica fondamentale della specifica combinazione di capitalismo, militarismo e ambizione territoriale che è stata la forza propulsiva della globalizzazione del sistema statale europeo” (p.357).
Consegue da questa lettura la necessità di riconoscere che il mercato interno non è una invenzione occidentale, per tutto il diciottesimo secolo il più grande mercato nazionale è in Cina. Si tratta di una istituzione dalla lunga gestazione che viene consolidata dalle politiche della dinastia Qing, ma che parte dalla necessità durante la dinastia Song del Sud (1127-1276) di finanziare le spese militari e le ricostruzioni derivanti dalle guerre con i mongoli a nord e di ovviare alla perdita di controllo della essenziale “via della seta” incoraggiando altre attività tassabili come i traffici marittimi privati. A questo fine finanziarono la ricerca cantieristica e navale e resero le giunche cinesi le più avanzate del periodo, con innovazioni come la bussola, la pruna affilata su fondo piatto, etc… gli spostamenti di popolazione al sud portò la densità nelle regioni risicole più alta che in Europa e il sovrappiù agricolo consentì una elevata diversificazione di attività. Sotto la dinastia Yuan (1277-1368) questo processo di consolidò, portando a estese reti commerciali tra i mari del sud-est e l’oceano indiano[70]. In sostanza per Arrighi “nell’Asia orientale ai tempi dei Song e degli Yuan erano già presenti quelle che si sarebbero dimostrate tendenze tipiche del percorso di sviluppo europeo”.
Ma queste tendenze non sfociarono nella competizione tra stati per la costruzione di imperi territoriali e commerciali oltremare. Anzi, sotto la dinastia Ming ci fu una svolta introversa, furono poste sotto controllo le rotte esterne e favorito il commercio interno, e fu spostata la capitale da Nanchino a Pechino, spostando di fatto a nord le strutture commerciali e di mercato che si erano sviluppate nel sud. Furono anche costruite vie d’acqua interne per portare le risorse agricole del sud al nord che si specializzò nelle produzioni di cotone grezzo, mentre nello Yangtzi avveniva la lavorazione in tessuti.
I Ming, insomma, favorirono una più pronunciata divisione del lavoro e relativo commercio interno e centralizzarono il controllo fiscale, ponendo restrizioni al commercio marittimo come all’emigrazione nel sud-est asiatico. E’ questo il contesto nel quale le spedizioni d Zheng He, quando la turbolenza della frontiera nord diventa impellente vennero interrotte.
Il dilemma è acuto, come scrive Janet Abu-Lughod: “sul punto di dominare una considerevole porzione del globo e in possesso di un vantaggio tecnologico non solo attinente alle produzioni pacifiche, ma anche alla potenza militare e navale […] perché mai la Cina ha fatto retromarcia e ritirato la flotta, lasciando così un enorme vuoto di potere che i mercanti mussulmani, privi com’erano dell’appoggio militare di una flotta di stato, si trovarono assolutamente impreparati a colmare, ma che i loro ‘colleghi’ europei si sarebbero dimostrati ansiosi e perfettamente in grado di occupare solo settant’anni dopo” (cit.p.360).
La risposta di Arrighi è semplice:
“Gli stati europei hanno combattuto guerre senza fine allo scopo di stabilire un controllo esclusivo sulle rotte che univano l’Ovest all’Est, perché il controllo del commercio con l’Oriente rappresentava una risorsa critica per la ricerca di ricchezza e potere da loro praticata. Invece per i governanti cinesi il controllo delle rotte commerciali di lunga distanza era assai meno importante che non il consolidamento di relazioni pacifiche con gli stati confinanti e l’integrazione di tutto il loro popoloso dominio in un’unica economia nazionale a base agricola. Quindi per i Ming era del tutto razionale non disperdere risorse nel tentativo di controllare rotte commerciali fra Est e Ovest, per concentrarsi invece nello sviluppo del mercato interno, dando così l’avvio a quello che Smith definirà come modello esemplare del suo percorso ‘naturale’ verso la ricchezza”.
Qui viene anche una delle differenze più sorprendenti della diversa mentalità, e situazione materiale, dell’estremo oriente, rispetto al caso europeo: persino il commercio tributario (che, appunto, le missioni di Zheng He avrebbero espanso) aveva un saldo negativo. Da oltre mille anni, dai tempi delle dinastie Qin, i rapporti tributari fra il centro e gli stati vassalli, al contrario del modello occidentale (ma, per quel che ne sappiamo anche persiano), non erano dalla periferia al centro via tributo o tassa. Gli stati vassalli, salvo che nella dinastia Yuan, portavano doni simbolici, ad attestare la loro fedeltà, ricevendo in cambio doni di valore maggiore. La relazione era quindi in qualche modo di clientela/protezione. il “regno di mezzo”, che era più ricco per la sua estensione e mercato interno, acquistava la fedeltà e controllava i flussi di merci attraverso la creazione di una fascia di paesi vassalli tenuti in condizione di reciproca convenienza[71]. Questa unione di “ricchezza e liberalità” che procura “amici e servi”, come disse Thomas Hobbes, funzionava se il paese era ricco e se era abbastanza forte da disincentivare (anche pagandoli) i vicini a provare ad appropriarsene.
La transizione violenta tra Ming e Qing fu causata dal venire meno di tutte queste condizioni. Quindi dalla riduzione del “tributo inverso” e dalle crescenti difficoltà fiscali. Per un poco si trovò un equilibrio basato sull’argento europeo e l’esazione di tasse ai traffici relativi, ma nel 1644 una generalizzata rivolta affermò la dinastia successiva. La dinastia rivoluzionaria partì con il bando al commercio privato e una violenta politica della “terra bruciata” che trasformò il sud-est della Cina in “una terra di nessuno che teneva separati i due universi economici”. Dopo venti anni fu rimosso il bando ma inserite comunque drastiche limitazioni alle navi e la proibizione delle armi da fuoco. Nel 1717 fu di nuovo proibito andare all’estero e nel 1757 definito un unico porto autorizzato. Ma contemporaneamente fu esteso il mercato interno con le terre di frontiera nord e ridotte le tasse, insieme a redistribuzione delle terre e bonifiche. Seguì una politica di riduzione delle ineguaglianze interne e grandi opere per dare lavoro, oltre che la ristrutturazione dei granai pubblici (che compravano il grano nei periodi di abbondanza e lo mettevano a disposizione a prezzo politico in quelli di carenza). Pace, prosperità, crescita demografica e quel modello che Smith vide al suo tempo.
Tutto molto efficace e razionale, ma con un grosso punto debole che i contemporanei non potevano vedere: gli europei.
La Cina era infatti entrata in quella che Arrighi chiama “una trappola di equilibrio di alto livello”, l’insieme degli incentivi presenti nella situazione non incoraggiava l’innovazione e lo sviluppo tecnico e tendeva ad essere statica. Non è sempre stato così, anzi tra il 800 e 1300 c’era stata una grande crescita tecnica che poi rallentò. Alcuni, come Christopher Chase-Dunn e Thomas Hall[72], ne hanno tratto la convinzione che il capitalismo era sul punto di materializzarsi nella Cina dei Song (del sud), ovvero prima dello spostamento a nord ad opera dei Ming. Certo, dopo di allora ci fu un altro scalino di crescita tra la fine dei Ming e i Qing, appunto per effetto delle massicce politiche pubbliche e riforme rivolte a rendere più equilibrata l’economia, ma portò, se pure ad un equilibrio più “alto”, in realtà ad una maggiore distanza dal capitalismo.
Bisogna intendere i termini per come qui si usano:
“il carattere capitalistico di uno sviluppo su basi di mercato non è determinato dalla presenza di istituzioni e disposizioni capitalistiche, ma dalla relazione tra potere dello stato e capitale. Si possono aggiungere capitalisti a volontà a una economia di marcato, ma se lo stato non è subordinato al loro interesse di classe, quell’economia di mercato mantiene il suo carattere non capitalistico” (p.368).
Soprattutto sotto la dinastia “rivoluzionaria” dei Qing, ma anche sotto i precedenti Ming, anche se i banchieri e uomini di affari della provincia dello Shanxi e oltremare assomigliavano agli stessi tipi umani europei del sedicesimo secolo, nel complesso prevaleva l’ostilità dello stato per chi era diventato “anormalmente ricco” (come si esprime Braudel); cosa che significa che “lì non poteva esserci capitalismo, fatta eccezione per alcuni gruppi ben definiti che erano sostenuti dallo stato e, in definitiva, alla mercé dello stato”[73].
Come sottolinea anche un autore cinese:
“gran parte della ricchezza commerciale europea è stata divorata da governi sempre a corto di mezzi e ansiosi di espandere le loro entrate fiscali per far fronte all’aumento senza fine dei costi della guerra […] Sia i mercanti sia i governanti europei traevano vantaggio da questa loro complessa relazione, i primi intascando profitti favolosi e i secondi procurandosi il denaro di cui avevano assoluta necessità. La Cina del tardo impero non ha sviluppato questo tipo di mutua dipendenza dai grandi mercanti. In assenza di difficoltà finanziarie di dimensioni paragonabili a quelle europee, i funzionari governativi cinesi fra il sedicesimo e il diciottesimo secolo erano meno stimolati a immaginare forme di finanza creativa e a contrarre grandi debiti coi mercanti, mentre restava loro sostanzialmente estraneo il concetto di debito pubblico, così come quello di debito privato”[74].
Ci furono peraltro grandi organizzazioni affaristiche capaci di controllare grandi reti di intermediari commerciali ed appaltatori, ma rimasero sempre un gruppo subordinato, che per lo più proliferava negli spazi interstiziali. L’esempio più importante è quello della famiglia Zheng che mise in piedi un vero e proprio impero commerciale di dimensioni simili all’Olanda del tempo, eliminando anche la concorrenza portoghese, usando navi da guerra competitive e armi da fuoco. Riuscirono anche a liberarsi degli esattori Ming, ma ne provocarono la reazione, si rifugiarono infine a Taiwan ma furono sconfitti militarmente dai Qing nel 1683. Questo provocò il disarmo dei commercianti cinesi e la “terra bruciata”.
Quando alla fine giunsero gli europei, e dopo guerre che costarono oltre venti milioni di morti[75], tutto il sistema cinese fu incorporato in posizione subordinata nel sistema europeo, ormai divenuto mondiale. Si ebbe una enorme contrazione della sua quota della produzione mondiale. all’Asia orientale mancava una cosa essenziale, la sinergia tra militarismo, industrialismo e capitalismo che invece è tipica del cammino europeo.
Ma ciò, ovvero la subordinazione, non fu:
“in misura determinante il frutto di una maggiore competitività dell’impresa economica europea rispetto a quella asiatica e, in particolare a quella cinese. Contrariamente all’affermazione di Marx e Engels che le merci a buon mercato sarebbero state ‘l’artiglieria pesante’ con cui la borghesia europea avrebbe abbattuto ‘tutte le muraglie cinesi’, i produttori e i mercanti inglesi incontrarono molte difficoltà a battere la concorrenza delle loro controparti cinesi anche dopo che le muraglie dei regolamenti statali che avviluppavano l0economia nazionale della Cina erano state abbattute dalle cannoniere britanniche. Sebbene dopo il 1830 alcuni settori e regioni dell’economia cinese venissero pesantemente danneggiati dalle importazioni di prodotti tessili inglesi, nei mercati rurali le stoffe di cotone provenienti dall’Inghilterra non furono mai in grado di competere col più robusto panno cinese. Inoltre, man mano che le importazioni dall’estero rendevano obsoleta la filatura manuale del cotone, l’introduzione anche in Cina di filati più a buon mercato prodotti a macchina conferì all’industria tessile locale una nuova spinta propulsiva che non solo le consentiva di mantenere le proprie posizioni, ma anche di crescere. Le aziende occidentali che aprirono stabilimenti in Cina non riuscirono mai a penetrare commercialmente in modo efficace nelle sconfinate regioni interne, e dovettero sempre dipendere dalla mediazione dei grossisti cinesi sia per le forniture di materia prima sia per la vendita dei loro prodotti. Gli imprenditori e i prodotti occidentali ebbero effettivamente successo solo in alcuni settori industriali, come le ferrovie e le miniere, ma nel resto dell’attività economica il mercato cinese non doveva procurare che frustrazioni agli uomini d’affari stranieri” (p.373).
Sorsero settori redditizi, il più rilevante divenne l’esportazione di lavoratori, i coolie, e la gestione delle rimesse. Ciò fece le fortune di Singapore, Hong Kong, Penang e Macao e di molti capitalisti cinesi all’estero, fino al collasso della dinastia nel 1911. Ma già dalla guerra del 1841, cosiddetta “dell’oppio”, la Cina nel suo complesso non era più il centro del sistema orientale.
A questo punto il Giappone, modernizzandosi a tappe forzate, tentò di prenderne il posto. La guerra che seguì nel 1894 accelerò ulteriormente il disfacimento ed il caos politico. Seguirono i signori della guerra, un’altra invasione giapponese, la guerra civile tra comunisti e nazionalisti.
Subentrò allora l’egemonia americana.
Origini e dinamica della ascesa cinese
A questo punto resta da cercare di spiegare le ragioni dell’ascesa cinese dal pozzo del declino in cui era caduta. In grande misura questa è in relazione con l’attrazione di capitali e di know how occidentale, ma non dipende tanto dalla manodopera abbondante ed a buon mercato, quanto dalla disponibilità di forza-lavoro di alta qualità in termini di salute, istruzione e margini di autonomia, insieme alla rapida espansione delle condizioni della domanda e dell’offerta generata dalla mobilitazione produttiva di queste risorse nel paese. Ma questa attrazione riesce per la mediazione ancora una volta dei capitalisti cinesi, per lo più della diaspora, ovvero di Taiwan e Hong Kong. In pratica è come se si fosse stabilita un’alleanza tra il Partito Comunista al potere e gli imprenditori d’oltremare, che consentono ai capitali occidentali di saltare sul carro.
Ma la Cina non si allinea mai, in nessuna circostanza, al Washington Consensus, protegge la propria sovranità e cerca sempre di mantenere la stabilità nelle ristrutturazioni facendole procedere solo di conserva con la creazione di nuovi posti di lavoro. Accetta gli investimenti diretti solo e nella misura in cui li reputa funzionali ai propri interessi nazionali. Tiene alte le protezioni, modernizza il sistema di istruzione.
In sostanza mette più in competizione tra di loro i capitalisti che i lavoratori (p.395).
Insomma, tiene sempre il coltello dalla parte del manico, determinando una condizione di perenne sovraccumulazione che genera una pressione al ribasso dei saggi di profitto. Si tratta di una sorta di capitalismo ‘alla Smith’, che costringe i capitalisti, per mezzo dell’inarrestabile concorrenza, a muoversi in direzione dell’interesse nazionale.
Anche se al prezzo di episodi di superfruttamento nell’insieme si tratta, cioè, di una “accumulazione senza spoliazione”. Svolgono un ruolo in questa direzione le imprese di municipalità (p.400), le conquiste dell’epoca di Mao, l’incapacità, per ora, della classe dei capitalisti di prendere il potere.
Poteva farsi qualcosa di diverso? Arrighi risponde di no. “Il partito comunista non poteva fare altro che giocare al gioco della politica mondiale con le regole che c’erano, ossia con quelle capitalistiche, come d’altra parte sapeva benissimo lo stesso Mao. Dopo che l’incombente sconfitta in Vietnam aveva costretto gli Stati Uniti a riammetterla nel giro dei normali scambi commerciali e diplomatici con gli altri paesi dell’estremo oriente e con il resto del mondo, era perfettamente logico per la Cina comunista cercare di sfruttare le opportunità aperte da quei rapporti per rilanciare la ricchezza nazionale e la sua potenza” (p.409).
Alcune radici del resto sono proprio presenti nella rivoluzione anti-leninista condotta sin dall’inizio da Mao. Anche se restava il Partito-avanguardia questo portava avanti una “linea di massa”, non solo maestro ma anche allievo delle masse. Ciò significava anche promuovere contadini più che operai (la “classe rivoluzionaria” di Marx), dato che questi per lo più stavano dalla parte del capitale con il quale erano integrati. Ciò spinse il partito rivoluzionario verso la Cina profonda, lontano dalla costa. Ma ciò modellò anche il particolare rapporto con le masse contadine che furono elevate ed assorbite dal partito comunista e quello con la rivoluzione industriale, che non fu mai presa in modo acritico (come in sostanza ha fatto il comunismo sovietico).
Alla fine per Arrighi l’ascesa economica cinese, anche se difettosa e rischiosa, è il “sintomo premonitore di quella maggiore equità e rispetto reciproco fra i popoli di stirpe europea e non europea che Smith aveva delineato e auspicato duecentotrenta anni fa”.
Per concludere due sono le caratteristiche di un possibile, futuro, “Beijng consensus” per Arrighi:
1- La localizzazione, ovvero “il riconoscimento della necessità di tarare lo sviluppo sulla base delle necessità locali”,
2- Il multilateralismo, cioè “il riconoscimento dell’importanza della cooperazione tra stati”.
La speranza dell’ultimo libro che l’economista e sociologo milanese ci lascia è questa: che l’insieme di queste due caratteristiche possa aprire lo spazio ad una nuova Bandung[76] la quale metta fuori gioco le istituzioni finanziarie del Nord, offrendo condizioni migliori ai vari sud del mondo, e che ponga infine termine, anche se ci vorrà tempo, all’egemonia Usa.
Producendo un possibile Commonwealth futuro.
[1] - Giovanni Arrighi (1937, 2009)
[2] - La “teoria della dipendenza” negli anni sessanta domina il campo della critica anticapitalista di matrice marxista e che si muterà, incorporandosi, prima nella “teoria dei sistemi mondo” per poi dissolversi progressivamente. Il punto teorico è che le istituzioni ed i rapporti economici (ma anche quelli sociali e culturali, o politici) che si osservano nel mondo “centrale” e “sviluppato”, e quelli che si osservano nelle “periferie” e “sottosviluppate”, sono il prodotto le une delle altre in una dialettica che si sviluppa attraverso relazioni reciproche di dipendenza e conflitto nella reciproca connessione. I paesi più forti drenano ‘surplus potenziale’ (Baran, “Il surplus economico”, 1957) da quelli deboli e in questo modo determinano il loro sottosviluppo. In questo modo i primi si avvicinano al loro “potenziale”, mentre i secondi ne restano distanti. Come scriverà Andre Gunder Frank (in “Capitalismo e sottosviluppo in America latina”, 1967), l’accumulazione del capitale che avviene in questa forma è quindi nella sua essenza e di necessità ineguale. Questa struttura di accumulazione, che drena risorse verso la catena dei centri e la porta all’esterno dei paesi (per questo) sottosviluppati, “penetra come una catena il mondo sottosviluppato nella sua totalità, creando una struttura di sottosviluppo ‘interna’”. È questa la ragione per la quale nessuna posizione interclassista e nazionalista ha possibilità di avere successo nel superamento del sottosviluppo. Il sottosviluppo non è una questione esterna, ma è una intera struttura costitutiva delle soggettività e quindi degli assetti politici.
[3] - Andre Gunder Frank (1929, 2005)
[4] - Samir Amin (1931, 2018)
[5] - La “teoria dei sistemi mondo” è l’evoluzione da una parte della “Teoria della dipendenza”, dalla quale eredita l’idea che l’interconnessione tra i paesi procede attraverso le loro relazioni commerciali e gli scambi di capitale, relazioni funzionali, più marginalmente individui, ma lascia cadere la tattica della “disconnessione” e quindi della ricerca di indipendenza e sostituzione delle importazioni (anche di capitale), ovvero le varianti della linea Listiana. Trae ispirazione principale al lavoro di Ferdinand Braudel andando in effetti a sostituire la lettura di derivazione marxista connessa con la linea genealogica del pensiero antimperialista otto-novecentesco (in particolare Lenin). Questa, secondo la critica sviluppata rileggeva la relazione padrone/servo in un’ottica ancora connessa con il nazionalismo metodologico, per la quale si individuava una catena di principali/agenti funzionalmente connessi principalmente dalle relazioni commerciali, ovvero dagli scambi. Viene opposto un approccio che negli anni novanta si manifesta nel contesto del successo del globalismo e del paradigma della “storia globale” (Sebastian Conrad, “Storia globale”). Lo spostamento di scala, in qualche modo debitore sia del clima post-modernista sia dell’infatuazione per le ‘scienze della complessità’, parte da una critica appropriata dell’eurocentrismo ma è attraversato dal rischio di tradursi in una nuova versione di filosofia della storia sul modello moderno-lineare invalso in occidente sulla scorta della rivoluzione scientifica e la sistemazione newtoniana. L’eurocentrismo cacciato dalla porta potrebbe, insomma, rientrare dalla finestra. In questa direzione interviene la forte critica di Gunder Frank, a partire da “Re-Orient” anche se in buona misura risulta corretta dal libro in oggetto. Per la critica di Frank si veda “Per una storia orizzontale della globalizzazione”, parte seconda.
[6] - Immanuel Wallerstein (1930, 2019)
[7] - Giovanni Arrighi “Il lungo XX secolo”
[8] - Giovanni Arrighi, Beverly Silver, “Caos e governo del mondo”
[9] - Nel 1969 pubblica “Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa”.
[10] - Nel 1978, “La geometria dell’imperialismo: i limiti del paradigma hobsoniano”, e nel 1982, “Dinamiche della crisi mondiale”;
[11] - Arrighi, “Semiperipheal development: the politics of southern Europe in the twentieth century”, 1985, “Il capitalismo in un contesto ostile”.
[12] - Arrighi, “Antisystemic movement”, 1989
[13] - Adam Smith, “La ricchezza delle nazioni”, è stato completato nel 1776.
[14] - Adam Smith nasce a Kirkcaldy il 5 giugno 1723 e muore ad Edimburgo il 17 luglio 1790, studia filosofia sociale e morale all’università di Glasgow e poi a Oxford, dal 1751 è professore di logica e dall’anno successivo di filosofia morale a Glasgow. La sua prima opera importante è “Teoria dei sentimenti morali” (1759), seguita da “Lectures on justice, police, revenue and arms” (1763). Quindi la sistemazione del pensiero economico giunto fino a lui (fisiocratici e mercantilisti) e la proposta di una prospettiva di sintesi in “Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni”, nel 1776.
[15] - Domenico Losurdo, “Il marxismo occidentale”. Nel testo Losurdo indica una frattura fondamentale (naturalmente con qualche eccezione) tra due tradizioni del marxismo mondiale: quella occidentale e quella orientale. Poiché il marxismo in pratica ha sempre trionfato in paesi non imperialisti, non dominanti e centrali, e deboli oltre che periferici, si è sempre imposto il tema dell’indipendenza e della difesa dalle brame coloniali, ovvero la sopravvivenza. In occidente, invece, il capitalismo si è sviluppato sempre come pensiero critico e quindi il tema centrale è diventato l’antiautoritarismo in chiave di antinazionalismo e di attesa messianica e millenaristica di una finale dissoluzione dello stato. Mentre in occidente prevale lo spirito utopico, ad esempio espresso dall’auspicio blochiano della fine dell’economia del denaro, in oriente, si pone quello dello sviluppo economico e delle forze produttive, come indispensabile leva per poter difendere le conquiste sociali dall’aggressione concreta delle forze organizzate del capitale occidentale. Chi sostiene questa posizione, nel punto di passaggio è già Lenin, mentre Bloch esprime quest’auspicio della fine dell’economia mercantile nel 1918, o Walter Benjamin nel 1920. Il leader della rivoluzione russa sposta progressivamente il tiro, e sulla spinta della necessità ridefinisce la priorità dalla posizione della distruzione dello Stato (ai fini della sua ricostruzione) di “Stato e rivoluzione”, del 1917, con la NEP del 1921, in cui lo sviluppo economico di un paese ancora arretrato è diventato il tema cruciale. Nel 1923, nella famosissima “Lettera al Congresso”, un Lenin ormai morente scrive, infatti: “sarei pronto a dire che per noi il centro di gravità si sposta sul lavoro culturale, se non fossimo impediti dai rapporti internazionali, dall’obbligo di lottare per la nostra posizione su scala internazionale … davanti a noi si pongono due compiti fondamentali, che costituiscono un’epoca. Si tratta del compito di trasformare il nostro apparato statale, che proprio non vale nulla e che abbiamo ereditato al completo dall’epoca precedente”. E prosegue: “il nostro secondo compito consiste nel lavoro culturale fra i contadini. E questo lavoro ha come scopo economico appunto la cooperazione” (in questo riecheggiano i temi dell’ultimo Marx stesso). Ma, e questo è cruciale: “questa rivoluzione culturale comporta delle difficoltà incredibili, sia di carattere puramente culturale (poiché siamo analfabeti) che di carattere materiale (poiché per diventare colti è necessario un certo sviluppo dei mezzi materiali di produzione, è necessaria una certa base materiale”. Questa della “certa base materiale” è l’ultima parola della Lettera. L’ultimo lascito.
[16] - David Harvey, “Geografia del dominio”, Ombre Corte, 2018, p.67 [trad. parziale di “Space of capital: towards a Critical Geography”, 2001].
[17] - Andre Gunder Frank chiama “sviluppo del sottosviluppo” la relazione perversa tra centri e periferie per la quale lo sviluppo dei primi dipende e incentiva il sottosviluppo dei secondi. Questa tesi si sfumerà notevolmente nella teoria dei “sistemi-mondo” e sarà contrastata da altri autori marxisti “occidentali”, come Robert Brenner.
[18] - Arrighi lo descrive in questo modo, una metafora varata per descrivere spiegare quella vistosa divergenza [tra i paesi sviluppati e quelli in ritardo]. La divergenza sosteneva, altro non era che l’espressione di un processo di espansione capitalistica globale capace di generare allo stesso tempo sviluppo (ricchezza) al centro (Europa occidentale e poi America del Nord e Giappone) e sottosviluppo (povertà) nel resto del pianeta”. p.34
[19] - Robert Brenner, “The origin of capitalist development: a critique of neosmithian Marxism”, “New Left Review”, I/104, luglio 1977. Si veda anche “Reply to Sweezy”, NLR, I/108, marzo 1978, e Paul Sweezy, “Commento su Bremmer”, NRL i/108, marzo 1978. Ben Fine, “On the origin of capitalist development”, I/109, Maggio 1978, Alex Callinicos, “England’s transition to capitalism”, I/207, 1994.
[20]- Nel 1999 con “Re-Orient” Gunder Frank improvvisamente rompe con le premesse eurocentriche della “scuola dei sistemi-mondo” e tutti i suoi amici della “banda dei quattro” (Frank, Amin, Arrighi, Wallerstein). Arriva a sostenere che un “sistema mondo” è sempre esistito, almeno da seimila anni. Da allora cicli di sviluppo e crisi, trasportati dalle linee di commercio a lungo tragitto si sono susseguiti a livello planetario (con i necessari slittamenti). Ma anche l’accumulazione di capitale come principio di organizzazione delle leadership egemoniche e la dialettica centro/periferie sarebbe una caratteristica permanente. La civiltà occidentale non ha quindi alcuna specificità, non ci sono punti dai quali sarebbe partita, non ci sono demarcazioni, non c’è un eccezionalismo. Rispetto alle differenze conta più la continuità.
[21] - Che ad un certo punto arresta il circolo tra dimensione del mercato, divisione del lavoro e miglioramento economico, a causa dell’urto con limiti geografici, o istituzionali, insuperabili.
[22] - Titolo del libro di Kenneth Pomeranz, “La grande divergenza”, del 2000.
[23] - Bin Wong, “The role of the chinese state in long-distance commerce”, 1997
[24] - Andre Frank, “Re orient”, 1998. In questo libro avviene la svolta contro l’eurocentrismo delle teorie dominanti e l’abbandono dello schema della sostituzione delle importazioni.
[25] - Mentre in Cina abbondano i lavoratori e scarseggia in senso relativo il capitale, in Europa è l’opposto.
[26] - Pomeranz, cit.
[27] - Cfr. Tzvetan Todorov, “La conquista dell’America”, 1984. In particolare il tema del diverso sguardo che gli occidentali esercitano sul mondo e sull’uomo.
[28]- Karou Sugihara, “The european miracle and the east asian miracle towards a new global economic history, ‘Sangyo to keizal’”, 2003
[29] - Questo è un punto che diventa recentemente controverso, per citare un recente studio su Marx di Marcello Musto: “Con continuità, dunque, dalle prime formulazioni della concezione materialistica della storia, risalente agli anni ‘40, fino agli ultimi interventi degli anni Ottanta, Marx mise in evidenza la relazione esistente tra il ruolo fondamentale dell’incremento produttivo generato dal modo di produzione capitalistico, e le precondizioni necessarie alla nascita della società comunista per la quale il movimento operaio avrebbe dovuto lottare. Le ricerche condotte negli ultimi anni della sua esistenza gli permisero, però, di rivedere questa convinzione e di evitare di cadere nell’economicismo che contraddistinse invece le analisi di tanti suoi seguaci” (Marcello Musto, “Karl Marx”, 2018, p.219). La transizione attraverso la via del capitalismo (separazione dai mezzi di produzione, proletarizzazione, industrialismo e divisione del lavoro tra salariati e capitalisti) con la conseguenza politica della centralità della classe generata dal capitalismo, quella operaia, connessa intimamente con il centro della produzione (con il suo “laboratorio”) nella trasformazione in società socialista, è messa in crisi, se pur per abbozzi, dal confronto con il caso Russo. Per l’ultimo Marx, come per Engels, la Russia è la probabile frontiera della trasformazione, il luogo dei più acuti conflitti e contraddizioni, un coacervo del più retrivo feudalesimo con le forme più spregiudicate di finanza e la nascente borghesia, ma anche ancora una nazione vastissima e contadina. Osservandola (Marx impara addirittura verso i sessanta anni il russo, per studiare il dibattito in corso tra “populisti” e “marxisti”) prende in considerazione l’ipotesi che la transizione attraverso la proletarizzazione non sia “sempre necessaria”, e che sia meramente un fenomeno storico, non un modello astorico. Si veda anche Marcello Musto “L’ultimo Marx”, ed il post “Karl Marx, la comune rurale e la questione russa”.
[30] - Karl Polanyi, “La grande trasformazione”, 1944.
[31] - La caduta del saggio di profitto è una delle “leggi” più centrali e controverse della economia classica. In Marx bisogna partire dal fatto che l’accumulazione dipende (come il profitto) dalla progressiva meccanizzazione del processo produttivo, però, ciò implica che la produttività del lavoro cresce continuamente nel capitalismo. Con essa cresce quella che Marx chiama la “composizione organica del capitale”. In temini di formule: P = s’ (1 – q)
Con un saggio del plusvalore costante si determina la conseguenza che il saggio di profitto finisce per variare in ragione inversa della composizione organica del capitale, e quindi “se q aumenta, allora p deve diminuire”. Questa è la tendenza alla caduta del saggio di profitto.
[32] - Si veda, ad esempio, la prefazione di Engels, del 1888, a “Dazio protettivo e libero scambio”, di Marx (conferenza del 1848).
[33] - Scrive nel Manifesto del Partito Comunista: “i tenui prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con cui essa [la borghesia] abbatte tutte le muraglie cinesi”. In effetti però ci volle proprio l’artiglieria non metaforica.
[34] - Friedrich Engels, “La situazione della classe operaia in Inghilterra”, 1844
[35] - Hosea Jaffe (1921, 2014) è stato uno storico e scrittore sudafricano noto per tesi molto aspre contro l’eurocentrismo degli studi economici e storici. Abbiamo letto, ad esempio, “Era necessario il capitalismo?” del 2008, in esso si scaglia contro Engels ed in parte Marx mettendo in evidenza le tesi eurocentriche e l’interpretazione del capitalismo come fase necessaria di passaggio verso il socialismo. La sua tesi è che il capitalismo è regressivo ed ha prodotto danni ingenti ovunque è stato applicato in quanto si è sempre sviluppato insieme al colonialismo, che è ad esso strutturalmente necessario. La questione è, in altre parole, se la dissoluzione dei modi di produzione ‘comunitari’, più o meno dispotici, e ‘tributari’ (possono anche esserci entrambi contemporaneamente) sia stato un progresso.
[36] - Ferdinand Braudel, “Afterhoughts on material civilization and capitalism”, 1977, p. 64
[37] - Domenico Losurdo, “Il marxismo occidentale”, 2017.
[38] - Per avere un’idea di questo punto, che naturalmente merita ben più elevato approfondimento, può essere utile rileggere alcuni articoli dei Monthly Review, raccolti nel 1968 nel libro di Leo Huberman e Paul Sweezy “La controrivoluzione globale” che per lo più si confronta con il movimento di liberazione delle minoranze nere.
[39] - Il punto teorico è analizzato in particolare nella principale opera della scuola americana, l’ultima di Paul Baran, “Il capitale monopolistico”, scritto nel 1967 con Paul Sweezy. In esso viene formulato una sorta di “teorema di impossibilità” nella fase monopolistica del capitalismo. La rivoluzione sistemica nelle società del centro capitalistico (monopolista) maturo non avviene dove si aspetta; questo ha, infatti, una immensa capacità di coinvolgimento ed egemonica, ma anche, e nella stessa logica produce una capacità di mobilitazione alle periferie, che di necessità ne devono pagare il prezzo. Lo schema della rivoluzione al culmine dello sviluppo delle forze produttive ne viene rovesciato: le condizioni dell’instabilità sistemica del capitalismo non si danno al centro, ma nelle sue periferie interconnesse e vitali per la sua sopravvivenza, nel senso specifico che senza l’estrazione di ‘surplus potenziale’ da queste esso resta condannato alla tendenza alla stagnazione e quindi non è in grado di riprodurre il consenso al suo interno. Questa forma di capitalismo, diretta e controllata dalle grandi imprese per azioni monopoliste e multinazionali, è quindi strutturalmente imperiale e organizzato di necessità per grandi catene di sfruttamento internazionali. Catene che determinano l’estrazione di valore e la contrapposizione tra la massima opulenza e la massima disperazione, entro e fuori le cittadelle assediate delle metropoli occidentali.
[40] - Ad esempio si legga questo famoso passo: “la produzione basata sul capitale crea da una parte l’industria universale, […] dall’altra crea un sistema di sfruttamento generale delle qualità naturali ed umane, un sistema della utilità generale, il cui supporto è tanto la scienza quanto tutte le qualità fisiche e spirituali, mentre nulla di più elevato-in-sé, di giustificato di per se stesso, si presenta al fi fuori di questo circolo della produzione sociale e dello scambio. … soltanto col capitale la natura diventa un puro oggetto per l’uomo, una pura cosa di utilità, e cessa di essere riconosciuta come forza per se; e la conoscenza teoretica delle sue leggi autonome si presenta soltanto come astuzia per subordinarla ai bisogni umani, sia come oggetto di consumo, sia come mezzo di produzione. In virtù di questa sua tendenza il capitale spinge a superare sia le barriere e i pregiudizi nazionali sia l’idolatria della natura e la soddisfazione tradizionale, orgogliosamente ristretta entro determinati limiti, dei bisogni esistenti, e la riproduzione del vecchio modo di vivere. Nei riguardi di tutto questo il capitale opera distruttivamente, opera una rivoluzione permanente, abbatte tutti gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle forze produttive, la dilatazione dei bisogni, la varietà della produzione e lo sfruttamento e lo scambio delle forze della natura e dello spirito” (K. Marx, “Grundisse”, p.11)
[41] - Ad esempio può essere ricordata la discussione tra Lenin e Kautsky sulla “dittatura del proletariato”, come necessità (la repressione della borghesia da parte degli operai in armi e le loro organizzazioni), dato lo sviluppo insufficiente delle forze produttive, e/o la necessità di passare per una fase ‘borghese’. Questa discussione, tra un modello rigido di progresso storico del socialismo (difeso da Kautsky) e un modello che, a ben vedere, sposta il focus sulla indipendenza e la lotta antimperialista (di Lenin), animerà successivamente tutto il movimento socialista. Ad esempio il dibattito Stalin-Trotsky e la questione della decolonizzazione nel dopoguerra. Quindi c’è la questione della estinzione dello Stato. In “Stato e rivoluzione”, Lenin più o meno dice che il comunismo pienamente dispiegato, discutendo della “Critica al programma di Gotha”, comporterà la dissoluzione dello Stato ed il controllo spontaneo delle deviazioni tramite il controllo sociale dei lavoratori (“in armi”). Ma, nella fase intermedia, “che sarà molto lunga”, lo Stato è necessario, insieme alla dittatura del proletariato, per impedire che i pochi opprimano i molti. Lo Stato, come macchina di repressione dovrà quindi funzionare, ma per i molti contro i pochi. A questo testo, ed alla prassi conseguente nel “comunismo di guerra” Kautsky, in “La dittatura del proletariato”, 1918, risponde intanto che il partito bolscevico in effetti governa “contro altri partiti socialisti”, quindi individua la divergenza nello scontro tra “il metodo democratico ed il metodo dittatoriale”. La questione che pone il leader della socialdemocrazia tedesca (poi avremo tragiche conseguenze nel momento in cui a gennaio 1919 scoppierà, in risposta alle richieste pressanti sovietiche, la “rivolta spartachista”, nella quale la parte di socialdemocrazia al governo risponderà con una feroce repressione che costerà la vita a Rosa Luxemburg) è che “il nostro scopo finale, compreso con esattezza, non è il socialismo, ma consiste nella abolizione di ogni forma di sfruttamento e oppressione sia essa diretta contro una classe, un partito, una nazione, una razza (programma di Erfurt)” (adottato nel 1891), p.25. Anche la “forma socialista di produzione”, è quindi indicata come mezzo e non fine, come dice “se ci si dimostrasse che in ciò sbagliamo, che la liberazione del proletariato e dell’umanità in genere si può raggiungere unicamente o nel modo più opportuno sulla base della proprietà privata dei mezzi di produzione come ancora riteneva Proudhon, dovremmo rifiutare il socialismo, senza minimamente rinunciare alla nostra meta finale, ma appunto nell’interesse di questa”. In conseguenza non si può pensare al socialismo senza la democrazia. “Per socialismo moderno noi intendiamo non soltanto un’organizzazione sociale della produzione, ma anche un’organizzazione democratica della società”. Non proseguo nell’analisi di un testo davvero importante e che meriterebbe una lettura organica. A questo, come noto Lenin risponde con il violentissimo “La rivoluzione proletaria ed il rinnegato Kautsky”, nel quale riconduce il discorso del primo al liberalismo, per lui “il ‘contrasto fondamentale’ tra ‘il metodo democratico e il metodo dittatoriale’ è il nocciolo della questione. E’ l’essenza dell’opuscolo di Kaustky. Ed è una confusione teorica così mostruosa, un’abiura del marxismo così completa, che deve convenirsi aver Kautsky di molto sorpassato Bernstein”. In sostanza accusa il tedesco di essere antistorico, e di guardare scolasticamente a tempi ormai passati (il XIX secolo). E di “guardare la cosa dal punto di vista di un liberale, cioè come questione di democrazia in generale e non di democrazia borghese”. La questione è che “un marxista non dimentica mai di porre la domanda: [democrazia] per quale classe?” (p.35) e quindi questi “ha dimenticato la lotta di classe”. Ora, la semplice verità è che, in Marx, per Lenin, “la dittatura è un potere che si appoggia direttamente sulla violenza, non vincolato da alcuna legge. La dittatura rivoluzionaria del proletariato è un potere conquistato e sostenuto dalla violenza del proletariato contro la borghesia, un potere non vincolato da alcuna legge”. Ma qui, per capire queste dure parole, siamo nel novembre 1918. Il nocciolo della questione (p.40) è dunque “la violenza”.
[42] - Una nozione altamente complessa e dai molti significati, che tuttavia ai fini del nostro discorso tende a cadere sotto la critica che le rivolse Walter Benjamin nelle “Tesi sulla storia”, (13° tesi): ““la teoria socialdemocratica, e più ancora la prassi, era determinata da un concetto di progresso che non si atteneva alla realtà, ma presentava un’istanza dogmatica. Il progresso, come si delineava nel pensiero dei socialdemocratici, era, innanzitutto un progresso dell’umanità stessa (e non solo delle sue capacità e conoscenze). Era, in secondo luogo, un progresso interminabile (corrispondente ad una perfettibilità infinita dell’umanità). Ed era, in terzo luogo, essenzialmente incessante (tale da percorrere spontaneamente una linea retta o spirale). Ciascuno di questi predicati è controverso, e da ciascuno potrebbe prendere le mosse la critica. Ma essa, se si vuol fare sul serio, deve risalire oltre questi predicati e rivolgersi a qualcosa di comune a essi tutti. La concezione di un progresso del genere umano nella storia è inseparabile da quella del processo della storia stessa come percorrente un tempo omogeneo e vuoto. La critica dell’idea di questo processo deve costituire la base della critica dell’idea del progresso come tale”
Il tempo della storia, invece, non è il tempo astratto e vuoto della valorizzazione, ovvero il tempo in ultima analisi del capitale che, trascinando davanti a sé lo sviluppo tecnologico in direzione della massima autovalorizzazione e continuamente dissolvendo gli ostacoli, si produce attraverso di esso; ma è il tempo, dice nella 14° tesi, “quello pieno di ‘attualità’”. Ovvero è il tempo di ciò che si fa attuale (ad esempio la Roma antica durante la rivoluzione francese per Robespierre). Si arriva a dire che (15° tesi) “la coscienza di far saltare il continuum della storia è propria delle classi rivoluzionarie nell’attimo della loro azione”, infatti dalla “selva del passato”, nell’area in cui comanda la ‘classe dominante’ (diremmo in cui si esercita la sua egemonia che la fa dominante), il balzo di tigre che attualizza un ‘passato’, rendendolo nuovamente presente, fa sì che si possa restare “signore delle proprie forze” (In “Angelus novus”, p.83 e seg.). Emerge la concezione di una sorta di tempo granulare e discontinuo, in cui l’atto che costituisce potere (e quindi valore) diventa la scelta di cosa considerare contemporaneo, cosa attuale. Un tempo, quindi, politico.
[43] - Si tratta di una questione davvero difficile, la tesi riportata deriva in sostanza dalla proposta di Braudel. Naturalmente non si intende il “mercato” come la circolazione delle “merci” nel senso descritto da Marx perché questa presuppone i rapporti di produzione del capitalismo. Andiamo a Braudel, in particolare “La dinamica del capitalismo”, 1977, che riassume i concetti di “Civiltà materiale”, 1979: il “capitalismo” (ma sta parlando di quello preindustriale) vi viene individuato come sistema economico avverso al “mercato”. Il “capitalismo” si può costruire solo con il supporto dello Stato, il fenomeno è interpretato come effetto di una sorta di gioco di strategia in cui diversi poteri sfruttano le condizioni e le istituzioni del tempo per consolidare un predominio avverso alla grande maggioranza, inclusi i nuclei e frammenti di mercato e gli imprenditori in essi operanti. Questa lettura inquadra, insomma, il fenomeno cui si dà nome “capitalismo” distinguendolo, ed in qualche modo opponendolo, sia alla divisione del lavoro (lettura di Adam Smith) sia ad ethos culturali e religiosi (Max Weber). In questo libro, la cui lettura dovremo rimandare, le “socioeconomie” sono insomma influenzate sia da “chi possiede i mezzi di produzione, la terra, le navi, le materie prime, i prodotti finiti e le posizioni dominanti” (come sottolineava Marx che qui è citato), sia dallo Stato, che è “causa e conseguenza insieme” e turba, piegando anche involontariamente, i rapporti. diversa lettura del “capitalismo”, che vede addensarsi a partire dal 1200 e che non è letto, secondo la tradizione che risale a Smith, e non viene seriamente contestata neppure da Marx, come un fenomeno connesso con la concorrenza, la divisione del lavoro e la razionalizzazione, che è pervertito tardivamente da colonialismo e imperialismo (in Marx e nei suoi successori), deformato dai monopoli. Come abbiamo visto il “capitalismo” scaturisce dal commercio internazionale, di lunga percorrenza, e dalle lunghe catene di scambi in cui il medium “denaro” può esplicare la propria logica ed è quindi, dall’inizio, internazionale, volto a creare e sfruttare privilegi facendo leva sulla mobilità, scaturente dal monopolio. Parassitario di rapporti sociali locali e poteri politici nazionali (dei nascenti Stati o delle autorità semifeudali esistenti). Esso crea e rende possibili le “economie-mondo” (la cui lettura è una delle marche di Braudel e della sua scuola i cui continuatori sono Wallerstein e Arrighi), imponendo strutture piramidali e canalizzando in luoghi densi e privilegiati (le “città globali” di cui parla Saskia Sassen) i loro affari d’ordine e sfruttando quelle diventate marginali (qui si può andare a “Espulsioni, brutalità e complessità nell’economia globale”). Il capitale si forma e si sposta, si organizza intorno a centri in cui operano infrastrutture di servizio e reti di competenza, prima emergono in questa veste centri come Firenze, Milano, Venezia e Genova, poi nello scorrere dei decenni Anversa, Amsterdam e quindi Londra, infine New York fuori del perimetro temporale della ricerca.
Per Braudel, diamogli la parola: “la caratteristica fondamentale dell’economia preindustriale è la coesistenza delle rigidità, inerzie e lentezze di un’economia ancora elementare coi movimenti limitati e minoritari, benché vivi ed incisivi, caratteristici della crescita moderna. Da un lato, contadini che vivono nei loro villaggi e sviluppano forme autonome, quasi autarchiche di economia, dall’altra un’economia di mercato ed un capitalismo in espansione che, estendendosi a macchia d’olio, tracciano, a poco a poco, la configurazione del mondo in cui viviamo. Due universi, dunque, due generi di vita apparentemente estranei ma le cui masse rispettivamente rimandano tuttavia l’una all’altra” (p.26).
“L’economia di mercato” nella tradizione storiografica che, appunto, risale alla sistemazione prodotta nell’ultimo quarto del settecento da Adam Smith, è la presenza che assorbe il nostro campo visivo, ma per Braudel essa “non è che un frammento di un più vasto insieme, a causa della sua stessa natura che la riduce a giocare il ruolo di semplice area di collegamento tra produzione e consumo: fino al XIX secolo, l’economia di mercato costituisce soltanto un livello più o meno consolidato e resistente, talora una sottile intercapedine, tra l’oceano della vita quotidiana che si estende sotto di essa ed i movimenti del gioco capitalistico che, più d’una volta, la manovrano dall’alto” (p.49).
Tuttavia questa presenza ubiqua, che connette e collega aree diverse, e nella quale rifornimenti, prezzi, flussi, produzioni, sono messi in contatto, a volte manipolati, influenzati, fatti oggetto delle prime “politiche economiche”, protetti o sfidati, osservati e razionalizzati, appare ai contemporanei come il vero elemento decisivo. L’equilibratore, fondato sul meccanismo che appare agli occhi della “concorrenza”, che riesce di superare i dislivelli. Le carenze dell’offerta, quelle della produzione, della domanda. “Il mercato diventa così un dio nascosto e benevolo, la <mano invisibile> di Adam Smith, il mercato autoregolato del XIX secolo, chiave di volta dell’economia per tutto il periodo in cui ci si è attenuti al principio del laisser faire, laisser passer”. Che ne pensa Braudel? Lo dice subito, “in tutto questo c’è, senza dubbio, una parte di verità, una parte di malafede, ma anche di illusione”. Intanto il mercato è manipolato, alterato, dal potere politico, dai monopoli, poi questo è incompleto ed imperfetto come legame tra produzione e consumo. Braudel tiene “a sottolineare la parola incompleto”, e continua: “mentre credo nelle virtù e nell’importanza dell’economia di mercato, ciò che non mi convince è la sua funzione di fattore assoluto, esclusivo”. Questo è semplicemente “un mito”.
Oltre a questa cosa c’è? Intanto, ovviamente, le strutture del quotidiano, della vita materiale, ma anche “il capitalismo”. Braudel lo dice chiaramente, il termine è scelto per avere una diversa etichetta che si distingua dall’economia di mercato. Si tratta di “forme di attività molto differenti”. È chiaro che si tratta di un termine ambiguo e pericoloso; lanciato (anzi, come dice prudentemente, oggetto “del suo primo vero <lancio>” nell’opera maggiore di Sombart nel 1902) è “praticamente ignorato da Marx” e viene connesso normalmente alla rivoluzione industriale. Ma questa è contaminata dal passato, si stava delineando da tempo, da molto prima del XVIII secolo. Questo, il “capitalismo” è dunque “in linea di massima … il modo in cui è gestito, con finalità generalmente poco altruistiche il gioco della costante immissione” del capitale nel processo di produzione. Dove “capitale” non è solo il denaro, ma anche i beni o le infrastrutture (le case) o la natura (ad esempio le foreste) nel momento in cui sono sfruttati e partecipano al processo di produzione.
[44] - Ovvero i tre libri sulla ricostruzione del ciclo del capitalismo che abbiamo citato.
[45] - Nella controversia tra Bernstein e Kautsky, alla quale partecipò anche una giovane ma già determinata Rosa Luxemburg si attiva la divaricazione tra posizioni riformiste-compatibiliste e posizioni rivoluzione-crolliste. Per come la mette Luxemburg, “o la trasformazione socialista continua ad essere una conseguenza delle contraddizioni obiettive del sistema capitalistico, allora insieme a questo sistema si sviluppano anche le sue contraddizioni, e un crollo, in questa o in quella forma, a un certo momento, ne è il risultato; ma allora anche i ‘mezzi di adattamento’ [Bernstein] sono inefficaci e la teoria del crollo è giusta. Oppure i ‘mezzi di adattamento’ sono in realtà tali da impedire un crollo del sistema capitalistico, rendono quindi il capitalismo in grado di esistere, sopprimono le sue contraddizioni; ma allora il socialismo cessa di essere una necessità storica, e sarà tutto quel che si vuole tranne che un risultato dello sviluppo materiale della società. Questo dilemma conduce ad un altro dilemma: o Bernstein ha ragione per quanto riguarda il corso dello sviluppo capitalistico, e allora la trasformazione socialista della società si muta in un’utopia, oppure il socialismo non è un’utopia e allora la teoria dei ‘mezzi di adattamento’ non deve essere valida. That is the question, questo è il problema”, Rosa Luxemburg, “Newe Zeit”, 1896.
[46] - Robert Brenner, “The economics of global turbulence”, New Left Review, I/229 maggio 1998
[47] - Fu allora, sul finire del giorno, che Nixon disse “adesso siamo diventati tutti keynesiani”.
[48] - Si veda, “Francoise Mitterrand e le svolte degli anni ottanta”.
[49]- Robert Brenner, “The economics of global turbolence. The advanced capitalist economics from long book to long downturn”, 2002
[50] - Si veda Massimo d’Angelillo, “La Germania e la crisi europea”, la politica di Brandt, l’unica fase keynesiana della storia tedesca (nella quale politiche di crescita vengono portate avanti ‘dal lato della domanda’) si interrompe quando nel 1974 l’economia che era fino all’anno prima in piena occupazione (tasso di disoccupazione 0,6%) rallenta bruscamente, cresce solo dello 0,6% (anno prima +4,3%), e, inoltre, una opaca operazione di spie lo coinvolge in uno scandalo che porta il cancelliere alle dimissioni a maggio 1974, gli succede Helmut Schmidt che abbandona il keynesismo per puntare sul “modell Deutschland”, che cerca di fare della Germania il perno dei flussi finanziari internazionali, fondata su un marco “forte” e la compressione della domanda interna per favorire le esportazioni.
[51] - Tra “base” (termine che viene usato per “struttura” da Marx, nell’”Ideologia tedesca”, infatti userà struktur e basis) e la “soprastruttura” (uberbau, tutte metafore architettoniche come si vede, si tratta di ciò che è edificato sopra e del fondamento), in una condizione nella quale evidentemente ci vogliono entrambe, c’è una relazione molto più stretta di quella, pur complessa, della vulgata marxista. Il concetto di egemonia è per espressa ammissione, ripreso da Gramsci (che lo rileva da Lenin, ma lo estende molto) che lo impernia in una critica della vulgata marxista del rapporto tra “struttura” e “soprastruttura” nella loro reciproca influenza. I due concetti sono una unità, in senso dialettico. Ma avviene in qualche modo in Gramsci, nell’intreccio di concetti che si rimandano, un passaggio che è colto molto più da Arrighi che da Negri: la struttura, la base, è in un rapporto con la soprastruttura che ad essa si innerva e intreccia, quasi confondendosi, in un modo che ricorda quello tra storia ed evento. Cioè quel rapporto, nella lettura storica che Gramsci compie in tutta la sua opera, tra passato e presente. Affondare le radici nella storia, che è la stessa mossa nell’interpretazione del presente che compie la tradizione degli Annales (forse non a caso avviata nel ’29 e a conoscenza del nostro), significa per Gramsci liberarsi di ogni trascendenza residuale, di ogni teologia. Il concetto compare nei primi mesi del 1930, nei Quaderni del Carcere, e precisamente nell’ambito del discorso sul risorgimento (che abbiamo letto per ora qui) e resta praticato fino alla fine, ogni volta con una qualificazione: politica, culturale, linguistica, intellettuale, morale, … l’egemonia è in qualche modo, proverei a dire, uno strumento ed un effetto, che opera nel garantire e realizzare la prevalenza di uno verso l’altro. Sia esso una classe, o un blocco storico, una nazione (come del caso). Il concetto, per essere compreso, va connesso con la sua assenza, ovvero con il puro e semplice “dominio”. Dove il potere è nudo, privo della necessaria componente del consenso, si ha quindi solo l’esercizio brutale del “dominio”. Ma il vero potere non si limita alla costrizione; si estende alle menti ed ai cuori, si fa seguire in qualche modo volontariamente, coinvolgendo insieme: la rappresentazione di sé che si costruisce, l’immagine del mondo, e la meccanica dei valori e obiettivi, con la loro gerarchia. Si radica inoltre nella “base” degli interessi, e dei bisogni, cui in qualche modo (secondo il filtro delle rappresentazioni) l’egemone risponde, facendosene almeno in parte carico. Il vero potere è dunque egemonia. Abbiamo, ad esempio egemonia tedesca in Italia, quando volontariamente si sceglie di seguire la logica della moneta stabile e forte, della deflazione come orizzonte, dell’austerità suo mezzo. L’egemonia ha sempre un suo campo e, per chi vi appartiene, un coerente insieme di desideri, effetti di dominio (verso qualche subalterno) inseparabili da effetti identitari, e sempre risponde almeno a parte ai suoi interessi e bisogni secondo la loro percezione.
Dunque le potenze realmente egemoniche, come sono state quella olandese, inglese e americana al loro meglio, quando si sono fatte carico, anche se diversamente, di produrre e distribuire beni pubblici e senso, o come la Russia sovietica, che esportava una egemonia potente, hanno riorganizzato in parte per effetto della loro base di potere, ma in parte altrettanto importante (e inseparabile) per effetto della loro struttura di valori, rappresentazioni coerenti, tecniche e regole, intorno a sé porzioni decisive del mondo, rendendolo “sistema”. Cioè rendendolo capace di funzionare insieme e creare le premesse per una accumulazione che ha anche disciplinato, in qualche modo, i capitali incorporati entro le loro strutture e quelli mobili (che fin che dura l’egemonia sono limitati). I capitali sono, infatti, una sorta di rapporto sociale.
[52] - La divisione della potenza doveva vedere in sostanza tre poli industriali dominanti nel campo occidentale (Usa, Germania e Giappone) e uno nel campo sovietico (Urss). Poi, a completare si potrebbe citare i poli secondari e subalterni (Italia, Francia e nel campo socialista la Germania dell’Est) e quelli declinanti (Inghilterra).
[53] - Si veda, ad esempio, questa altra descrizione della crisi in Massimo Amato e Luca Fantacci “Fine della finanza”.
[54] - Si veda “Gig economy o sharing economy?” e “Amazon e il suo monopolio”. Quando Walmart apre un nuovo punto di vendita nel territorio le reti di commercio di prossimità, anche le più forti ed organizzate, cedono, non riuscendo a stabilire con i fornitori la stessa relazione di potere schiacciante. La grande catena nata pochi anni fa da un solo punto vendita nello stato di Bill Clinton e divenuta una delle multinazionali più grandi al mondo, di cui abbiamo molte volte parlato (ad esempio qui), basa il suo potere nell’unione perfetta di un monopsonio (di fatto diventa, per la sua grandezza l’unico possibile acquirente per i suoi fornitori) e di un monopolio (con i suoi prezzi diventa l’unico a vendere su un territorio), che si fondano letteralmente l’uno sull’altro, e nel farlo devasta insieme la rete del piccolo commercio, desertificando le città, e il mercato del lavoro, verso il quale il monopsonio si estende. Se si ha la sfortuna di essere un lavoratore debole in un territorio nel quale c’è uno dei giganti di WalMart, si può scegliere tra essere senza lavoro ed esserne schiavo. Qualcuno potrebbe dire, a questo punto, che è il capitalismo. In effetti lo è; il capitalismo è una forma di organizzazione sociale per sua natura predatoria. La famiglia Walton, che lo ha fondato nel 1962, ed ora è più ricca di 100 milioni di americani con i suoi oltre 80 miliardi di dollari di patrimonio, ha solo applicato il modello. Man mano che il lavoro si è indebolito, a partire dalla rivoluzione reaganiana, un modello che mobilita capacità rese sottoutilizzate dal crollo delle agenzie che proteggevano il lavoro dallo strapotere del capitale ed al contempo offre alle stesse popolazioni marginali riduzioni di costo (ottenute dallo sfruttamento selvaggio della debolezza di lavoratori e fornitori), si è fatto progressivo ed irresistibile. Più si allarga lo strato di lavoratori impoveriti, più una catena che offre salari di stretta sussistenza per vendere prodotti a basso prezzo (e qualità), strangolando i fornitori e costringendoli a loro volta ad abbassare i salari, è in vantaggio. La competizione come unico criterio legittimo, essenza dello spirito del capitalismo, alla fine porta alla concentrazione nelle stesse mani delle due forme interrelate di monopolio.
[55] - Si veda, Paul Baran, Paul Sweezy, “Il capitale monopolistico”
[56] - Al momento si stima che il 64% delle riserve valutarie mondiali siano detenute in dollari, il 26% in euro, il 4% in sterline e il 3,3% in yen. Di quelle in dollari 3.700 miliardi sono detenuti dalla Cina, 1.200 dal Giappone, solo 430 complessivamente dall’eurozona e 400 dalla Russia (che ne sta vendendo il 10%), seguono Taiwan (300), Brasile (250), India (250), Corea del Sud (200), Hong Kong (180), Singapore (165). Insomma il sud-est asiatico nel suo complesso ne detiene 6.200 miliardi, i principali paesi del resto del mondo 1.000.
[57] - Si veda “Sviluppi della teoria della dipendenza”.
[58] - Si veda, Domenico Losurdo, “Il marxismo occidentale”, 2018.
[59] - Come abbiamo visto nella Parte Seconda, qui è d’obbligo riferirsi alla principale opera della scuola americana, l’ultima di Paul Baran, “Il capitale monopolistico”, scritto nel 1967 con Paul Sweezy. In esso viene formulato una sorta di “teorema di impossibilità” nella fase monopolistica del capitalismo. La rivoluzione sistemica nelle società del centro capitalistico (monopolista) maturo non avviene dove si aspetta; questo ha, infatti, una immensa capacità di coinvolgimento ed egemonica, ma anche, e nella stessa logica produce una capacità di mobilitazione alle periferie, che di necessità ne devono pagare il prezzo. Lo schema della rivoluzione al culmine dello sviluppo delle forze produttive ne viene rovesciato: le condizioni dell’instabilità sistemica del capitalismo non si danno al centro, ma nelle sue periferie interconnesse e vitali per la sua sopravvivenza, nel senso specifico che senza l’estrazione di ‘surplus potenziale’ da queste esso resta condannato alla tendenza alla stagnazione e quindi non è in grado di riprodurre il consenso al suo interno. Questa forma di capitalismo, diretta e controllata dalle grandi imprese per azioni monopoliste e multinazionali, è quindi strutturalmente imperiale e organizzato di necessità per grandi catene di sfruttamento internazionali. Catene che determinano l’estrazione di valore e la contrapposizione tra la massima opulenza e la massima disperazione, entro e fuori le cittadelle assediate delle metropoli occidentali.
[60] - David Harvey, “The new imperialism”, 2003
[61] - Henry Lefebvre, “Spazio e politica”, 1974,
[62] - Questa, almeno, è la tesi unanime della “teoria della dipendenza”, conservata nel tempo almeno da Samir Amin.
[63] - Si veda la classica analisi di Wolfgang Streeck, “Tempo guadagnato”, 2013.
[64] - Thomas Frank, “What’s the matter with Kansas? How the conservative won the heart America”, Owl Books, 2005.
[65] - Si tratta di un effetto largamente studiato. Si veda Andrew Spannaus, “La rivolta degli elettori”, 2017.
[66] - La campagna di Trump è per molti versi sorprendente, si veda ad esempio: George Lakoff “Nessuno sa perché Trump sta vincendo. La risposta delle scienze cognitive”, o “Donald Trump, Barac Obama, “Discorsi di insediamento”.
[67] - Il “reshoring” è un fenomeno strettamente economico e designa il rientro in patria delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato la produzione. In genere si tratta di aziende collocate nei segmenti alti del prodotto che vogliono ulteriormente valorizzare il proprio marchio, ma influiscono fattori come il costo dei trasporti, connessi con i prodotti energetici (e la loro volatilità), la necessità di avere linee di produzione più moderne e flessibili, e il fatto che nei paesi di primo esodo (incluso la Cina) i salari si avvicinano a quelli occidentali (che per lo più, al contrario, scendono). In Italia il fenomeno riguarda soprattutto aziende della moda e dell’elettronica-elettrotecnica.
[68] - Questa differenza dipende probabilmente dalla ricchezza e forza relativa e dalle masse in campo tra i paesi europei, sempre in equilibrio instabile tra di loro e soggetti a continui giochi triangolari, e la situazione del sud-est asiatico nel quale un grande e ricco centro si trova circondato da stati antichi, singolarmente molto meno forti ma in grado, come una muta di cani nei confronti di un leone, di fare seri danni se coalizzati. La strategia meno costosa potrebbe essere stata in questo contesto di pagare e corrompere, poi le pratiche diventano tradizione, e le tradizioni diventano cultura.
[69] - Questa è poi una delle tesi essenziali di tutta la scuola, e di un’ampia corrente storiografica che continua a lavorare in questa direzione. Comunque c’è una essenziale dissimmetria di lunga durata negli scambi tra il sistema europeo e quello orientale, e dura fin tutto l’ottocento: in sostanza le merci vanno dall’oriente all’occidente, mentre dall’occidente all’oriente vanno per lo più metalli preziosi. La soluzione inglese, il famoso “commercio triangolare” basato sulla conquista dell’India, è uno dei fattori decisivi (insieme all’altro “triangolo” atlantico) per l’egemonia inglese ed europea.
[70] - La letteratura citata in questa parte è essenzialmente cinese, si tratta di Jung-pang Lo, “Marittime commerce and its relation to the Sung Navy”, 1969, Po-kueng Hui, “Overseas chinese business networks: east asian economic development in historical prospective”, 1995, Lien-sheng Yang, “Money and credit in China. A short history”, 1952, Luquan Guan, “Songdai guangzhou de haiwai maoyi”, 1994, Yoshinobu Shiba, “song foreign trade: its scope and organization”, 1983, ma anche occidentale, Francesca Bray, “The rice economies: thecnology and development in asian societies”, 1986, Mark Elvin, “The pattern of the chinese past”, 1973, Ravi Palat, “Historical transformation in agranian system based on wet-rice coltivation: toward an alternative model of social change” 1995.
[71] - La fonte di questa informazione è cinese, si tratta di Gao Weinong, “Zou xiang jistsi de Zhongguo yu ‘chaogong’ guo guanxi”, 1993
[72] - Chase-Dunn, Hall, “Rise and demise: comparing word-system”, 1997
[73] - Ferdinand Braudel, “Civiltà materiale, economia e capitalismo”, 1982
[74] - Bin Wong, “China trasformed. Historical change and the limits of european experience”, 1997, p.146
[75] - Hosea Jaffe, in “Era necessario il capitalismo?” ricorda l’articolo che Marx scrisse per il “New York Tribune” nel 1853 sulla “rivoluzione in Cina ed in Europa”. In esso prevedeva che “le prossime insorgenze dei popoli europei e il loro movimento per la libertà repubblicana e un’economia di governo dipendono probabilmente più da ciò che avviene nel Celeste Impero – antitesi di ciò che è l’Europa – che da qualsiasi altra spinta politica in atto, comprese le minacce della Russia e il rischio conseguentemente plausibile di una guerra europea”. Ma “ciò che avviene nel Celeste Impero” era in effetti la rivoluzione Taiping (1851-1864) piegata solo dalle truppe inglesi del generale Gordon, ed era, niente di meno che, “la più grande lotta di classe della storia”. Basata nella città di Nanchino ebbe come bersaglio la libertà delle donne, la terra ai contadini, l’espulsione delle potenze straniere, l’educazione popolare e l’eguaglianza dei cittadini. E come antitesi i poteri coloniali. Malgrado questo esempio che giudica lui stesso “formidabile”, però Marx alla fine sembra contrario. Il dilemma sembra essere il seguente: la rivoluzione Taiping, in caso di successo, avrebbe potuto rovesciare il modo di produzione del dispotismo asiatico dall’interno? Senza, cioè, passare per il modo di produzione capitalistico e per la conseguente dominazione coloniale? Il Manifesto dei Taiping, che al loro massimo ebbero oltre due milioni di combattenti, prevedeva una società senza classi e l’eguaglianza universale, inoltre l’abolizione della proprietà privata sui terreni, e l’espropriazione dei beni dei proprietari per accedere ad una proprietà comunitaria della terra, inoltre l’abolizione del commercio privato e l’eguaglianza tra i sessi, con messa al bando di schiavitù, oppio, tabacco, alcol, poligamia, monarchia ed espulsione dei colonialisti stranieri. Purtroppo, quando questi furono sconfitti e sterminati dai cannoni inglesi, in un articolo del 1862 Marx dichiarò che “nella lotta contro il marasma conservatore non sembrano avere introdotto altro che forme grottesche di distruzione, senza alcun germe di rigenerazione” (p.102).
[76] - Si tratta del movimento dei paesi coinvolti nel Patto di Bandung, che era stato siglato nel 1955 tra 29 paesi del “sud del mondo”, non tutti socialisti. L’elemento unificatore di questo accordo è la lotta al colonialismo, che unisce l’Egitto di Nasser, l’India di Nehru, l’Indonesia di Sukamo, la Cina di Zhou Enlai. Successivamente, nel 1961, e quindi poco prima di questa conferenza, alla conferenza di Belgrado si propone la linea del “non allineamento”, con ben 120 stati (l’attuale presidente è Maduro).