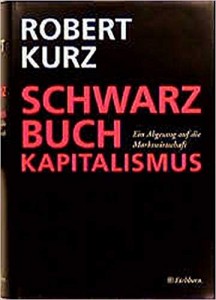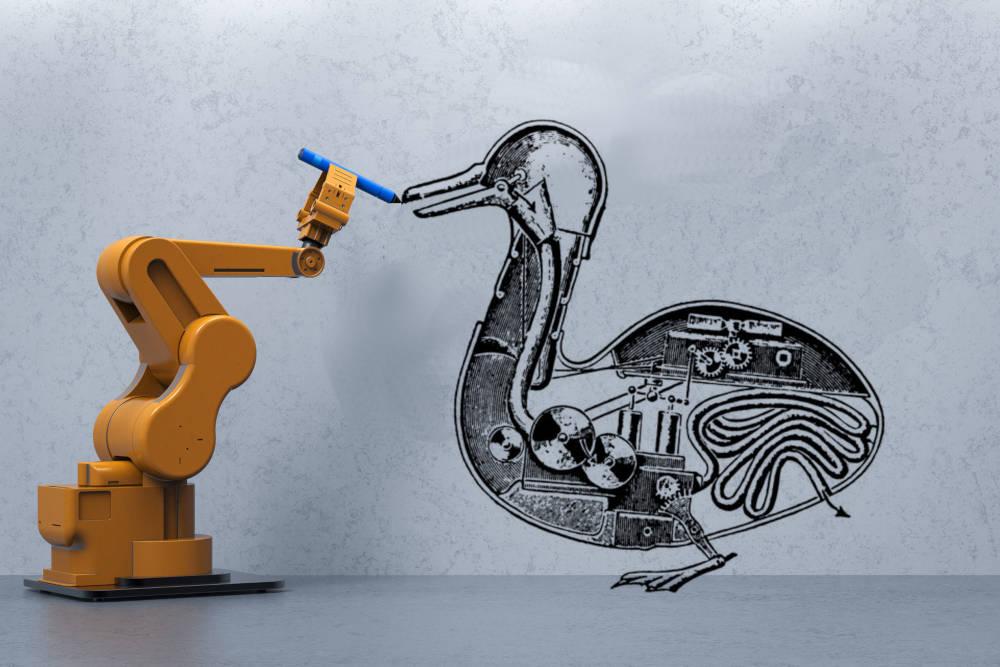La storia della terza rivoluzione industriale. 2-La razionalizzazione elimina l’uomo
mag 23rd, 2019 | Di Thomas Munzner | Categoria: Teoria e critica
Pubblichiamo il secondo capitolo della sezione VIII dello Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”) di Robert Kurz.
[redazione]
—–
Da Schwarzbuch Kapitalismus
Sezione VIII. La storia della terza rivoluzione industriale
• Visioni dell’automazione
• La razionalizzazione elimina l’uomo
• L’abdicazione dello Stato
• L’ultima crociata del liberalismo
• La nuova povertà di massa
• L’illusione della società dei servizi
• Capitalismo da casinò: il denaro perde il lavoro
• La fine dell’economia nazionale
• Il risveglio dei demoni
La razionalizzazione elimina l’uomo1
La storia a partire dal tardo XIX secolo ha già dimostrato come lo sviluppo reale di una rivoluzione industriale avvenga in maniera disomogenea e dopo periodi di incubazione più o meno lunghi. La nascita di una nuova tecnologia non comporta di per sé il «balzo» di una corrispondente rivoluzione socio-economica e la rispettiva tecnologia di base richiede a sua volta un certo periodo di maturazione e l’interazione con innovazioni su altri livelli. Ad esempio, negli anni Ottanta del XIX secolo l’automobile era già stata inventata ma le fondamenta della seconda rivoluzione industriale vennero gettate solo a partire dal 1913 con la «scienza del lavoro» di Taylor e con i nuovi metodi di produzione di Ford; essa inoltre, dopo un primo tentativo naufragato con la crisi economica mondiale, riuscì ad affermarsi a livello globale solo molto più tardi, cioè attorno al 1950. Uno sviluppo di questo genere, durato più di mezzo secolo, può andare incontro naturalmente a interpretazioni differenti e contraddittorie, fino al momento in cui non si manifesta distintamente il suo carattere autentico di rivoluzione epocale.
Le novità tecnologiche della terza rivoluzione industriale comparvero in un’epoca in cui la seconda rivoluzione non aveva neppure terminato di imporsi. È facile individuare la qualità delle tre grandi avanzate dello sviluppo industriale in base all’attività nel processo capitalistico di produzione: la prima rivoluzione industriale si contraddistinse essenzialmente per la sostituzione della forza fisica umana con quella delle macchine mentre la seconda fu caratterizzata dalla «razionalizzazione» o, si potrebbe dire, per la «robotizzazione» della forza-lavoro umana attiva nel sistema delle macchine. Il marchio fondamentale della terza rivoluzione industriale non poteva che essere la facoltà di rendere superflua la forza-lavoro umana nel processo di produzione industriale e la «razionalizzazione per riduzione» della medesima forza-lavoro grazie a meccanismi di controllo automatico e ai sistemi informatici.
Per questo scopo furono determinanti due innovazioni. Da una parte si rese necessaria una nuova forma di «scienza dell’organizzazione», che non era più una «scienza del lavoro» nel senso di Ford e Taylor ma una «scienza del controllo», buona per aggregati tecnologico-economici, ossia indipendente dal «dispendio di nervo, muscolo e cervello» dell’uomo e totalmente astratta così da poter essere applicata alla regolazione di «processi» sistemici di ogni genere. Essa venne individuata nella cibernetica, il cui concetto venne coniato per la prima volta da Norbert Wiener nel libro omonimo pubblicato nel 1948 (modellato sulla parola greco-antica che sta per l’«arte di pilotare le navi»). Wiener diede così vita a una nuova scienza che si collocava ai confini tra la matematica, la tecnologia e la biologia (neurofisiologia) e che aveva per oggetto le «leggi dei meccanismi funzionali»: un ramo interdisciplinare della scienza tagliato su misura per il funzionalismo capitalistico. Trapiantata in campo sociologico questa scienza non poté che sfociare in una tecnocrazia sociale di largo respiro: sul piano tecnologico l’automazione, su quello economico la «razionalizzazione per riduzione» della forza-lavoro umana. L’apparato concettuale della cibernetica, che iniziò da quel momento a inserirsi nel lessico generale, si interessa delle strutture della comunicazione, informazione, memoria e reazione o «feedback» da una prospettiva del tutto particolare, focalizzata sulla «regolazione» automatica. In una prima esposizione sintetica di questa nuova scienza – che conobbe uno sviluppo rapidissimo – possiamo apprendere qualcosa sulla sua genesi e sul suo contenuto, a partire dai concetti sviluppati per la prima volta da Wiener nel suo libro:
L’apparizione di quel libro fece l’effetto di un nucleo cristallino in una soluzione sovrasatura: tutti i cristalli si depositarono come d’incanto sul fondo, tutto ciò che «era nell’aria» nei più differenti campi e nei più diversi paesi prese improvvisamente forma, si condensò e finalmente la scienza della «cibernetica» apparve! […] Avevamo la cosiddetta «tecnica della regolazione», cioè la teoria dei dispositivi tecnici di regolazione, della loro costruzione e della loro applicazione nell’industria […] Anche la biologia e la fisiologia avevano dato vita ad uno sviluppo analogo ma, in un certo senso, nella direzione opposta. Si era capito ormai da tempo come la «regolazione» dei processi fisiologici negli organismi giocasse un ruolo fondamentale […] Fu allora che alcuni fisiologi e biologi, alla ricerca di metodi per descrivere questo comportamento degli organismi e l’interazione vicendevole e terribilmente complessa dei processi fisiologici negli esseri viventi, iniziarono a ricorrere ai concetti e soprattutto ai metodi matematici dei tecnici della regolazione – il primo di essi, in Germania, fu il fisiologo monacense R. Wagner, già a partire dal 1925. Per parte loro i tecnici poterono imparare molto per la teoria e per la costruzione dei loro «regolatori» da questo contatto con la biologia. Un altro ambito in cui erano già stati discussi problemi di genere analogo fu la tecnologia della comunicazione […] In seguito allo sviluppo sempre più rapido dei sistemi di comunicazione globale – che per giunta dovevano superare distanze sempre maggiori – i tecnici della comunicazione furono costretti ad affrontare molti problemi di tipo nuovo; ad esempio: com’è possibile inviare con il minimo sforzo e nel più breve tempo possibile il massimo di informazione a qualsiasi distanza? Quale influenza possono avere, in tal senso, gli inevitabili «disturbi»? E come sarebbe possibile minimizzarli […]? Nacquero così, necessariamente, alcuni interrogativi che concernevano la formulazione delle comunicazioni, cioè problemi di linguaggio, di testo, di «codificazione» delle comunicazioni, di riconoscibilità dei segni […] Nel corso di queste ricerche venne scoperto e messo a punto un concetto completamente nuovo, quello di «informazione». Si sviluppò uno specifico settore della scienza, la teoria dell’informazione, che si collocava ancora una volta in una terra incognitatra la tecnica della comunicazione, la linguistica, la logica simbolica, la matematica etc., e che in seguito acquistò un’importanza sempre maggiore per la tecnica della regolazione e per la biologia […] Tutto spingeva davvero verso una unificazione, verso una sintesi […].2
La vecchia metafora capitalistica della macchina in grado di descrivere la struttura del mondo, già declinata in maniera specifica nel corso delle prime due rivoluzioni industriali, venne riproposta anche nella definizione della cibernetica come «scienza formale e generale delle macchine», con la sottolineatura esplicita che «anche gli organismi viventi, le comunità, le economie nazionali e così via, sono da considerare come macchine» (Flechtner, op. cit.). Lo stesso Wiener, in un congresso del 1960, volle definire la «sua» scienza nella maniera seguente: «La cibernetica è la scienza del controllo e dell’informazione: non fa differenza che si tratti di esseri viventi o di macchine» (cit. da Flechtner). Ma per un’ironia del destino fu proprio questa «scienza generale delle macchine» a mettere fuori corso gli uomini come macchine capitalistiche e fu proprio questa «scienza del controllo» a mandare definitivamente fuori controllo il capitalismo, come del resto aveva già previsto lo stesso Wiener.
D’altro canto era però necessario anche un nuovo tipo di macchina, nel senso letterale del termine, per rendere efficace su grande scala la cibernetica e mettere così in moto la terza rivoluzione industriale. Questa macchina di nuovo genere era il calcolatore automatico, il cui sviluppo fu strettamente legato fin dal principio con la nascita della cibernetica. L’idea come tale, così come le forme più elementari della sua applicazione, è molto vecchia. Le prime ricerche matematiche a questo scopo risalgono addirittura al Medioevo. Fu Leibniz a perseguire il programma di una «formalizzazione universale» del mondo legata alla costruzione di macchine per il calcolo. Però tutti questi tentativi non superarono il loro stadio embrionale data l’insufficiente «capacità di memoria» e l’eccessiva lentezza delle operazioni di calcolo. Nonostante tutto però, già nella prima rivoluzione industriale, si realizzarono macchine che funzionavano con un controllo a schede perforate: «Bonchon utilizzò già nel 1725 una scheda perforata per trasferire meccanicamente un modello […] Nel 1805 Jacquard perfezionò il controllo a schede perforate mediante una successione di schede – il primo passo verso l’elaborazione dei dati».3 E nel 1890, ancora alla vigilia della seconda rivoluzione industriale, l’ingegnere americano di origine tedesca Hermann Hollerith (1860-1929) inventò la macchina a schede perforate. Ma fu solo nel XX secolo che quest’idea divenne una priorità assoluta per lo sviluppo scientifico-tecnologico del capitalismo. Nel 1936 il matematico inglese A.M. Turing creò il modello ideale di una macchina che prese il suo nome e che formalizzò il «concetto di computabilità o di costruibilità»:4
La macchina di Turing è […] il modello matematico di una macchina di calcolo. Con un apposito programma è in grado di eseguire qualunque operazione di calcolo che un uomo possa descrivere sulla carta […] In seguito fu chiaro che questo modello matematico di macchina è equivalente a tutti calcoli formali noti della computabilità […] Turing era consapevole della versatilità degli automatismi di calcolo definiti in termini matematici. Durante la guerra egli lavorò in una sezione dell’esercito britannico specializzata nella decifrazione di codici segreti a una macchina di questo genere: il progetto «Colossus». Nel 1947, sulla scia di questo progetto, venne realizzato il primo calcolatore britannico.5
Sempre nel 1936 l’ingegnere tedesco Konrad Zuse mise a punto un «calcolatore numerico» che «era in grado di risolvere equazioni per calcoli statici sulla base di un controllo a programma».6 La seconda guerra mondiale accelerò lo sviluppo dei calcolatori elettronici automatici per il calcolo di traiettorie balistiche, la decifrazione dei codici nemici e, non da ultimo, per la realizzazione della bomba atomica; per quel che riguarda i fondamenti tecnologici della terza rivoluzione industriale ancora una volta la guerra fu la madre di tutte le cose capitalistiche. Ma i calcolatori a base di tubi elettronici erano ancora troppo pesanti e costosi per essere un elemento di un nuovo tipo di produzione di massa. Nel 1948, parallelamente alla creazione della cibernetica da parte di Wiener, entrò in scena l’affermazione tecnica decisiva: nei laboratori Bell, alle porte di New York, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley inventarono il transistor – il «neurone dell’epoca dell’informazione». Per questa scoperta essi ricevettero il premio Nobel nel 1956. Il transistor, un elemento di amplificazione elettronica fatto di materiali semiconduttori, non era soggetto al surriscaldamento tipico dei tubi elettronici ed era non solo molto più piccolo ma anche passibile di un’ulteriore miniaturizzazione. Alla fine degli anni Cinquanta, grazie all’integrazione di diversi transistor, nacque finalmente il microchip. Tutti gli elementi fondamentali della rivoluzione microelettronica erano quindi presenti:
Sul piano dell’innovazione teorica il transistor e la conseguente tecnologia microelettronica sono interessanti in quanto […] come innovazione di base […] rappresentano l’elemento-chiave di una mutazione strutturale tecnologica del controllo automatico delle macchine, le cui ripercussioni sulla tecnologia produttiva sono così imponenti che non è certo un caso che si sia parlato di «rivoluzione industriale».7
In altre parole il dibattito sull’automazione della fine degli anni Cinquanta e dell’inizio dei Sessanta non fu mera fantascienza perché poteva già contare su di un sottofondo tecnologico reale, mentre stava ancora dispiegandosi il boom fordista. Il transistor estese repentinamente il campo di applicazione del controllo elettronico. Nell’ambito del congresso organizzato da IGM nel 1965, Walther P. Reuther, presidente del sindacato americano del settore automobilistico, si espresse così circa le prime tendenze di questa automazione di tipo nuovo:
Dieci anni fa la nostra organizzazione ha pubblicato un saggio dedicato alle conseguenze dell’automazione con un elenco di casi eclatanti: un tornio automatico capace di regolare i suoi dispositivi di taglio e, all’occorrenza, di sostituirli; torni e macchine perforatrici controllati attraverso dispositivi elettronici o nastri perforati, in grado di rimpiazzare lavoratori altamente specializzati; per finire addirittura una macchina a «memoria elettronica» capace di esaminare accuratamente un albero a gomiti, identificare eventuali scabrosità, memorizzarle, fermare l’albero e rimediare automaticamente alle imperfezioni […] Pressoché ovunque si confida in una crescita della produzione ma il progresso tecnico non potrà che rallentare o perfino diminuire la crescita dell’occupazione.8
Questo sviluppo rese però ancora necessario un certo periodo di incubazione, in un certo senso, una duplice competizione: da una parte tra l’espansione dei mercati fordisti e la nuova razionalizzazione microelettronica, dall’altra tra il calcolo dei costi aziendali e la miniaturizzazione (nonché la relativa riduzione del prezzo) dei calcolatori e dei dispositivi di controllo. La terza rivoluzione industriale prese forma nel grembo della seconda:
L’automazione inizia con la tecnologia legata ai processi produttivi nel settore chimico e petrolchimico, nell’industria dell’acciaio, in quella mineraria, nella produzione di energia e in quella dei generi di prima necessità. L’automazione dell’industria della lavorazione dei metalli è di gran lunga più complicata a causa della complessità e del carattere differenziato delle singole fasi produttive e inizia a divenire massiccia solo verso la metà degli anni Settanta dopo l’introduzione del microprocessore come tassello a buon mercato della regolazione e del controllo […].9
Fino a quando queste forze antagonistiche spinsero la riproduzione sociale in direzioni diverse, non fu possibile percepire con chiarezza le conseguenze finali della terza rivoluzione industriale e così l’ottimismo storico dei sindacati e dei teorici come Fourastié non fu apparentemente smentito sul piano pratico. Sebbene l’espansione fordista dei mercati si fosse già esaurita verso la fine degli anni Sessanta le onde del dibattito sull’automazione si placarono nuovamente. In un primo momento la cosiddetta crisi petrolifera» deviò lo sguardo in una direzione differente. Ma quando ci si rese finalmente conto che la causa della disoccupazione di massa innestatasi su scala globale non si poteva addebitare esclusivamente allo shock del prezzo del petrolio, riaffiorò anche la questione circa le ripercussioni socio-economiche dell’automazione; ora però in maniera ben più sgradevole e meno ottimistica rispetto a venti o a cinquanta anni prima.
Questa disoccupazione di massa, che viene definita come tecnologica oppure nel frattempo come «strutturale», la cui crescita sempre più inesorabile va di pari passo con l’ascesa della rivoluzione microelettronica dell’inizio degli anni Ottanta, manifestava un tratto peculiare, destinato a suscitare una profonda inquietudine per la coscienza capitalistica: la disoccupazione era strutturale in quanto non aumentava o diminuiva sotto l’influsso del ciclo congiunturale ma cresceva in continuazione indipendentemente da esso. Non c’era solo il rallentamento relativo della crescita in quanto il ciclo economico si limitava a modulare debolmente un’imponente disoccupazione di massa che aumentava in termini assoluti e il cui «zoccolo» col trascorrere del tempo, fino alla fine del XX secolo, si ingrossava costantemente. Questo problema si era convertito nel problema sociale per eccellenza, in una crisi globale permanente, tale da offuscare ogni altro problema o di crearne in continuazione di nuovi.
L’idea di Hannah Arendt circa la «crisi della società del lavoro» non solo iniziò ad acquisire per la prima volta rilevanza presso il grande pubblico ma assunse anche un tono minaccioso. Nel 1983 IG Metall pubblicò uno studio sulla disoccupazione tecnologica di massa il cui titolo «Vogliono le macchine, non gli uomini!» risuonava giustamente stridulo a paragone del dorato ottimismo del 1965. Anche la riflessione teorica assunse sembianze ugualmente tetre e indurite. Già nel 1977 il filosofo Günther Anders aveva speso parole circa «l’obsolescenza del lavoro»:
Ora, la maggior parte dei lavoratori odierni non appartiene ancora alla categoria dei servi dell’automazione. Ma il trend è inarrestabile: negli anni duemila, così si prevede, la maggioranza dei lavoratori saranno lavoratori dell’automazione. Questo naturalmente non significa che tutti lavoreranno come «volontari del lavoro» o nelle industrie automatizzate. Esiste infatti una regola ferrea dell’inversione della proporzione, che afferma che con il crescente sviluppo dell’automazione il numero dei lavoratori richiesti diminuisce. Detto in altro modo: è inevitabile che dall’automazione escano per così dire come «sottoprodotto» milioni di disoccupati […] In Giappone esistono già unmanned factories. Ce ne saranno presto altre anche altrove, e così pure unmanned offices, dato che i computer odierni calcolano con rapidità circa un milione di volte maggiore […] di quella dei propri costruttori […] L’umanità si trasformerà in un unico, colossale Lumpenproletariat? […] Infatti la disoccupazione che attualmente ci minaccia farà sembrare innocua quella che regnava cinquant’anni fa. Se si pensa che già quella di allora era stata una delle cause principali del nazionalsocialismo, potrà mancare il coraggio di figurarsi quel che produrrà la disoccupazione immanente. Non è impossibile che le stufe a gas di Auschwitz (allora assurde da un punto di vista economico) potranno fornire i modelli per il «superamento» del fatto che, in confronto alle possibilità di lavoro, «esistono troppi uomini».10
Con un’angoscia gravida di cattivi presentimenti vengono tratteggiate qui le più oscure conseguenze del crollo incombente dei mercati del lavoro, che riecheggiano il ricordo delle fantasie liberali di annientamento delle masse umane «superflue» per il capitalismo durante le grandi crisi di trasformazione della prima rivoluzione industriale. Il guaio è che Anders, come già molti altri critici prima di lui, sebbene nomini occasionalmente, quasi en passant, il capitalismo, vorrebbe ricondurre in ultima analisi questo problema catastrofico direttamente alla «tecnica», pregiudicando così qualsiasi possibilità di soluzione. Quando parla del «totalitarismo degli apparecchi»,11egli adotta naturalmente un’espressione appropriata, ma solo in quanto le forze produttive, in questi «apparecchi», sono già associate in una forma specificamente capitalistica, la cui logica intrinseca non è «tecnica» perché è la logica di sfruttamento economico del «lavoro astratto». Seguendo il filo della sua argomentazione Anders sottolinea in maniera indiretta il carattere distruttivo della razionalità aziendale; infatti è inverosimile che nel 1977, ancor meno che nel 1844 o nel 1999, siano le «macchine risparmia-lavoro» in sé, per ragioni meramente «tecniche», a gettare nella miseria le masse umane. La responsabilità non è della tecnica in quanto tale ma solo dell’organizzazione sociale che conduce lo sviluppo tecnico verso conseguenze talmente insensate.
Ma perlomeno Anders chiama la brutalità del sistema con il suo vero nome, pur non riuscendo a cogliere l’insieme delle condizioni socio-economiche, mentre Ralf Dahrendorf, cinque anni più tardi, in occasione del XXI Congresso dei sociologi tedeschi si pronuncia con il gergo tipico del liberale autentico, introduce una riflessione sul terreno economico che, proprio in quanto tale, conformemente ai canoni della dottrina economica anglosassone, dissimula la «crisi della società del lavoro» con il pretesto di spiegarla, consigliando nel medesimo frangente una soluzione ignobile, che però non sembra neppure convincere fino in fondo questo mâitre-à-penser del liberalismo contemporaneo.
Tutti parlano di disoccupazione. È facile comprenderne il perché. Ancora fino alla metà degli anni Settanta la percentuale degli individui in grado di lavorare, ma che non avevano un lavoro, si aggirava intorno al tre o al massimo al quattro per cento. Oggi, nel 1992, il tasso di disoccupazione nei paesi OCSE si attesta in media attorno al 10% […] Secondo la tesi di Friedrich von Hayek in una vera economia di mercato la disoccupazione non dovrebbe esistere; il costo del lavoro diminuirebbe fino a un livello tale da garantire lavoro per tutti […] Fino a quando la grandezza dei salari reali non si modifica, la spiegazione della disoccupazione è data ma non possiamo fare nulla per combatterla. I salari reali, così come li conosciamo oggi, sono l’esito finale di uno sviluppo lungo e gravido di conseguenze […] lo sviluppo dei diritti di cittadinanza. Questo diviene particolarmente evidente se si prendono in considerazione le misure volte alla sicurezza sul posto di lavoro e soprattutto alla sicurezza del posto di lavoro, ossia se parliamo di salari reali nel senso più ampio del termine. Tutti questi sviluppi hanno reso il lavoro più costoso. La disoccupazione ha le sue radici nel costo del lavoro […] Il sempre maggior successo del lavoratore è dunque la forza propulsiva della società del lavoro, che ne causerà infine la soppressione […] Si sente dire spesso che la causa della disoccupazione, qualora non dipenda chiaramente dalla congiuntura economica, sarebbe lo sviluppo tecnologico. Effettivamente è impossibile negare che i posti di lavoro possano anche essere surrogati da procedure tecniche […] Solo che il progresso tecnico, contrariamente all’idea che i lavoratori hanno dei rapporti sociali, non è affatto una «legge di natura». La tesi secondo cui la tecnica starebbe distruggendo i posti di lavoro è alquanto miope. Da tempo ormai la tecnica non è più tanto la causa, quanto piuttosto l’effetto dei mutamenti sociali, un elemento dei rapporti di produzione, non una forza produttiva. Senza l’aumento continuo dei salari reali lo sviluppo tecnologico sarebbe rimasto per molto tempo nuda teoria. L’introduzione delle innovazioni tecniche si deve al fatto che esse sono più convenienti; non in quanto tali ma solo a paragone del lavoro umano. A ben vedere, la causa della cosiddetta disoccupazione «strutturale» o «tecnologica» è il fatto che la tecnica ha un costo più vantaggioso rispetto a quello del lavoro.12
Prendono qui la parola spudoratamente i triviali sofismi del liberalismo classico. Si vuole sottolineare con «rammarico» il fatto che la vera causa della miseria è il livello «eccessivo» dei salari reali. Ne deriva il ragionevole sarcasmo della coscienza liberale egemone: se non ci fosse stato lo «sviluppo gravido di conseguenze» dei «diritti sociali», l’innalzamento del livello salariale, il miglioramento delle garanzie di lavoro etc., ossia se il vecchio movimento operaio e lo Stato sociale non avessero goduto di tanto «successo» (ma i loro risultati sono stati in realtà assai modesti) adesso non ci sarebbe alcun problema. Ma è successo ciò che doveva succedere: la forza-lavoro è diventata «troppo costosa» e così adesso la frittata è fatta! È arrivato allora il momento, come è logico, di dare libero corso, «una volta per tutte», agli slogan dell’estremismo economico: abbasso i salari, piazza pulita delle prestazioni sociali, fine della «baldoria» delle garanzie sociali! Tutte cose assolutamente sgradevoli – così prosegue la riflessione liberale con voce melliflua – che voi non volete assolutamente, che nessuno vuole, ma in questo caso occorre pagarne le conseguenze, qualsiasi esse siano!
Questa pseudo-argomentazione è doppiamente assurda. Una riduzione radicale del livello salariale e delle prestazioni sociali non garantirebbe alcuna via di scampo, anche in un senso tutto immanente al sistema. Dato il livello storico raggiunto dall’accumulazione il ritorno massiccio degli «eserciti del lavoro» – che la coscienza liberale si augura di tutto cuore (fedelmente alla sua tradizione) – deflagrerebbe il modo di produzione capitalistica per ragioni oggettive puramente economiche, anche in assenza di qualsivoglia movimento di opposizione sociale. Nella prima fase della nuova crisi Dahrendorf ha già apparentemente dimenticato tutta l’autoriflessione scaturita da più di un secolo di dibattito interno al capitalismo: dalla concessione di qualche «goccia di balsamo sociale» da parte di Bismarck, fino al riconoscimento fordista della necessità sistemica del consumo-«investimento» di massa sotto forma di auto, elettrodomestici etc.
Dahrendorf rispolvera un classico sofisma, tipico del pensiero microeconomico prekeynesiano nella teoria economica: ciò che è «buono» per la singola impresa sul livello aziendale allo scopo di affermarsi nella concorrenza (riduzione dei costi) sarà tale anche sul livello macroeconomico della riproduzione sociale complessiva in forza della «mano invisibile». Ci si dimentica però che una diminuzione radicale dei salari reali sul livello della produzione fordista avrebbe solo effetti catastrofici sul piano macroeconomico dalle conseguenze corrispondenti sul livello aziendale. L’atteggiamento di Dahrendorf è quello di chi sembra ignorare tutt’a un tratto quanto sia indispensabile e ineluttabile per l’esistenza del capitalismo stesso la coerenza faticosamente raggiunta tra produzione di massa industriale, salari di massa nella forma-denaro e consumo di massa di merci.
D’altro canto anche l’argomentazione keynesiana, tutta concentrata sul livello macroeconomico delle grandezze fluide dell’economia nazionale, era ormai obsoleta in quanto l’inflazione del sistema monetario aveva affossato già da tempo il progetto del «deficit spending». Pertanto la caparbia ostinazione su questo programma, che caratterizza ancora oggi il keynesismo accademico di sinistra, non era più in grado di offrire nessuna soluzione – il keynesismo si era completamente usurato. Questo voleva semplicemente dire che, da quel momento in avanti, la logica microeconomica e quella macroeconomica non potevano più coincidere. Mentre il punto di vista microeconomico, nelle nuove condizioni, pretendeva una diminuzione radicale dei salari reali e delle prestazioni sociali, quello macroeconomico raccomandava al contrario un ulteriore aumento dei salari per le masse, per non minacciare la crescita. In altre parole: l’autocontraddizione interna del capitalismo si sviluppò fino ad uno stadio qualitativamente nuovo, in grado di distruggere il sistema. Ed è proprio questa la conseguenza che né i keynesiani né i liberali come Dahrendorf vogliono trarre. E così, mentre il campo keynesiano, sempre più rarefatto e costretto sulla difensiva, continua comunque a puntare sul «deficit spending», un programma ormai irrimediabilmente esaurito, Dahrendorf è ritornato implicitamente alla vecchia e conseguente concezione microeconomica, già fallita prima del keynesismo che aveva addirittura tenuto a battesimo. Si annuncia così la direzione dell’intelligentsia capitalistica agli albori della nuova crisi del sistema: la fuga in avanti – verso il passato liberale!
Ma la tesi di Dahrendorf risulterebbe assurda perfino se questa rivincita della prospettiva microeconomica – e quindi la riduzione dei salari reali – funzionasse davvero anche sul piano macroeconomico. È sufficiente riflettere sulla grottesca pretesa che viene rivolta ai lavoratori, che dovrebbero ingaggiare una «concorrenza sui costi» con i potenziali di razionalizzazione della terza rivoluzione industriale e quindi una competizione al ribasso tra i loro salari e i costi delle nuove tecnologie di controllo. Detto altrimenti: l’unica possibilità di garantire l’occupazione, secondo Dahrendorf, dovrebbe consistere nell’arresto del progresso tecnologico da parte dei lavoratori, a patto che essi siano disposti a peggiorare sempre più drasticamente il loro livello di vita. Infatti non si tratterebbe logicamente di un provvedimento preso una volta per tutte ma di una spirale permanente a base di contrazione salariale e sviluppo economico, poiché nella concorrenza l’interesse di chi offre tecnologie razionalizzatrici esige una costante diminuzione dei loro costi. Pertanto in questa stravagante «competizione» contro il progresso tecnico, nelle condizioni della terza rivoluzione industriale, i salari sarebbero dunque costretti a diminuire continuamente, fino ad azzerarsi o persino a diventare negativi. Il prezzo della forza-lavoro, al cospetto dei balzi sempre più enormi nella produttività degli aggregati microelettronici dovrebbe ridursi in misura sovraproporzionale; la diminuzione dei costi dei mezzi di produzione microelettronici può essere combinata con una produttività tecnica sempre più accresciuta, mentre la capacità di rendimento della forza-lavoro umana è limitata in senso assoluto e quindi potrebbe concorrere solo sul lato dei costi.
Questa conclusione sul piano microeconomico, completamente folle e socialmente suicida sotto numerosi aspetti, rappresenta l’ultima parola di un sistema assurdo fin dal principio. Dahrendorf non si sogna neppure di trarre l’unica conseguenza ragionevole. Essa naturalmente non consiste certo nello scatenamento di una concorrenza demenziale contro il progresso tecnico ma, in armonia con tale progresso, nella rivendicazione di più ozio per tutti, nella piena partecipazione di ognuno ai frutti di una produttività spaventosamente accresciuta. Tale conclusione, l’unica davvero assennata, è però assolutamente irrealizzabile sul terreno della razionalità economica. E così il maitre-à-penser liberale non fa che snocciolare le sue sciocchezze madornali, assoggettandosi in questo ad un’interiorizzazione talmente spinta e profonda dell’autotelia capitalistica che anche questo evidente controsenso viene incassato come se si trattasse di una seria argomentazione teorica. Alla fine del suo intervento è lo stesso Dahrendorf a descrivere in tono quasi meravigliato la totale insensatezza in cui sfocia necessariamente l’eliminazione razionale del «lavoro» nelle condizioni capitalistiche:
La battaglia tra coloro che devono lavorare e coloro che non devono lavorare, ha condotto al successo totale: coloro che in passato non dovevano lavorare, sono adesso tra coloro che ancora possono lavorare, mentre coloro che in passato dovevano lavorare, non possono più lavorare. La lotta di classe per il lavoro ha condotto a una completa inversione dei fronti.13
Secondo Dahrendorf la responsabilità del paradosso insolubile del «lavoro» andrebbe addebitata in tutto e per tutto al «successo eccessivo» dei lavoratori. Si tratta in realtà di un paradosso del capitalismo stesso e l’unica colpa che si può rimproverare grandemente ai lavoratori è il loro irretimento nelle costrizioni del «lavoro astratto» e la loro interiorizzazione delle categorie del lavoro nel corso della storia. Tuttavia in questo paradosso, per come lo enuncia Dahrendorf, le condizioni di esistenza capitalistiche appaiono come irrevocabili e insuperabili. Ma se i criteri della «società del lavoro», con tutte le relative forme economiche, devono sopravvivere mentre, al contempo, la «società del lavoro inizia a vacillare» affiorano inevitabilmente questioni elementari, che Dahrendorf si limita a formulare in tono affermativo e quindi visibilmente repressivo:
Per esempio: come sarà possibile strutturare la vita degli uomini una volta che il disciplinamento legato all’organizzazione del lavoro venga a mancare? Oppure: come si potranno garantire i fondamenti dell’esistenza umana se quest’ultima non si basa più sulla prestazione lavorativa?14
Domande interessanti, cui è semplicissimo dare una risposta: il disciplinamento» del materiale umano è superfluo come il capitalismo stesso poiché gli uomini sono in grado di regolare in maniera autonoma tutte le loro incombenze anche senza subire la costrizione esterna di burocrazie alienate e di «pratici» del capitalismo usciti di senno. Nell’interrogativo di Dahrendorf riecheggia la vecchia logica benthamiana, che adesso diviene sempre più assurda. E sarebbe facilissimo garantire i «fondamenti dell’esistenza umana» con le nuove forze produttive se queste ultime venissero impiegate oltre la logica capitalistica e se la distribuzione dei loro prodotti avvenisse in tutta naturalezza indipendentemente dal contributo lavorativo dei singoli. Dov’è allora il problema? Le questioni sollevate dal teorico liberale gli appaiono «insolubili» solo perché egli non può, né vuole immaginare risposte differenti da quelle ormai impossibili già enunciate dal capitalismo.
Qualche anno prima anche Günther Anders si era già cimentato con l’aporia capitalistica, contenuta nella terza rivoluzione industriale; su questo punto sua è l’affermazione secondo cui «oggi mezzi e fini sono invertiti». Questa inversione è però connaturata alla logica autotelica del capitalismo; notevole è il fatto che, a quell’epoca, essa fosse stata percepita con chiarezza da un osservatore spassionato, per quanto privo degli strumenti teorici della critica del feticismo di Marx. Per giunta Anders, pur attribuendo il problema in modo erroneo direttamente alla «tecnica», identifica spontaneamente il fine in sé irrazionale del modo di produzione capitalistico che, al cospetto della razionalizzazione microelettronica, non sfuggirebbe neppure a un cieco.
Ma mentre prima lo scopo del lavoro consisteva nel fatto di soddisfare i bisogni mediante la produzione di prodotti, oggi il primo bisogno è la produzione di posti di lavoro; la creazione di lavoro diventa il vero compito, lo stesso lavoro diventa un lavoro da produrre […].15
Il capitalismo non fu mai diverso da così; la «semplice» relazione tra bisogno e processo produttivo, che Anders vede di fronte a sé come originaria, è effettivamente premoderna. Tuttavia, fino a quando la crescita capitalistica ebbe ancora margini di sviluppo storico davanti a sé fu sempre possibile mistificare la scarsità artificialmente prodotta dal capitalismo, accompagnata in maniera paradossale dalla crescita costante delle forze produttive, come un rapporto equilibrato tra bisogni e risorse. Mentre la terza rivoluzione industriale maturava è però venuta a galla anche l’incredibile circostanza per cui il «lavoro» è un «prodotto da produrre» – senza che si levasse una critica radicale di questa pretesa paradossale, che invece si intravede in Anders. Risuona piuttosto l’ululato lugubre per i «posti di lavoro», che ancor oggi ci lacera le orecchie, con un effetto comunque più sgradevole rispetto a quindici o venti anni or sono. Una volta escluso il superamento delle condizioni capitalistiche in maniera conseguentemente e tacitamente condivisa dall’intero campo sociale, nonostante che la sua assurdità fosse ormai impossibile da negare, non rimase altro che confidare in una profezia per il futuro forzatamente ottimistica, ripetuta ad intervalli di tempo più o meno regolari, circa un nuovo boom epocale; in genere astutamente relativizzato mediante l’enigmatico riferimento a una qualche imperscrutabile «complessità» della «moderna società». L’idea fondamentale era che, in ultima analisi, la terza rivoluzione industriale, così come le due precedenti, avrebbe condotto a una ripresa su vasta scala della crescita e dell’«occupazione». I pesanti crolli degli anni Settanta e Ottanta e la la relativa disoccupazione di massa erano da considerare solo come un fenomeno transitorio nel contesto di una crisi di trasformazione identica a quelle che già avevano caratterizzato le precedenti rotture strutturali. A partire dal 1983, la Banca mondiale, il giapponese MITI (ministero per il commercio internazionale e per l’industria), Prognos AG (Basilea), l’Ifo (Monaco di Baviera) e l’Istituto per l’economia mondiale (Kiel), nonché molti guru del management in Europa e negli USA, auspicarono una «inversione di tendenza» per gli anni Novanta.
Verso la metà degli anni Ottanta venne pubblicato in Germania un testo collettivo, dal classico titolo incoraggiante «Stanno per arrivare i prosperi anni Novanta?» (Jänicke 1985) che metteva al centro del dibattito la speranza nell’«onda lunga» di una nuova ripresa di lungo periodo. La teoria delle «onde lunghe» di Schumpeter e Nicolaj Kondratiev non coincide certo con la teoria più generale delle rivoluzioni industriali poiché rappresenta solo uno sviluppo della teoria della congiuntura;16 essa però assume un nesso fondamentale tra «nuove tecnologie di base» e «ripresa a lungo termine», effettivamente ammissibile per le prime due rivoluzioni industriali (non però nel senso di un «accrescimento del benessere» generale ma solo come espansione del sistema capitalistico), dopo un periodo di incubazione doloroso con un gran numero di perdenti. Per la terza rivoluzione industriale la teoria delle «onde lunghe» formula la seguente previsione: in una prima fase ci sarebbe stata la crisi irreversibile delle industrie fordiste ormai obsolete («i tetri anni Ottanta»), causata dai «distruttori creativi» schumpeteriani della nuova industria (principalmente microelettronica), poi queste ambiziose nuove imprese avrebbero costituito il motore della crescita e dei posti di lavoro («i prosperi anni Novanta»). Questo modello voleva lanciare, per così dire, un cessato allarme epocale:
La maggior parte degli autori è d’accordo sul fatto che l’ultima onda lunga della motorizzazione di massa abbia raggiunto e superato il suo apice con la recessione del 1967 e il cosiddetto shock petrolifero del 1973 […] Vecchi complessi industriali – come ad esempio l’industria automobilistica, quella dell’elettronica di massa o le industrie del carbone e dell’acciaio – sono generalmente entrati in una crisi di sopravvivenza […] Ma è altrettanto prevedibile il fatto che, dopo questa crisi, inizierà una nuova «ripresa». È un fatto ovvio, a patto però che tutte le condizioni generali per una nuova onda lunga siano presenti: una cultura in cui domini la ragione strumentale; una ben definita propensione individuale per il potere e il guadagno; personalità pionieristiche nella scienza e nella tecnica, così come nell’economia e nella politica e – non da ultimo – un flusso ininterrotto di sviluppi tecnico-scientifici, da sfruttare economicamente al momento opportuno […] Queste nuove tecnologie si relazionano vicendevolmente tra loro in molti modi e allo stesso tempo permeano quelle vecchie […] Il complesso elettronico incarna il nuovo progetto-chiave industriale […] In altre parole le forze in grado di muovere e sostenere una nuova onda lunga sono già date.17
Una grossolana sommatoria di «fattori» viene spacciata qui per una teoria della ripresa a lungo termine: un nuovo «modello di accumulazione» dovrebbe sorgere dall’interazione tra «ragione strumentale» (un concetto che nella teoria di Adorno ed Horkheimer aveva ancora un rilievo critico e che qui invece figura come una condizione positiva), «personalità pionieristiche» affamate di potere e guadagno (entrambe queste motivazioni, nello spirito di Mandeville, vengono giudicate come esemplari) e «nuove tecnologie»; una concatenazione presupposta alla stregua di un assioma, così da non doverla più fondare concretamente. L’esperienza del boom fordista, valido solo per una minoranza globale, esente da elaborazione analitica, appare come un «modello» universale, valido per ogni futuro. Questo ingenuo «orientamento verso la successiva nuova onda lunga»18 fu anche il punto di accordo implicito tra teorici liberali, conservatori, socialisti e verdi.
La forte tendenza a sdrammatizzare la situazione, ancor prima che la crisi si fosse realmente messa in moto, fece così ricorso, trasversalmente a tutto il campo sociale, allo stereotipo per cui era dapprima necessario mettere insieme in qualche modo le necessarie «condizioni-quadro». Dall’analisi della crescita capitalistica reale e delle sue condizioni interne l’interesse si trasferì alla cornice esterna, all’«organizzazione politica» e ai presupposti istituzionali; nel suo saggio sulla «obsolescenza del lavoro» Günther Anders si espresse così, in modo lungimirante: «Io diffido della parola “formare”, che fa parte della lista nera, quella delle parole da proscrivere […]».19 Gli speranzosi propagandisti dell’«organizzazione politica» credevano che le cose sarebbero andate come nel caso della seconda rivoluzione industriale, quando i presupposti infracapitalistici per il nuovo boom della tecnologia e della razionalizzazione erano già stati effettivamente realizzati mentre i cambiamenti istituzionali vennero solo in seguito. Questa interpretazione della crisi asseconda già, per certi versi, l’imperativo di Dahrendorf visto che in seguito il problema delle «condizioni-quadro» è stato smascherato piuttosto velocemente come un mero problema di «adattamento» ai nuovi rapporti capitalistici – dove per adattamento bisogna intendere naturalmente ancora una volta una sottomissione sociale incondizionata.
Malgrado tutto però, dall’inizio degli anni Ottanta, l’epoca delle esternazioni di Dahrendorf, mentre i salari reali e i trasferimenti sociali nel mondo intero, inclusi i paesi-chiave del capitalismo, sono diminuiti costantemente, la disoccupazione strutturale di massa continua a dilagare a macchia d’olio come un incendio di vasta portata e i tassi di crescita rimangono bassi o, in molti paesi, sono letteralmente sprofondati. Attualmente, alla fine degli anni Novanta, non si vede proprio alcuna traccia del nuovo boom secolare. Dovrebbe essere ormai chiaro che attendersi una «ripresa di lungo periodo» per la terza rivoluzione industriale è come aspettare Godot. Ogni nuova spinta della razionalizzazione microelettronica spazza via sempre nuovi segmenti dei mercati del lavoro mentre le istituzioni capitalistiche sono impegnate in una gestione dilatoria della crisi che minaccia di diventare permanente.
L’ottimismo dilettantesco delle profezie di Fourastié è finito male ed è caduto ormai da tempo nell’oblio, per non parlare delle 15 ore settimanali di lavoro «terapeutico» immaginate da Keynes a fronte di un aumento corrispondente della produzione. Ancora durante gli anni Ottanta i sindacati tentarono indubbiamente di risolvere la «crisi del lavoro» sul terreno del capitalismo mediante la riduzione dell’orario contrattuale di lavoro fino a 40 ore settimanali (o addirittura a sole 35 ore). Ma questo ragionamento dettato dal senso comune non avrebbe mai potuto funzionare e, com’era prevedibile, si infranse contro la razionalità socialmente irrazionale dell’economia d’impresa. La riduzione dell’orario di lavoro, pattuita in ogni caso solo in pochi paesi-chiave del capitalismo (e anche lì solo in certi settori), nel corso degli anni Novanta venne aggirata e completamente svuotata di senso nella prassi, in qualche caso grazie al ricorso al lavoro straordinario (sempre più di frequente non retribuito!) oppure mediante la fuoriuscita da associazioni vincolate a contratti collettivi o, infine, attraverso palesi violazioni contrattuali. Come reazione alla crisi, nella stragrande maggioranza dei paesi e dei settori economici, non ci fu neppure una riduzione formale dell’orario di lavoro ma una divaricazione tra pressanti pretese efficientistiche e perfino l’allungamento dell’orario di lavoro da una parte e disoccupazione di massa e crescita della miseria generale dall’altra. Adesso il paradigma della riduzione dell’orario di lavoro è caduto in discredito anche presso i sindacati dei paesi più sviluppati – un chiaro segnale di capitolazione e di autoimmolazione incondizionata. «L’era della riduzione generale dell’orario di lavoro è giunta al termine» (Süddeutsche Zeitung 2/7/1997) – e proprio in un’epoca di automazione e di disoccupazione di massa.
A dispetto di ogni evidenza l’opinione pubblica borghese, così come i governi e gli apparati dello Stato, si rifiutano caparbiamente di percepire la reale portata della «crisi della società del lavoro» dagli effetti dirompenti per il sistema. È senz’altro vero che non si parla più ormai da tempo di una nuova secolare ripresa di lungo periodo. Ma alla fine di questa grande speranza non ha fatto seguito l’ammissione che il capitalismo, nelle condizioni della rivoluzione microelettronica, non è più in grado di riprodurre la società ma solo un business as usual in relazione con una crisi che sempre più si auto-divora. E così hanno preso l’avvio due metodi complementari. Da una parte l’ufficialità mediatica, pubblicistica, accademica discute o si limita a simulare sterili «progetti di soluzione» totalmente inefficaci, dall’altra le istituzioni dominanti infliggono restrizioni sociali sempre più dure contro il materiale umano «superfluo».
Architettare piani per la battaglia donchisciottesca contro la «depressione occupazionale» è già ormai quasi uno sport per i cosiddetti «pensatori creativi» e, in ogni caso, un remunerativo settore commerciale. Il risultato è un profluvio di inverosimili chimere – a partire dal job-sharing e dal lavoro part-time fino ad arrivare alla «rivalutazione» dei «lavori socialmente utili» – tutte accomunate dal medesimo aspetto: nessuna di esse coglie il nocciolo del problema poiché danno tutte per scontato che qualsiasi soluzione concepibile debba conciliarsi necessariamente con l’«economia di mercato» e con le sue leggi sistemiche. È possibile discutere unicamente dei sintomi, non della malattia. Pertanto questo pseudo-dibattito affronta solo settori marginali e forme peculiari non generalizzabili dell’«occupazione» mentre il centro della società, il blocco egemone del «lavoro astratto», viene completamente eclissato. Soluzioni di questo genere rappresentano un’«offerta» assiduamente lanciata sul mercato, che nel frattempo si è rivelata talmente deficitaria nelle sue analisi, tanto scadente e in sé contraddittoria che persino un bambino potrebbe saggiare la sua inconsistenza. Ammesso che vi si possa riconoscere un senso, esso non può che consistere nel ripristino delle «condizioni quadro», da tradurre regolarmente come riduzione dei salari e restrizioni sociali. Il frastuono di questo singolare discorso sovrasta le misure della gestione capitalistica del lavoro, il cui obiettivo più raffinato consiste da tempo nel rendere «invisibile» la disoccupazione di massa nella maniera più sotterranea e delicata possibile:
Sono molti i paesi industriali sviluppati, i cui governi si erano proposti l’obiettivo della piena occupazione in un futuro non troppo remoto, che presentano statistiche ufficiali sulla disoccupazione già allarmanti sotto il profilo sociale […] Il numero reale dei disoccupati è probabilmente assai più elevato di quanto i dati ufficiali lascino presagire. Tale numero rappresenta un tema politico scabroso, e così vengono registrati nelle statistiche ufficiali solo coloro che corrispondono alla definizione ufficiale. Nel caso tedesco, ad esempio, questa definizione è stata ripetutamente rivista, cosicché adesso un considerevole numero di disoccupati effettivi si nasconde all’interno di altre categorie come ad esempio i percettori di sussidi sociali. In numerosi Stati industriali sviluppati, tra cui la Germania, sono definiti disoccupati solo coloro che cercano un posto di lavoro, ed anche il sussidio di disoccupazione viene erogato solo per un periodo di tempo determinato. Date le circostanze un numero sconosciuto di persone in cerca di lavoro smette di cercarlo dopo ripetuti tentativi falliti e si accontenta del sussidio sociale […].20
In sostanza le statistiche sulla disoccupazione vengono regolarmente falsificate quasi ovunque per ragioni di opportunità politica. Da una parte un enorme numero di disoccupati non trova più posto nelle statistiche perché la loro reale condizione è stata artatamente occultata, non solo mediante il trasferimento nella categoria dei percettori di sussidi ma anche attraverso l’inserimento in «società per l’occupazione» o in «misure per la creazione di lavoro» statali o promosse dallo Stato, le cosiddette «riqualificazioni» o temporanei collocamenti a riposo. Molte donne, siano esse coniugate e madri di famiglia oppure genitrici singole, vengono indirettamente «ricacciate al focolare domestico» e spesso integralmente estromesse dalla registrazione statistica. Dall’altra invece nella statistica degli «occupati» compaiono sempre più lavoratori che, in realtà, vengono arruolati solo per lavori stagionali o a tempo parziale o persino per poche ore.
Negli USA viene considerato «occupato» perfino chi, anche solo per una o due ore a settimana, letteralmente per una manciata di dollari, aiuta la clientela con i sacchetti al supermercato. Inoltre la statistica sugli occupati e sui rapporti di lavoro subisce una falsificazione ancor più grossolana per il fatto che sempre più lavoratori, a causa della diminuzione dei salari reali in molti Stati industriali, sono costretti ad intraprendere, accanto al loro lavoro regolare, un secondo o addirittura un terzo rapporto di lavoro. Oggi a New York, per esempio, non è affatto insolito che un meccanico, terminata la sua giornata di lavoro, trangugi frettolosamente la sua cena e lavori poi ancora per molte ore come guardia notturna e, nel fine settimana, come cameriere, magari senza un vero e proprio stipendio, solo per racimolare qualche mancia. È unicamente attraverso questo stile di vita rovinoso che può essere mantenuta la facciata della normalità (assicurazione sanitaria, casa, automobile). Ci vuole davvero una bella faccia tosta per definire simili rapporti, che si stanno diffondendo da tempo anche in Europa, come «miracolo del lavoro». Per questo motivo la statistica sulla disoccupazione oggi presenta un quadro falso e abbellito della situazione reale. Nonostante tutto però, anche attraverso il velo delle cifre ufficiali, è possibile quantomeno intuire la diffusione esplosiva della disoccupazione strutturale di massa, esaminandone l’andamento a partire dal primo grande balzo tra il 1980 e il 1985 fino ai tardi anni Novanta:
Numero dei disoccupati (in milioni)
| Paese | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 0,889 | 2,304 | 1,883 | 3,210 |
| Francia | 1,467 | 2,442 | 2,205 | 2,980 |
| Inghilterra | 1,513 | 3,179 | 1,556 | 2,454 |
| USA | 7,637 | 8,312 | 7,047 | 7,404 |
| Giappone | 1,140 | 1,560 | 1,350 | 2,098 |
(Fonte: Ufficio statistico federale, Annuario statistico per l’estero, 1998)
Questi dati e la loro variazione non sono un buon riflesso del rapporto tra le fasi di crisi e quelle di ripresa relativa ma rispecchiano piuttosto i limiti degli artifici di occultamento burocratico: per quanto si provveda a manipolare il numero dei disoccupati (in particolare tra il 1985 e il 1990, soprattutto nei paesi anglosassoni), esso viene risospinto nuovamente verso l’alto dall’impulso della razionalizzazione microelettronica. In termini assoluti è possibile constatare un incremento di lungo periodo dello zoccolo della disoccupazione. In Germania, dove l’asticella dei quattro milioni di disoccupati ufficiali è stata nel frattempo superata, il loro numero reale, secondo alcune stime, raggiungerebbe i sette milioni. Negli USA e nel Regno Unito il dato ufficiale andrebbe non solo raddoppiato ma addirittura triplicato o quadruplicato. L’economista statunitense Lester C. Thurow ci presenta un calcolo assai diverso da quello ufficiale:
La disoccupazione americana è come un iceberg: la parte più grossa se ne sta sott’acqua. Un tasso di disoccupazione pari a poco più del 5% equivale ad oltre sette milioni di disoccupati […] Ma accanto a questi disoccupati ufficiali ci sono altri sei milioni di persone che, se interrogate in proposito, si definirebbero tali. Ufficialmente però esse non lo sono perché non soddisfano questa o quest’altra condizione, magari perché la settimana precedente avrebbero dovuto impegnarsi attivamente nella ricerca di un lavoro. Ci sono poi 4,5 milioni di lavoratori part-time, che nondimeno preferirebbero di gran lunga lavorare a tempo pieno […] Otto milioni di americani lavorano solo occasionalmente. Altri due milioni solo in caso di chiamata da parte del datore di lavoro […] Nessuna di questi milioni di persone passa per essere disoccupata […] Inoltre quasi sei milioni di individui di sesso maschile tra i 25 e i 60 anni, rilevamenti alla mano, sono scomparsi nel nulla. Secondo i dati dell’ultimo censimento sono ancora vivi ma non compaiono più nelle statistiche del lavoro. Non lavorano, né sono disoccupati, non vanno a scuola, né se ne stanno in galera. Come si guadagnino da vivere (forse grazie ad attività illecite?) rimane un mistero […].21
In Gran Bretagna i metodi per la registrazione dei disoccupati sono cambiati non meno di tre volte a partire dal 1979 e la conseguenza è stata che l’esercito dei disoccupati sulla carta si è assottigliato regolarmente (Lütge 1997). E in Giappone, se valessero gli attuali criteri statistici (per quanto manipolati) dei paesi europei, risulterebbe disoccupata una quota tra il 10 e il 15% della popolazione attiva. Quanto siano sconclusionate queste stime lo dimostra anche la situazione della Spagna, il paese dell’Unione europea con la più elevata disoccupazione (una media di lungo periodo del 20-25%), in cui adesso però si sta festeggiando un «miracolo dell’occupazione», perché tale quota, secondo i metodi di rilevazione, è scesa al 18 o addirittura al 10,8%. Anche il tanto lodato «miracolo» olandese rivela un aspetto melanconico:
Gli esperti del mercato del lavoro che indagano sulla cosiddetta disoccupazione occulta sono giunti a risultati a dir poco agghiaccianti. Negli ultimi tempi ha fatto discutere uno studio della società di consulenza McKinsey. È l’Olanda il paese su cui stavolta si appuntano i sospetti. Secondo McKinsey il tasso di disoccupazione reale non coincide con quello ufficiale, pari al 6,3%, che certificherebbe uno straordinario progresso nella lotta alla disoccupazione, in quanto le persone in cerca di lavoro sarebbero circa il 20%. I ricercatori hanno incluso nei loro dati tutti coloro che, pur potendo e volendo lavorare, ufficialmente non stanno più cercando un lavoro. Tra di essi ci sono anche individui che, in passato, erano stati giudicati in grande stile come inidonei al lavoro e che adesso vengono considerati invalidi.22
È un dato di fatto: ovunque i posti di lavoro regolari nell’industria si sciolgono come neve al sole. Solo in Germania, secondo l’Ufficio statistico federale, il numero dei lavoratori nelle «attività produttive» è sceso tra il 1991 e il 1997 di circa tre milioni, dopo che già per tutti gli anni Ottanta la perdita dei posti di lavoro in questo settore fondamentale aveva conosciuto un rapido progresso. Se si tenesse conto anche del lavoro artigianale la riduzione nel settore industriale sarebbe ancora più drammatica. In fin dei conti se ne può trarre la seguente conclusione: il tasso di disoccupazione nei paesi industriali capitalistici – che all’inizio degli anni Ottanta, secondo Dahrendorf, era cresciuto fino al 10% – andrebbe raddoppiato in termini reali (cioè al netto di tutte le manipolazioni e di tutte le «dislocazioni» statistiche in altre categorie) fino a circa il 20%, mentre secondo i dati ufficiali esso risulta attestarsi nella maggior parte dei casi tra il 10 e il 15%.
In Germania l’incremento particolarmente drastico delle cifre assolute è da addebitare anche all’annessione della Repubblica Democratica Tedesca, il cui tracollo ha condotto a tassi di disoccupazione del 30% e oltre in molte città e regioni orientali. Questa circostanza viene abitualmente giudicata come un fattore speciale esterno, una zavorra ereditata del socialismo di Stato. Anche astraendo dall’aumento incessante del numero dei disoccupati nella vecchia Germania Occidentale, questa argomentazione difensiva risulta inconsistente per un’altra ragione. I regimi del capitalismo di Stato non rappresentavano affatto un sistema antagonista, tale da incarnare una società basata su principi differenti, postcapitalistica e già oltre il «lavoro astratto», ma solo una variante della «modernizzazione di recupero» nella periferia capitalistica; nel caso della RDT si trattò perfino di una sorta di aborto storico che vide l’assoggettamento antistorico ad un regime della periferia di una parte separata di un paese capitalisticamente già sviluppato (come risarcimento a carico della Germania, colpevole di avere scatenato il secondo conflitto mondiale). In gioco ci sono soltanto due differenti stadi di sviluppo e, in un certo senso, due diversi «stati di aggregazione» di un unico sistema della merce e, se lo si comprende, allora non si può che concludere che il crollo del capitalismo di Stato fu già un elemento della terza rivoluzione industriale, non un fattore esterno, una zavorra «estranea»; lo dimostra già il fatto che l’«apertura» nei confronti della variante occidentale più progredita, basata sulla concorrenza tra i capitali non ha affatto mitigato la crisi dei paesi dell’Est, che si è invece aggravata.
L’annessione della ex-RDT alla Germania Occidentale è pertanto un fenomeno peculiare perché con essa, in opposizione al decorso della crisi globale finora delineatosi, un’economia nazionale della periferia schiantata dalla terza rivoluzione industriale è stata integrata direttamente nello spazio economico interno di un paese capitalistico centrale. Questo processo inusitato ha fatto sì che la Repubblica Federale, come eredità della storia tedesca, si sia giustamente contaminata con la crisi molto più avanzata dei paesi periferici. Infatti il tramonto della RDT è certamente un capitolo del medesimo sviluppo che, a partire dagli anni Ottanta, non ha visto solo il collasso del sistema complessivo dell’industrializzazione di recupero, raggruppato attorno all’«economia sovietica», ma anche la rovina di vaste regioni del Terzo mondo in Asia, in America latina e soprattutto in Africa, afflitte dalle conseguenze della razionalizzazione microelettronica (con ripercussioni più tardive anche nei paesi del boom effimero del Sud-Est asiatico) in una misura comunque maggiore rispetto ai «signori del mercato mondiale» occidentali.
Ci si accorge così gradualmente di come quasi tutti i paesi della periferia capitalistica, la stragrande maggioranza dell’umanità, non siano più in grado di sostenere i costi della terza rivoluzione industriale – a meno di cadere nella trappola di un indebitamento estero senza speranza. In questi paesi la rivoluzione microelettronica non ha un effetto diretto, bensì indiretto, mediato dal mercato. Se nei paesi capitalistici centrali essa agisce sul livello delle singole imprese, nella periferia coinvolge intere economie nazionali, rovinate dall’assalto di una concorrenza equipaggiata con la microelettronica.
Pertanto la disoccupazione di massa strutturale è, da un lato, immediatamente tecnologica, causata dalla «razionalizzazione per riduzione» della forza-lavoro – come si può osservare soprattutto nei centri capitalistici, che sono ancora in grado di «esportare» almeno in parte il problema mediante la concorrenza sul mercato mondiale. Dall’altro però, per la medesima ragione, la nuova disoccupazione di massa è mediata dal mercato mondiale – cioè dal fallimento delle industrie che non possono giovarsi, oppure solo in misura estremamente modesta, degli aggregati microelettronici. È generalmente il caso dei paesi della periferia che non possono permettersi le tecnologie di automazione e controllo, le quali, nonostante la continua diminuzione dei loro costi, divengono addirittura sempre meno convenienti col passare del tempo; questo perché i prezzi delle merci che questi paesi esportano, da essi prodotte al di sotto dei nuovi standard di produttività, diminuiscono più rapidamente rispetto ai prezzi delle merci importate dai paesi centrali, malgrado anche questi ultimi si riducano a causa dello sviluppo delle forze produttive microelettroniche. Essi finiscono dunque nel vortice di un ciclo economico infernale, cui sanno reagire solo mediante lo sfruttamento estremo della loro forza-lavoro: la crisi della terza rivoluzione industriale sta avanzando nei paesi centrali, ma lo fa in modo relativamente più rapido nei paesi tradizionalmente poveri della periferia capitalistica, causando crolli periodici di intere economie nazionali.
Anche la disoccupazione strutturale di massa è corrispondentemente più elevata laddove le statistiche sono ancor meno significative che in Occidente. Intervengono infatti alcuni fattori temporaneamente sconosciuti nei paesi capitalistici sviluppati o il cui effetto non è granché rilevante. Ad esempio la «sottoccupazione», che è la condizione di coloro che non hanno un posto di lavoro regolare ma guadagnano sporadicamente qualche soldo sulla base di salari orari o giornalieri – di fatto si tratta di disoccupati – è assai più diffuso nel Terzo mondo che negli USA ed è ormai da tempo la normalità per la maggior parte della popolazione. Di conseguenza chi si trova ancora incluso nelle statistiche dei disoccupati, appartiene già a una minoranza privilegiata. Suona così semplicemente grottesco il fatto che un paese come il Brasile abbia annunciato per il 1997 un tasso di disoccupazione pari a solo il 5,7% e il Messico, per il 1998, una quota di disoccupati pari addirittura al 3,6%. In questi paesi, così come in tanti altri che non raccolgono neppure più i dati sulla disoccupazione, la grande maggioranza delle persone appartiene agli «esclusi», che sono stranieri nel loro stesso paese:
Per molti paesi poveri non abbiamo a disposizione alcun dato oppure le statistiche riguardano solo un settore relativamente esiguo dell’economia, le città o anche solo la capitale.23
Laddove la manipolazione dei dati non è così sfacciata oppure valgono le stime delle organizzazioni indipendenti, il livello della disoccupazione aumenta fino a un punto che equivale di fatto al crollo totale del sistema: il suo valore in Afghanistan è pari al 90%, in Mozambico al 50%, in Sudafrica al 45%, nella Jugoslavia tra il 40 e il 50%, in Giordania al 40%, in Algeria e in Libano al 35% etc. (tutti i dati in: Kidron/Segal 1997; Almanacco mondiale Fischer 1999). Nel caso della Cina, che ha dichiarato per il 1997 un tasso di disoccupazione ufficiale pari al 4%, valutazioni indipendente parlano invece di un tasso reale del 30%. Questa la conclusione di uno studio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di Ginevra verso la metà degli anni Novanta:
All’inizio del 1994, sulla scia della peggiore crisi dei mercati del lavoro dalla depressione degli anni Trenta, c’erano in tutto il mondo 820 milioni di persone, cioè il 30% dell’intera forza-lavoro, prive di un’occupazione (cit. da Handelsblatt, 7/3/1994).
Questa stima include anche i paesi centrali del capitalismo, di conseguenza tasso di disoccupazione del 30% è un riflesso della situazione globale – alla luce delle valutazioni comunque sempre prudenti dell’OIL. Nel 1999 c’erano perlomeno un miliardo di persone in tutto il mondo da ritenere disoccupate (Handelsblatt, 15/3/1999). Durante la crisi del 1997/1998, solo nel Sud-est asiatico, ancora una volta secondo i dati dell’OIL, sono andati persi definitivamente 24 milioni di posti di lavoro. Si aggiunga inoltre il fenomeno delle cosiddette «industrie fantasma» che coinvolge vaste regioni del globo, soprattutto nei paesi dell’ex-blocco orientale, in Cina, a Cuba, nella ex-Jugoslavia etc. Si tratta generalmente di industrie statali della ex-«modernizzazione di recupero» non ancora dismesse, che «occupano» ancora formalmente parecchi milioni di persone ma che in realtà, sul piano economico, sono solo dei «morti che camminano». La produzione di queste imprese è solo saltuaria, la retribuzione sporadica o inesistente, senza contare che talvolta gli «occupati» vengono retribuiti in natura:
La sempre più grave insolvenza delle imprese private e statali in Russia ha fatto sì che la cifra relativa al mancato pagamento di stipendi e di pensioni arretrate, senza dimenticare i debiti nei confronti dei fornitori, ammonti a circa 26 miliardi di marchi. Sempre più imprese sono costrette a retribuire in natura dipendenti e pensionati: fabbricanti di ceramiche pagano con vasellame, industrie dolciarie con qualche chilo di cioccolato, case editrici con cataste di libri. Attualmente alcune imprese di Kursk erogano la pensione sotto forma di cereali e porcellini vivi. Talvolta i lavoratori organizzano la vendita sulla strada di questi surrogati del salario, spesso a grande distanza dal luogo di produzione, così da ottenere denaro contante. Finora non ha riscosso molto successo l’iniziativa di un’impresa di Volgograd, che da tre anni distribuisce ai propri collaboratori come salario mensile (pari a circa 42 marchi) una media di otto reggiseni. Tali prodotti, non particolarmente appetibili, vengono anche elargiti come sussidio materiale in caso di nascita o di morte […] (Der Spiegel, 8/1997).
Naturalmente si tratta unicamente di fenomeni transitori in attesa che queste imprese chiudano una volta per tutte. Non si potrà negare più a lungo il fatto che la maggioranza della popolazione mondiale è già stata messa alla porta dal capitalismo – quindi anche dalla società ufficiale – e si limita pertanto a vegetare. Miliardi di uomini vengono rigettati in una miserabile economia di sussistenza su base famigliare, in gran parte esclusi dalle forze produttive moderne, amministrate nella forma capitalistica.
Come risultato complessivo non si può che concludere che la terza rivoluzione industriale nel giro di circa due decenni ha scatenato la crisi mondiale più terribile dal 1929. Mentre nei paesi centrali del capitalismo la disoccupazione di massa – un problema che si credeva definitivamente superato – bussa di nuovo alla porta, nella periferia, in molti paesi, si è già verificato il collasso, oltre che del «lavoro astratto», anche dell’economia monetaria. Ma tutto questo non esaurisce affatto il potenziale di automazione e di razionalizzazione della microelettronica. La «liquidazione razionalizzatrice» della forza-lavoro umana dal processo produttivo capitalistico, iniziata alla fine degli anni Settanta, proseguirà anche nei decenni a venire. Questo processo si perfeziona in una successione di impulsi, interrotti solo dalla riduzione del costo della forza-lavoro da problemi tecnologici di interfaccia. Da un lato l’automazione continua a progredire con ogni nuova generazione di microchip e di sviluppi del software, subendo una nuova accelerazione nella seconda metà degli anni Novanta:
Negli ultimi anni l’automazione si è conquistata un ruolo sempre più importante per le imprese produttive […] Nella fase di montaggio si è consolidato l’utilizzo di piccoli robot a basso costo, mediante cui è possibile automatizzare a dovere le prestazioni più semplici […] La tendenza verso l’automazione è stata incoraggiata anche dalla diminuzione del prezzo dei componenti. Negli ultimi tempi, ad esempio, il costo dei robot industriali si è ridotto addirittura del 40% ed anche la qualità delle loro prestazioni è migliorata rispetto ai modelli più vecchi grazie alla tecnologia di direzione, a sensori e ad interfacce di controllo. Il campo di applicazione dei robot industriali si fa sempre più esteso, la tecnologia robotica fa progressivamente breccia anche in settori che fino ad oggi non erano reputati centrali per gli sforzi di automazione, l’industria del mobile, l’edilizia o perfino la tecnologia medica […].24
Dall’altro, grazie all’ausilio della microelettronica e dei nuovi programmi software, si rafforza anche la razionalizzazione organizzativa. In quest’ambito non si verifica neppure l’automazione di determinate attività e di interi livelli di impresa, dalla pianificazione della produzione fino al marketing, perché essi divengono addirittura superflui grazie alle nuove forme di organizzazione integrate con l’elettronica. E questa progressiva avanzata dell’automazione e della razionalizzazione avrà naturalmente come conseguenza anche il tracollo indiretto, mediato dal mercato mondiale, dei mercati del lavoro della periferia.
Sebbene le istituzioni ufficiali continuino ovviamente a negarlo, si profila all’orizzonte una nuova crisi sistemica, che promette di oscurare tutte le precedenti fasi catastrofiche di trasformazione dall’inizio dell’industrializzazione. È pertanto impossibile eludere la questione circa la qualità peculiare che distingue la terza rivoluzione industriale dalle altre due. Essa consiste, come si evidenzia con sempre maggiore chiarezza, in una sorta di mobilitazione finale della contraddizione intrinseca del capitalismo. Il meccanismo di compensazione che era entrato in azione durante la prima e la seconda rivoluzione industriale, dopo pesanti crisi di trasformazione, cessa di funzionare nonostante tutte le invocazioni.
Certo, anche questa volta possiamo constatare la diminuzione progressiva dei costi della nuova tecnologia microelettronica di base e dei suoi prodotti. Elevate capacità di calcolo – fino a pochi decenni fa prerogativa esclusiva del capitale delle grandi imprese o delle istituzioni statali – adesso vengono regalate ai bambini per Natale sotto forma di videogame di ogni sorta. Il personal computer – che all’inizio degli anni Ottanta era ancora un mezzo di produzione relativamente costoso – è ormai entrato da tempo nel consumo di massa. Ma è del tutto assente un effetto sull’accumulazione e sull’«occupazione» che sia analogo a quello del fordismo. Questo perché la microelettronica, nel complesso, rende superfluo più «lavoro astratto» di quanto non ne generi di nuovo la riduzione del costo dei suoi prodotti e la relativa espansione dei mercati. La principale causa consiste nel fatto che il potenziale razionalizzatore della microelettronica è assai superiore a quello della catena di montaggio fordista e che la microelettronica può essere sfruttata universalmente: essa è in grado di razionalizzare già a priori la sua stessa produzione.
Il rapporto tra innovazione di prodotto ed innovazione di processo si è rovesciato: l’introduzione di nuovi prodotti nel consumo di massa viene sovrastata dalla forza della «razionalizzazione per eliminazione». In questo modo il già precario sistema a palla di neve industriale va incontro irreversibilmente alla sua fine. La prima rivoluzione industriale aveva condotto alla rovina soprattutto i produttori artigianali indipendenti, condannandoli in massa alla «disoccupazione», per poi integrarli gradualmente nel sistema di fabbrica in infime condizioni di esistenza. La seconda rivoluzione industriale era stata la causa della prima grande frattura sul terreno del capitale industriale con la crisi economica mondiale, per poi imporre nel dopoguerra il capitalismo integrale grazie al sostegno keynesiano. Nella terza rivoluzione industriale il capitalismo licenzia i suoi figli. Il sistema globale di trasformazione cibernetica dell’energia umana in denaro si converte una volta per tutte in un’impresa folle. La profonda irrazionalità di questo modo di produzione si può toccare con mano e diviene completamente insostenibile – proprio nel momento in cui, paradossalmente, lo si dichiara privo di alternative e destinato al contempo a determinare per sempre il futuro dell’umanità.
(Traduzione dal tedesco di Samuele Cerea)
—–
Note:
1.Nell’originale Die Wegrationalisierung des Menschen; il termine Wegrationalisierung nel gergo economico indica un processo di razionalizzazione aziendale basato sulla riduzione del personale e quindi sull’eliminazione della forza-lavoro.
2.Hans-Joachim Flechtner, Grundbegriffe der Kybernetik. Eine Einführung, Monaco, 1984, p. 1, 6 e ss.
3.Wolfgang Coy, Industrieroboter. Zur Archäologie der zweiten Schöpfung, Berlino, 1995, p. 47.
4.Ibidem, p. 31.
5.Ibidem, p. 30 e ss.
6.Ibidem, p. 63.
7.Jost Halfmann, Die Entstehung der Mikroelektronik. Zur Produktion technischen Fortschritts, Francoforte/New York, p. 60.
8.Walther P. Reuther, Automation und die Politik der Gewerkschaften in Automation. Risiko und Chance. Band II. Beiträge zur zweiten internationalen Arbeitstagung der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland über Rationalisierung, Automatisierung und technischen Fortschritt, Francoforte, pp. 1078 e ss.
9.Coy, op. cit., p. 64.
10.Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen Band II. Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution; tr.it L’uomo è antiquato. 2. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 87 e ss. Trad. di Maria Adelaide Mori.
11.Ibidem, p. 98.
12.Ralf Dahrendorf, Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht in Joachim Mattes (a cura di), Krise der Arbeitsgesellschaft? XXI Deutscher Soziologentag, Opladen, pp. 25 e ss.
13.Dahrendorf (1983), p. 34.
14.Ibidem, p. 34.
15.Anders, op. cit., p. 89.
16.La Konjunkturtheorie è una teoria del ciclo economico elaborata nel 1937 dall’economista austriaco Gottfried Hberler [N.d.T]
17.Joseph Huber, Modell und Theorie der langen Wellen. Kleine Forschungsgeschichte mit gemischten Ausblicken in Martin Jänicke (a cura di), Vor uns die goldenen neunziger Jahre? Langzeitprognose auf dem Prüfstand, Monaco/Zurigo, p. 67 e ss.
18.Ibidem, p. 71.
19.Anders, op. cit. p. 89.
20.Michael Kidron e Ronald Segal, Der Fischer Atlas zur Lage der Welt. Globale Trends auf einen Blick, Francoforte sul Meno, 1996.
21.Lester Thurow, Die Illusion vom Jobwunder. Viele Arbeitslose werden von Amts wegen gar nicht registriert, in Die Zeit, 44/1996.
22.Gunhild Lütge, Die Wunder der Statistik. Ein Vergleich der nationalen Arbeitslosenquoten führt in die Irre, in Die Zeit 47/1997.
23.Kidron/Segal, op cit.
24.Jens Neugebauer, Roboter sind billiger geworden und bieten deutlich mehr. Die
ROBERT KURZ
Robert Kurz (1943-2012). Ha sviluppato una critica radicale della modernità e una nuova teoria della crisi mondiale attraverso l’analisi del sistema globale del capitalismo. Le sue teorie sono state pubblicate sulle riviste teoriche “Krisis” e “Exit!” e in numerosi libri. Di Kurz sono apparsi in Italia “La fine della politica e l’apoteosi del denaro”, “L’onore perduto del lavoro”, il “Manifesto contro il lavoro”, “Ragione sanguinaria” e “Il collasso della modernizzazione”.