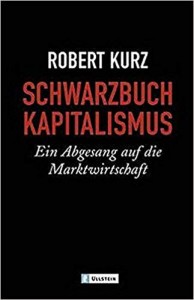La storia della terza rivoluzione industriale 1.
mar 20th, 2019 | Di Thomas Munzner | Categoria: Capitale e lavoroLa storia della terza rivoluzione industriale
1. Visioni dell’automazione
di Robert Kurz
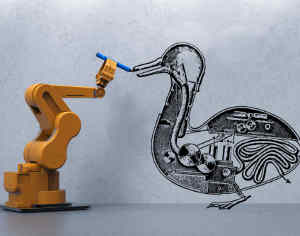
Iniziamo qui la pubblicazione della sezione VIII di uno dei libri più famosi di Robert Kurz, lo Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”). Questa sezione tratta della storia della cosiddetta terza rivoluzione industriale, l’epoca in cui il capitalismo si fa informatico e cibernetico. In questo momento storico, che è quello che stiamo vivendo, la forza lavoro umana perde il suo ruolo centrale diventando di fatto comprimaria di una svolta epocale in cui il capitale raggiunge i suoi limiti e pone il mondo e tutti noi di fronte ad una decisione molto difficile ma non rimandabile: prendere sul serio la possibilità (forse dovremmo dire la necessità) del suo superamento. L’alternativa è che ad essere superati si sia noi come esseri umani, e con noi il mondo.
Partiamo con il primo capitolo, “Visioni dell’automazione”. A breve seguiranno gli altri otto. Tutto questo dovrebbe preludere alla pubblicazione cartacea dell’intero libro, che auspichiamo avvenga nel minor tempo possibile [redazione].
* * * *
Ormai giunto all’ultimo terzo del XX secolo il capitalismo aveva già dimostrato a sufficienza di quale maestria fosse in grado nell’arte di addestrare gli uomini, fino a che punto esso fosse riuscito nell’impresa di trasformare la maschera delle sue forme feticistiche nel volto del mondo materiale e persino di gran parte del mondo naturale, nonché a spingere verso la negazione di sé grandi masse umane. Ma neppure questa straordinaria prestazione poté mai ammutolire del tutto il disagio elementare, che è fondamentalmente insito nell’autocontraddizione logica di questo modo di produzione e di vita. La fede nel progresso si era già esaurita nel XIX secolo (anche se da allora il suo fantasma viene regolarmente invocato dagli ottimisti di professione e dagli imbonitori del capitalismo per sdrammatizzare la crisi) e il soggetto borghese-illuministico aveva tolto il disturbo, al più tardi con la Prima guerra mondiale, per lasciare il posto ai rituali sado-masochistici del sacrificio di sé in un processo sociale considerato impossibile da governare e tuttavia gli uomini del dopoguerra fordista, degradati a mera materia prima, potevano ancora anestetizzarsi mediante la scialba ebbrezza del consumo.
Ma quando giunsero – e più rapidamente del previsto – i limiti del miracolo economico, la coscienza sociale, in virtù del grandioso ottenebramento che aveva colpito trasversalmente tutti i settori teorici e politici, poté reagire solo mediante la rimozione e la dissimulazione.
A partire dai tardi anni Sessanta il disagio della cultura fordista di massa fu certamente il segnale, già in una fase precoce, che la ricreazione era finita, anche nei centri occidentali; esso però non ebbe alcun seguito, non seppe consolidarsi in una nuova critica radicale. Sulle teste gravava il peso mostruoso di quasi tre secoli di modernizzazione e i nuovi movimenti sociali dal 1968, cui mai riuscì di penetrare il nucleo del feticismo moderno, si rivelarono compatibili con il capitalismo perlomeno quanto il vecchio movimento operaio. Non c’è da meravigliarsi che la società globale delle democrazie totalitarie del mercato globale, formatasi nella seconda metà del secolo, iniziasse a correre in modo cieco e afasico verso la propria fine.
Persino le «utopie negative» letterarie, così prodighe di ammonimenti e foriere di cattivi presagi, non furono più di alcuna utilità. Nel complesso la loro interpretazione degli «Stati del lavoro» fordisti appariva insufficiente poiché si concentrava, in ultima analisi, solo sugli elementi del totalitarismo politico; di conseguenza il valore delle relative previsioni si esaurì definitivamente con la fine della prosperità del dopoguerra. Questo pessimismo storico non fu sostanzialmente in grado di cogliere la crisi della fine del Novecento, che rimaneva ancora avvolta dalle nebbie del futuro. In effetti le utopie negative si limitarono a prolungare in maniera fantasmagorica un fordismo le cui forze produttive regolamentate garantivano la sussistenza di individui istupiditi dal consumismo; non vi fu timore legato al capitalismo burocraticamente perfezionato che esse non seppero prevedere, tranne uno: la fine del consumo, il ritorno della povertà di massa e della fame prodotta dalla società stessa.
«Senza sicurezza economica – scrisse da buon liberale Aldous Huxley, nella prefazione alla nuova edizione del suo Mondo nuovo – è impossibile che sorga l’amore per la schiavitù; per ragioni di concisione ritengo che gli onnipotenti esecutivi e i loro manager riusciranno a risolvere il problema di una sicurezza economica duratura».1 Ma proprio perciò questo genere di immagini distopiche non risultò ancora abbastanza cupo: tutte quante prendevano le mosse dal lavaggio del cervello da parte dello Stato e dalla manipolazione quasi fisiologica attuata dai suoi apparati totalitari, senza riconoscere la vera essenza e i limiti interni della macchina-mondo. Né tantomeno seppero individuare il nucleo della soggettività competitiva negli individui, che, nella crisi, sarebbe stato in grado di scatenare vere e proprie orge di esclusione sociale e di violenza endemica, invece di favorire il funzionamento mansueto, silenzioso e senza attriti di un’omogenea massa unitaria. Questa omogeneità caratterizza precisamente la concorrenza totale tra gli individui astratti, che include l’odio degli schiavi dei mercati anonimi nei confronti di se stessi, inevitabilmente proiettato, durante la crisi, verso l’esterno, contro gli «altri».
Esiste una ragione semplice per la miopia storica delle distopie fordiste e di quelle che le precedettero: hanno tutte come presupposto cieco il sistema del «lavoro astratto», concepito come un meccanismo funzionale e riproduttivo quasi «naturale». Il comando degli apparati di manipolazione fa sempre riferimento alla forma di attività della macchina-mondo produttrice di merce, in cui esiste perlomeno una cosa che sembra essere eterna: la necessità sociale del dispendio massiccio di forza lavoro. È da questo presupposto che si originano tutte le descrizioni orrorifiche di una vita mutilata in maniera meccanica: l’uomo come aggregato del «lavoro» degradato a robot. Anche nell’opera di Huxley, che pure sottolinea il rovescio consumistico a base di panem et circenses, esistono pur sempre «lavoratori» modellati su criteri funzionali, funzionalmente conformati allo stadio embrionale e, infine, «travasati»:
Uomini e donne tipificati, a infornate uniformi. Tutto il personale di un piccolo stabilimento costituito dal prodotto di un unico uovo bokanovskificato. «Novantasei gemelli identici che lavorano a novantasei macchine identiche!» […] Milioni di gemelli identici. Il principio della produzione di massa applicato finalmente alla biologia […] «I lavoratori tropicali cominciano a subire le inoculazioni al centocinquantesimo metro» […] «Gli embrioni hanno ancora le branchie. Noi immunizziamo il pesce contro le malattie dell’uomo futuro» […] Sulla rastrelliera 10, file intere della futura generazioni di lavoratori chimici venivano allenate a tollerare il piombo, la soda caustica, il catrame, il cloro. Il primo embrione di un gruppo di duecentocinquanta meccanici di aeroplani-razzo stava passando al 1100° metro della rastrelliera 3 […] «E ora […] vorrei mostrarvi una cosa molto interessante: il condizionatore per ottenere Intellettuali Alfa-Plus. Ne abbiamo un bel numero sulla rastrelliera 5. Prima Galleria» […] «Non si può veramente effettuare nessun condizionamento intellettuale utile, prima che i feti abbiano perduto la coda».2
Questa cieca proiezione futuristica del sistema del «lavoro» astratto venne condotta fino alle sue più estreme conseguenze in un altro celebre romanzo distopico, pubblicato già nel 1895 da H. G. Wells, l’autore della «guerra dei mondi». Ne La macchina del tempo, un’opera che ebbe un successo pari a quello della vicenda dell’attacco marziano, egli sfrutta l’idea del viaggio nel tempo (in quegli anni concepito naturalmente come orientato in maniera univoca al futuro) per prolungare il capitalismo vittoriano a fini di critica sociale fino al suo stadio terminale, quello della degenerazione totale. Nel lontanissimo futuro dell’anno 802.701 il suo viaggiatore temporale si imbatte in una società suddivisa come mai in passato tra fannulloni «inoperosi» e «lavoratori». Sulla superficie del pianeta vivono gli «Eloi», giovani di bell’aspetto e spensierati ma sciocchi e «inutili», discendenti dei capitalisti di un tempo. Nelle città-industrie sotterranee dimorano invece i «Morlocchi», i discendenti degli operai del passato, in quanto già alla fine del XIX secolo era invalsa la «tendenza a utilizzare lo spazio sotterraneo per gli scopi meno ornamentali della civilizzazione» (Wells 1895).3 Ma dopo un periodo di tempo così lungo entrambe le classi erano ormai entrate nella fase della loro decadenza e si era consumata una singolare inversione del loro rapporto:
I miei ospiti del mondo superiore dovevano avere rappresentato, un tempo, l’aristocrazia della razza umana, e i Morlocchi i loro servitori meccanici; ma ormai tutto ciò apparteneva al passato. Le due specie derivate dall’evoluzione dell’uomo stavano scivolando verso nuovi reciproci rapporti, e forse inconsciamente questi rapporti si erano già stabiliti. Gli Eloi, come i re Carolingi erano ormai ridotti a una semplice espressione di vana bellezza; erano ancora padroni della superficie terrestre unicamente perché i Morlocchi, esseri sotterranei da innumerevoli generazioni, non sopportavano la luce del giorno; costoro, concludevo, preparavano gli abiti degli Eloi e provvedevano ai loro quotidiani bisogni, per la vecchia, innata abitudine di servire gli altri, forse. Anche i cavalli continuano, ai nostri giorni, a raspare il terreno con gli zoccoli […] Ma senza dubbio il remoto ordine di cose era già, almeno in parte, invertito; la Nemesi stava rapidamente insinuandosi nel destino della razza più delicata: in epoche trascorse, migliaia di generazioni prima, l’uomo aveva privato il suo fratello degli agi e della vista del sole; adesso questo fratello compiva la strada inversa, e come mutato! Gli Eloi avevano già cominciato di nuovo a imparare una vecchia lezione, facevano di nuovo conoscenza della paura. Proprio in quel momento mi ricordai del pezzo di carne che avevo visto sul tavolo nel mondo inferiore […] Questi Eloi non erano che bestiame ingrassato che i Morlocchi formiche custodivano per poi impadronirsene, e di cui probabilmente sorvegliavano anche la riproduzione.4
Ma anche questa arguta invenzione, l’idea di un «cannibalismo di rappresaglia» post-storico, non può comunque occultare la circostanza per cui questo futuro negativo viene pur sempre immaginato come un prolungamento del «lavoro» e giudicato nella prospettiva dello «sfruttamento» astratto. Il sistema del dispendio meccanico di «nervo, muscolo e cervello», fine a se stesso, non viene superato ma sopravvive in una forma degenerata. Evidentemente gli autori di questa critica in forme letterarie avevano dimenticato quale fosse, in ultima istanza, l’autentico problema logico del capitalismo, la sua inestricabile contraddizione interna, oppure ritenevano – è il caso di Huxley – che essa fosse stata risolta positivamente, sebbene la crisi economica mondiale fosse lì a dimostrare l’esatto contrario. Per quanto possa sembrare curioso la crisi economica non trova posto nelle utopie negative, diversamente dallo «Stato del lavoro» totalitario, con la sua presunta onnipotenza.
Visioni dell’automazione
Ovviamente i creatori delle distopie negative, così come i «pratici» del management, conoscevano perfettamente la tendenza strisciante verso la sostituzione tecnologica della forza-lavoro. Perfino il sogno dell’automazione totale era già stata preconizzata da tempo. Quest’ultima idea, tuttavia, non venne percepita come un fatto assolutamente negativo, per quanto la sua realizzazione sembrasse collocarsi in un lontano futuro. Nel 1908 Walther Rathenau fece questa osservazione estemporanea:
Una fabbrica ideale dovrebbe funzionare in maniera automatica come un gigantesco meccanismo, con un unico operaio come sorvegliante. L’industria pesante e la chimica industriale sono prossime a questo stadio. Questo operaio-sorvegliante svolgerà esclusivamente un lavoro intellettuale, assumendosi una responsabilità assai gravosa […] l’imprenditore […] ha tutto l’interesse a provvedere che quest’uomo sia ben nutrito, abbia tempo libero per riflettere, sia soddisfatto e di buon umore.5
Ma l’idillio armonicistico che Rathenau coltiva qui si riferisce solo agli «imprenditori» e ai loro unici lavoratori residui; stranamente non affiora la questione circa l’esito di questa situazione se essa si generalizzasse e se i «lavoratori soddisfatti» assieme con il loro «buon umore» si fossero ridotti ad una sparuta pattuglia mentre il grosso dei lavoratori venisse espulso dalla riproduzione sociale come una scoria residua di «superflui» del capitalismo.
Anche in seguito, mentre Henry Ford furoreggiava con la seconda rivoluzione industriale, aleggiò pur sempre la certezza implicita che, nonostante la razionalizzazione operata dalla catena di montaggio e dalla «scienza del lavoro» taylorista, la forza-lavoro umana non sarebbe mai davvero scomparsa su larga scala. Non c’è dubbio: durante la crisi economica mondiale la disoccupazione di massa venne messa in relazione (spesso in tono accusatorio per scopi di agitazione) con i nuovi processi tecnici. Ma l’idea che la crisi del capitalismo potesse assumere le sembianze di una crisi fondamentale della «società del lavoro» e quindi del «lavoro astratto» superava di gran lunga l’immaginazione dei contemporanei.
Ma sul piano logico si trattava di un’idea del tutto verosimile: una volta che l’uomo delle industrie fordiste era stato trasformato in un automa, sarebbe bastato solo qualche passo in avanti nello sviluppo per sostituirlo con un vero automa. Per quanto possa sembrare strano i creatori delle utopie negative non avevano previsto questa possibilità oppure, in ogni caso, non seppero intuire il suo dirompente effetto sociale, preferendo associare il loro pessimismo storico ad altri problemi. Ma ancora più sorprendente è l’ottimismo dimostrato da quei pochi teorici che, volgendo lo sguardo al futuro, compresero che il fordismo era indubbiamente solo lo stadio preliminare di un processo di automazione fino a quel momento ritenuto impossibile.
Anche Keynes apparteneva al numero di questi ottimisti storici della terza rivoluzione industriale, ancora nascosta nel grembo del futuro ma destinata presto o tardi a cancellare il fordismo. Nel 1930 Keynes, ancora nel bel mezzo della seconda rivoluzione industriale, si dilungò in maniera frivola circa le «possibilità economiche dei nostri nipoti», nonostante il tenore critico con cui attacca la sua argomentazione:
Noi abbiamo invece contratto un morbo di cui forse il lettore non conosce ancora il nome, ma del quale sentirà molto parlare negli anni a venire – la disoccupazione tecnologica. Scopriamo sempre nuovi sistemi per risparmiare forza lavoro, e lo scopriamo troppo in fretta per riuscire a ricollocare quella forza lavoro altrove. Ma si tratta di uno scompenso temporaneo. Nel lungo periodo, l’umanità è destinata a risolvere tutti i problemi di carattere economico. Mi spingo a prevedere che di qui a cento anni il tenore di vita nei paesi avanzati sarà fra le quattro e le otto volte superiore a quello attuale. Alla luce delle nostre conoscenze attuali, è il meno che si possa dire. E immaginare una crescita anche più significativa non sarebbe un azzardo […] La conclusione è che, in assenza di conflitti drammatici, o di drammatici incrementi della popolazione, fra cento anni, il problema economico sarà risolto, o almeno sarà prossimo a una soluzione. In altre parole, se guardiamo al futuro l’economia non si presenta come un problema permanente della nostra specie. Ma perché addirittura sbalordirsi, vi chiederete. Bè, perché se per un attimo ci rivolgiamo al passato, anziché al futuro, il problema dell’economia, della lotta per la sopravvivenza, è sempre stato il problema fondamentale, e il più pressante che la nostra specie – e non solo la nostra, ma tutte le specie viventi, fin dall’alba della storia – si sia trovata a dover affrontare. In un certo senso, ci siamo evoluti – e con noi le nostre pulsioni, e i nostri istinti più profondi – per risolvere il problema economico, e una volta che questo fosse risolto, l’umanità si ritroverebbe priva del suo obiettivo più tradizionale. Sarebbe un bene? Per chi crede ai veri valori della vita, forse sì. Anche se, personalmente, l’idea che l’uomo medio debba cambiare abitudini e istinti in pochi decenni, abbandonando quelli accumulati da generazioni, un po’ mi inquieta. Per usare il linguaggio dei giorni nostri, non rischiamo un «esaurimento nervoso»? […] Insomma per la prima volta dalla creazione l’uomo si troverà ad affrontare il problema più serio, e meno transitorio – come sfruttare la libertà dalle pressioni economiche, come occupare il tempo che la tecnica e gli interessi composti gli avranno regalato, come vivere in modo saggio, piacevole, salutare […] Eppure nessun paese, e nessun popolo, può guardare alla prospettiva di questa età dell’oro senza un filo di apprensione. Da troppo tempo ci alleniamo a combattere, non a divertirci. Per l’uomo medio, che non ha particolari talenti e nemmeno radici nella terra, o nelle venerate convenzioni di una società tradizionale, tenersi occupato rappresenta un problema tremendo […] Turni di tre ore, o settimane di quindici, potranno procrastinare per un po’ il problema. Tre ore al giorno dovrebbero senz’altro bastare per placare l’Adamo […] Saremo finalmente in grado di buttare alle ortiche molti pseudo-principi che ci affliggono da duecento anni, e che ci hanno spinto a far passare alcune fra le più ripugnanti virtù umane per virtù eccelse […].6
C’è di che restare increduli: nel rapporto tra potenzialità dell’automazione e «disoccupazione tecnologica» il grande economista borghese Keynes riesce a cogliere solo un problema di natura culturale e psicologica: la questione se le masse «liberate» dalla vaticinata terza rivoluzione industriale saranno in grado di vedersela assennatamente con un ozio scevro da preoccupazioni, che verrà donato loro dallo sviluppo capitalistico. Un’argomentazione pressoché analoga, sebbene in una formulazione sostanzialmente più critica, venne presentata 28 anni più tardi dalla filosofa americana Hannah Arendt nella sua opera Vita Activa:
[…] forse altrettanto decisivo, è un altro evento non meno temibile, l’avvento dell’automazione, che in pochi decenni vuoterà probabilmente le fabbriche e libererà il genere umano dal suo più antico e più naturale fardello, il giogo del lavoro e la schiavitù della necessità. Anche qui, è in gioco un aspetto fondamentale della condizione umana, ma la ribellione contro di esso e il desiderio di essere liberati dalla «fatica e dell’affanno» del lavoro non sono moderni ma vecchi come una storia che ci è stata tramandata […] Può sembrare che il progresso scientifico e l’evoluzione della tecnica siano stati impiegati solo per conseguire ciò che tutte le generazioni passate avevano sognato senza poterlo realizzare. Tuttavia è così solo in apparenza. L’età moderna ha comportato anche una glorificazione teoretica del lavoro, e di fatto è sfociata in una trasformazione dell’intera società in una società di lavoro. La realizzazione del desiderio, però, come avviene nella fiabe, giunge al momento in cui può essere solo una delusione. È una società di lavoratori quella che sta per essere liberata dalle pastoie del lavoro, ed è una società che non conosce più quelle attività superiori e più significative in nome delle quali tale libertà meriterebbe di essere conquistata […] Ci troviamo di fronte alla prospettiva di una società di lavoratori senza lavoro, privati cioè della sola attività rimasta loro. Certamente non potrebbe esserci niente di peggio.7
Evidentemente gli ideologi del capitalismo conoscono molto male il loro stesso sistema. Soprattutto perché lo presuppongono alla stregua di un assioma e lo destoricizzano, servendosi delle categorie sovrastoriche e ontologiche dell’economia; fu per questa ragione Keynes che non fu in grado di giudicare i problemi da lui analizzati come il risultato di un processo di sviluppo irreversibile invece che come «casi possibili» di una forma sociale atemporale. Tuttavia Marx Karlsi rende perlomeno conto del fatto che la glorificazione del lavoro ebbe inizio solo nel XVII secolo mentre Keynes identifica invece, ancora una volta, il famigerato «problema economico», ossia il sistema delle vessazioni capitalistiche, con una «condizione di natura» generale che costringerebbe tutte le specie viventi, fin dall’alba della storia», ad affannarsi in ossequio ai criteri capitalistici dell’autoconservazione (ma è la pigrizia a caratterizzare di fatto le specie animali visto che la loro «autoconservazione», in realtà, non si fonda affatto su di un’attività incessante e fine a se stessa).
Per giunta Keynes non fa che ripetere in maniera insulsa la vecchia bugia liberale secondo cui l’economia di mercato avrebbe originato un incremento permanente del benessere, di cui però la maggior parte dell’umanità non ha mai goduto in prima persona. Di conseguenza la superfluità del lavoro degli anni a venire gli appare solo come un ulteriore miglioramento del tenore di vita, obiettivo verso cui sembrano tendere da sempre la «tecnica» e gli «interessi composti». Sembra proprio convinto che l’imminente obsolescenza del «lavoro», sul piano economico, rappresenti solo un piccolo problema di adattamento in seno all’ordine sociale esistente quando invece la fine del «problema economico» in realtà coincide proprio con la fine del capitalismo. Credeva seriamente Keynes che il sistema si sarebbe limitato a congedare il proprio materiale umano, lasciandolo dormire sonni tranquilli?
Va detto però che non è il caso di sottovalutare l’interiorizzazione della disciplina del lavoro in quanto problema psicologico e culturale alla luce del fatto che il sistema del «lavoro astratto» si sta convertendo in un’assurdità pura e semplice. D’altro canto il problema dell’«occupazione» non sarebbe poi così tremendo se sotto questa etichetta non si indicasse più l’attività alienata al servizio del fine-in-sé della «bella macchina». La sorte dell’uomo «disoccupato» in senso capitalistico, che se ne sta alla finestra con un’aria inebetita fino a quando la morte non lo redime dalle sue tribolazioni, è piuttosto frequente per le carcasse spossate di coloro che, dopo una macinazione aziendale durata tutta una vita, raggiungono finalmente i limiti di età; tuttavia, ad onta di tutti i condizionamenti sono davvero pochi quelli che si dimostrano così congenitamente e inossidabilmente ottusi da precipitarsi a «lavorare» perché altrimenti non saprebbero che fare di se stessi. La schiavitù volontaria sotto il giogo dei mercati anonimi ha sempre la sua motivazione fondamentale nella «costrizione muta dei rapporti» (Marx), che deruba gli uomini di tutte le risorse di cui potrebbero disporre e di tutte le relazioni sociali, costringendoli ad assoggettarsi ad una forma di attività disprezzata, pena l’esclusione dai fondamenti della propria esistenza.
Inoltre ciò che viene interiorizzato non è il «lavoro astratto» come tale ma la forma generale di relazione basata sul «guadagno di denaro» e sulla concorrenza, che ne è un derivato. Pertanto il disorientamento culturale dell’uomo nell’obsolescenza del «lavoro astratto» costituisce solo un problema collaterale perché il problema vero consiste nell’espulsione degli individui durevolmente e strutturalmente «superflui» dal sistema del «guadagno monetario» e della concorrenza, che però rimane pur sempre la condizione della loro esistenza. Keynes e Arendt disconoscono completamente la circostanza per cui la razionalità aziendale è fondamentalmente incapace di tradurre l’automazione in una diminuzione corrispondente del «lavoro astratto» (per Keynes fino a quindici ore settimanali – e anche qui solo per ragioni terapeutiche!). Questo abbaglio colossale dipende dal fatto che la cecità ideologica liberale fa derivare la moderna costrizione al lavoro dalla necessità «naturale» dell’accrescimento del benessere materiale concreto invece che dall’astratto fine-in-sé della macchina-mondo; se le cose stessero effettivamente così il flusso automatico della ricchezza materiale ridurrebbe necessariamente in maniera altrettanto «naturale» e progressiva il tempo di lavoro fino alla sua totale sparizione.
Si dà il caso però che, malauguratamente, sia vero proprio l’esatto contrario; infatti l’automa del calcolo aziendale preferirebbe di gran lunga mettere alla frusta, ventiquattr’ore su ventiquattro, l’ultimo operaio sopravvissuto (quello di Rathenau) ed espellere nel contempo i «superflui», senza concedere loro, in linea di principio, neppure un tozzo di pane. Ed è questa l’unica evoluzione logicamente possibile dell’automazione nel capitalismo: per esso la disoccupazione di massa non implica affatto una condizione gratificante di ozio per le masse, bensì la povertà di massa o, in casi estremi, la morte di massa. Questa logica connaturata alla razionalità economica deve imporsi necessariamente con il progresso dell’automazione, vanificando inesorabilmente i tradizionali meccanismi compensativi della crescita industriale. Ha perfettamente ragione Hannah Arendt quando giudica in modo profondamente negativo il fatto che alla moderna società del lavoro venga a mancare il «lavoro» – tuttavia tale giudizio risulta valido solo se inteso come pronostico di una grande crisi, non solo culturale, ma soprattutto sociale ed economica; inoltre non si tratterrà di una crisi passeggera, ma di un vero e proprio collasso storico del sistema, poiché questo «lavoro» in via di estinzione non è altro che la sostanza feticistica del capitale stesso.
Ma l’ufficialità e le istituzioni borghesi, caparbiamente aggiogate alla macchina sociale capitalistica, che allo stesso tempo garantisce la loro legittimazione esistenziale, furono costrette a respingere tale pensiero (proprio come ai giorni nostri) proprio come le masse lavoratrici, modellate sulla forma-soggetto e sulla forma-relazione del sistema della merce. Nonostante tutto però si levarono comunque voci isolate che misero in guardia circa la possibilità di una nuova ed inaudita catastrofe economica del capitalismo, causata dall’automazione, pur senza comprendere il nesso interno (e l’identità fondamentale) tra «lavoro», denaro e capitale e avanzando preferibilmente argomenti di natura morale. Tra di esse va citato anzitutto Norbert Wiener (1894-1964), il più importante tra i fondatori della cibernetica. In un celebre libro su questo tema, pubblicato poco dopo la Seconda guerra mondiale, Wiener formulò previsioni radicali, manifestando il suo profondo pessimismo in quanto egli, diversamente da Keynes o Arendt, era perfettamente conscio della situazione:
La fabbrica automatica, la catena di montaggio senza l’intervento dell’uomo, sono una realtà tanto lontana da noi, quanto limitata è la nostra volontà di mettere alla sua soluzione l’impegno posto, per esempio, nello sviluppo della tecnica del radar nella seconda guerra mondiale […] Può essere utile per l’umanità che la macchina la liberi dalla necessità di occupazioni servili e spiacevoli; ma può anche non esserlo. Non sono in grado di stabilirlo. Non può certo essere bene enunciare queste nuove possibilità in termini economici della moneta che esse fanno risparmiare […] Posso forse chiarire i presupposti storici della situazione odierna se dico che la prima rivoluzione industriale, la rivoluzione dei «neri, satanici opifici» rappresentò la svalutazione delle braccia umane al confronto della macchina […] La rivoluzione industriale moderna è ugualmente portata a svalutare il cervello umano, almeno nelle più semplici ed usuali decisioni. Naturalmente, come il falegname, il meccanico, il sarto specializzati sono in qualche modo sopravvissuti alla prima rivoluzione industriale, così lo scienziato e l’amministratore specializzati possono sopravvivere alla seconda. Certo che, una volta compiutasi la seconda rivoluzione, l’essere umano medio, di capacità mediocre o meno, non ha più niente da offrire che meriti di essere acquistato. La soluzione risiede, naturalmente, in una società basata più sui valori umani che sulla compra-vendita. Per giungere a questa società occorreranno grandi pianificazioni e grandi lotte che, se il meglio viene dal meglio, potrebbero essere sul piano delle idee ma potrebbero anche non esserlo […] Il meglio che possiamo fare è di cercare di far conoscere ad un vasto pubblico i vantaggi e gli svantaggi di questo lavoro […] Scrivo nel 1947, e sono costretto a dire che è una speranza molto tenue.8
Wiener mescola qui la seconda rivoluzione industriale, già visibile, con la terza rivoluzione industriale, ancora invisibile, che per l’autore appare solo come un prolungamento della precedente. Certo, ogni rivoluzione industriale costituisce il fondamento della successiva, si possono osservare stadi intermedi e transizioni, in quanto la concorrenza spinge permanentemente verso l’innovazione tecnologica. Ma considerando questo sviluppo sul lungo periodo e su scala più vasta è possibile individuare modelli coerenti che costituiscono su una base tecnologica assolutamente specifica un’epoca socio-economica corrispondentemente specifica.
Mentre la prima rivoluzione industriale fu caratterizzata dall’impiego del carbone e del vapore, che causò la rovina dei tradizionali produttori artigianali, la seconda rivoluzione si fondò invece sul motore a combustione interna, sulla catena di montaggio e sulla «scienza del lavoro» aziendale, in associazione con una scissione socio-economica epocale tra il periodo delle guerre mondiali industrializzate e quello della prosperità fordista del dopoguerra. La terza rivoluzione industriale avrebbe trovato la sua base tecnologica nell’elettronica e nelle «scienze dell’informazione» e ne sarebbe seguito un nuovo stadio qualitativo della disoccupazione di massa e quindi della crisi del sistema. Il pessimismo precoce di Wiener circa la possibile inconciliabilità tra l’ulteriore progresso produttivo e il modo di produzione dominante sulla base dei «mercati del lavoro» – emersa dalle sue ricerche sul piano tecnologico – era fin troppo giustificato; ma le sue indicazioni, in cui la seconda rivoluzione industriale non si distingueva nettamente dalla terza, risultarono prive di effetto e non c’è da stupirsene visto che nel 1947 la piena affermazione del fordismo era ancora a venire.
Nel 1965, quando il boom era ancora al suo apice, il sindacato tedesco IGM (Industriegewerkschaft Metall), uno dei più importanti del mondo, organizzò un congresso dal titolo «Automazione: rischi e opportunità», che venne documentato da due ponderosi volumi. Nonostante si discutesse già di calcolatori elettronici e di nuove potenzialità di razionalizzazione, il futuro della terza rivoluzione industriale venne esaminato attraverso le lenti fordiste della «piena» occupazione di massa. A prevalere era l’ottimismo, come testimonia del resto l’adozione del sempiterno ragionamento capitalistico circa «rischi e opportunità», laddove i «rischi» sono funzionali solo allo sfruttamento di formidabili «opportunità», così da giustificare preventivamente il corso capitalistico delle cose. L’allora presidente di IGM, Otto Brenner (1907-1972) rifletteva così in tutta serenità:
Nonostante l’automazione e l’impiego della tecnologia, in Germania c’è da anni la piena occupazione […] I sindacati dissentono nella maniera più assoluta da coloro che si attendono fatalmente la disoccupazione di massa dall’automazione e dalle altre forme di progresso tecnico […] Per i sindacati il progresso tecnologico è uno strumento necessario per il raggiungimento di uno standard di vita migliore per tutti […] Un futuro tecnologicamente avanzato pone anche nuovi compiti ai sindacati. Del resto i sindacati rivendicano già per se stessi il merito di avere realizzato nel passato, mediante politiche efficaci circa i livelli salariali e l’orario di lavoro, tutto ciò che era necessario fare per la garanzia della piena occupazione. Al momento non siamo ancora riusciti ad assicurare posti di lavoro equivalenti ai lavoratori sostituiti dalla tecnologia.9
Indubbiamente lo sguardo sul futuro dei sindacati, come già nel dibattito sulla razionalizzazione fordista degli anni Venti, confidava in maniera tenace ed esclusiva su un’imprecisata rivoluzione tecnologica del capitalismo, sulla possibilità di ridefinirla in termini cosmetici e sulla speranza di sopravvivere anche ad una nuova epoca di razionalizzazione e di automazione mediante una collaborazione positiva. In questo dibattito i rappresentanti delle istituzioni internazionali si espressero in maniera ancora più ottimistica, addirittura euforica, come dimostra ad esempio Jef Rens, dirigente dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) di Ginevra:
Mediante gli immani progressi tecnici del più recente passato diviene possibile produrre un profluvio costantemente crescente di beni, per soddisfare i desideri e i bisogni degli uomini. Possiamo riflettere come mai prima d’ora sul modo in cui vogliamo utilizzare questa produttività crescente […] L’ampliamento prevedibile del tempo libero offrirà anche possibilità estese per un suo impiego costruttivo. In questo sviluppo un ruolo considerevole potrebbero giocarlo proprio i sindacati. Essi sono stati creati e diretti dai lavoratori stessi e hanno quindi i presupposti ideali per la stesura e la realizzazione di programmi che possano dischiudere ai lavoratori una vita più ricca e più soddisfacente. Il movimento sindacale può stabilire nel migliore dei modi quali occupazioni siano di interesse per i suoi membri nel tempo libero e dare una forma corrispondente ai propri programmi. Al movimento sindacale odierno compete sicuramente ancora un grosso compito.10
Anche Michael Harris, vice-segretario generale dell’OCSE, condivide questo assurdo ottimismo, che vede nei sindacati del futuro una specie di organizzazione-fornitrice di senso per l’incombente società del tempo libero:
Forse si è prestata meno attenzione alle opportunità della tecnica moderna che ai suoi pericoli. Finora però l’incremento della produttività ha condotto ad un miglioramento costante del tenore di vita in tutti i paesi che hanno adottato le nuove tecniche. Nulla giustifica l’assunto secondo cui l’automazione dovrebbe cambiare lo stato delle cose.11
Nella più completa ignoranza di ogni vincolo economico strutturale a pronunciarsi qui con forza è unicamente la volontà di chi vorrebbe giudicare la terza rivoluzione industriale ai suoi albori solo dal punto di vista del boom fordista, già in fase declinante, e dunque come se si trattasse di un suo prolungamento. Aspettative che vennero alimentate anche da molti scienziati sociali. Sotto questo riguardo, nel novero dei più rinomati ottimisti di professione troviamo anche il sociologo francese Jean Fourastié (1907-1990), che volle calcolare anticipatamente la diminuzione del tempo di lavoro, rigidamente limitata ai centri della prosperità fordista, per il secolo successivo:
Ai giorni nostri è ampiamente condivisa l’idea che già in un prossimo futuro, nei paesi economicamente più sviluppati, l’uomo medio potrà soddisfare le sue necessità con un’attività lavorativa di trenta ore settimanali […]; in ogni caso i progressi della scienza e della tecnica, messi a punto nei paesi occidentali, fanno apparire queste prospettive come assolutamente giustificate […]; senza voler fissare un punto ben preciso nel tempo, possiamo ipotizzare che ben si accordino 30 ore di lavoro a settimana per 40 settimane di lavoro all’anno. Ne risultano 30 per 40 uguale 1200 ore all’anno […] Poiché la durata media della vita di un uomo è di circa ottant’anni […] i nostri discendenti dedicheranno solo sei ore su cento al lavoro nella produzione, che per millenni ha divorato quasi per intero la forza fisica e l’attività mentale di milioni dei nostri antenati. In altre parole stiamo sperimentando attualmente il passaggio dell’uomo da una fase di dipendenza dal tempo a una fase di abbondanza temporale.12
Proprio come i suoi colleghi della gilda economica e filosofica Fourastiè – la cui ottimistica visione dell’avvenire ha per titolo Le 40.000 ore (di più l’uomo non dovrebbe lavorare in futuro per l’intera durata della sua vita) – ignora completamente la logica capitalistica, istituisce una relazione immediata tra «progresso tecnologico» e «tempo di lavoro» e, per inciso, distorce ancora una volta la storia sociale dell’umanità quando afferma che gli uomini premoderni «per millenni» dovevano consumare tutto il loro tempo vitale per il «lavoro», il che non risponde minimamente al vero; infatti l’assurda tendenza ad incrementare la forza produttiva al solo scopo di convertire, se possibile, l’intero spazio della vita in «lavoro» è un fenomeno esclusivo del capitalismo. E se Keynes e Arendt si erano perlomeno posti il problema culturale e psicologico del superamento della «società del lavoro» ad opera dello sviluppo delle forze produttive, Fourastiè manifesta solo un’ingenua, sfrenata fede miracolistica nella tecnologia che, alla luce delle condizioni odierne, appare addirittura strampalata.
Adesso anche l’uomo normale potrà «perfezionarsi», ampliare le sue capacità, ridurre la sua fatica o perfino abolirla (!) e influenzare il suo patrimonio ereditario […] Nella biologia degli animali e delle piante esiste già un bestiame da macello che i nostri antenati avrebbero ritenuto fiabesco, pesche dal peso di mezzo chilo, mele dal peso di un chilo […]; nel 1965 è entrata in funzione la centrale atomica di Hanford ed è in essa che si può riconoscere l’aspetto che assumeranno le gigantesche centrali del prossimo futuro […].13
Una tale euforia ha in sé qualcosa di spettrale se si pensa che la fede ottocentesca nel progresso, sia liberale che socialista, ridimensionata in forme tecnologiche o tecnocratiche, si era già catastroficamente spenta nell’epoca delle guerre mondiali industrializzate e della crisi economica mondiale. Sarebbe tuttavia corretto dire che la breve fase della prosperità fordista dopo il 1950 introdusse nella coscienza sociale una parodia di questa speranza tecnocratica. Il pallido ottimismo di Fourastiè si colloca indubbiamente nel contesto delle utopie tecnologiche fordiste che vennero divulgate dappertutto su di un livello intellettuale estremamente basso. L’«abolizione della fatica», che la tecnologia sembrava rendere possibile, va di pari passo con le fantasie contemporanee, diffuse dalle riviste tecniche per dilettanti o dai romanzi fantascientifici, a base di alimenti in pillole, autostrade lanciate sul lago di Costanza o rasoi meccanici alimentati da reattori atomici in miniatura.