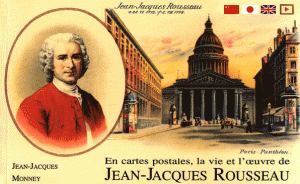JEAN-JACQUES ROUSSEAU E LA FILOSOFIA CLASSICA TEDESCA : UN PROBLEMA CRITICO APERTO.
gen 7th, 2015 | Di Maurizio Neri | Categoria: Teoria e critica
Nel corso di una delle sue brillanti lezioni su Fichte –nel 1977-, Francesco Moiso, che mi fu indimenticato Maestro di studi hegeliani all’Università di Torino, ebbe ad affermare che i concetti di libertà e perfettibilità, con cui Rousseau spiegava la fuoriuscita dell’uomo dall’ipotetico stato di natura, stavano all’origine del concetto di Geist in Hegel e nella filosofia classica tedesca.
Ancora imbevuto di schemi critici kroneriani e dellavolpiani –desunti dalla consueta preparazione liceale-, con la mente ancora irrigidita sull’ Io legislatore e finito di Kant che, con le mediazioni di Reinholdt, Schulze e Maimonide, diventa l’Io assoluto e creatore di Fichte, per essere poi rielaborato e perfezionato da Schelling e da Hegel, ebbi alcuni momenti di sconcerto. Ma ciò sollecitò comunque la mia curiosità e, negl’anni successivi, non dimenticai mai queste sue sollecitazioni critiche. Mi abituai sempre più visibilmente ad attribuire a Rousseau un ruolo primario, nella genesi della filosofia classica tedesca e di una più profonda linea di pensiero umanistico e critico della modernità capitalista, che si dipana dalla classicità tedesca sino al marxismo e al neoidealismo del XX secolo.
Ne scaturirono numerosi studi, svolti per lo più nel corso degli anni ’90, la cui pubblicazione fu possibile grazie al continuo interessamento, alla disponibilità, alla grande apertura di orizzonti culturali del Prof. Marzio Pinottini –a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti.
Va però detto, a premessa delle considerazioni che qui intendiamo sviluppare, che il quadro della recezione di Rousseau in Germania, fra il 1751 e gl’anni ’90 del secolo, non consente di trovare testimonianze oggettive e prove chiare del paradigma critico che intendiamo proporre e che valorizza, in funzione dello sviluppo della Filosofia Classsica Tedesca, il Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza, largamente trascurato e sottostimato dall’ambiente intellettuale tedesco di quegl’anni[1].
Infatti il Rousseau che ha suscitato gli apprezzamenti maggiori è quello delle opere letterarie –fra cui spicca la Nuova Eloisa-, della Lettera a D’Alambert, dell’Emilio, degli scritti tardi ed autobiografici. E’ un Rousseau che sembra molto diverso, rispetto alla condanna del processo di civilizzazione dell’uomo, all’antitesi apparentemente rigida fra natura e cultura, uomo naturale e uomo sociale civilizzato, al rigetto dell’ideale illuministico del progresso continuo dell’uomo e della ragione, che Gottsched e molti esponenti della generazione di Lessing avevano colto nei due Discorsi e che ne avevano motivato una visione tendenzialmente negativa. Le tematiche ora in evidenza sono quelle della virtù morale e dei suoi fondamenti religiosi –centrali proprio nella Nuova Eloisa, in molte parti dell’Emilio e nelle Passeggiate del pensatore solitario-, più consone all’ambiente intellettuale tedesco dell’epoca. Tematiche che contribuiscono a generare il mito della personalità di Rousseau, quale modello vivente di moralità perseguitata, in antitesi alla corruzione della società del tempo e ai cedimenti dei Lumi francesi suoi contemporanei.
Nello specifico dei Discorsi, va innanzitutto detto che a suscitare le maggiori prese di posizione e il dibattito più vivace è il Discorso sulle scienze e le arti, che urta in modo diretto, improvviso e imprevisto, i miti illuministici contemporanei. Il secondo Discorso, seppur tradotto prontamente da Mendelsohn, ha un impatto immediato molto più debole. Ciò è dovuto all’opinione dominante che esso segua gli schemi di pensiero del primo e che, in entrambi i casi, ci si trovi di fronte ad un sofista, ad uno spirito animato da paradossi e da contraddizioni.
Nella sostanza, con l’importante eccezione di Lessing che, recensendo analiticamente il primo Discorso, coglie e valorizza la questione dell’alienazione sociale, che già vi spicca[2], il pubblico intellettuale tedesco degli anni ’50 condivide in gran parte la sprezzante e superficiale critica di Voltaire: con Rousseau ci si trova di fronte ad un personaggio stravagante, che propone come ideale l’uomo ignorante e barbaro delle foreste! Comunque sia, spicca negativamente il rifiuto dell’idea dello sviluppo continuo dell’uomo e della sua ragione e l’antitesi natura/cultura, natura/civiltà.
Sino alla metà degli anni ’90 non troviamo traccia di una lettura più approfondita e meno condizionata dai pregiudizi volteriani. Tuttavia, proprio in questi anni cruciali, secondo Jamme, se ne ha una valorizzazione prima in Hölderlin, che vi legge una visione triadica dello sviluppo storico e culturale dell’umanità, secondo lo schema perdita/riconquista dell’armonicità originaria, e successivamente in Hegel, agli inizi del periodo francofortese, che, come noto, recepisce questo schema, facendone il fondamento logico della sua dialettica[3].
Il fatto, accertato e asserito da uno studioso della statura di Ch. Jamme, che sia Hölderlin che Hegel approfondiscano in questa direzione la lettura di Rousseau fuga ogni dubbio sull’alto valore critico della ricordata affermazione verbale di Francesco Moiso e toglie ogni margine di arbitrarietà alle analisi che ci accingiamo a condurre.
Dunque perché i concetti rousseauiani di libertà e di perfettibilità potrebbero essere all’origine del concetto hegeliano di Geist, come di quello fichtiano di Ich, che gli è affine, in sintonia con un intero quadro culturale –quello della Goethe Zeit- che fa perno sull’idea dell’uomo quale soggettività creativa del proprio mondo in un contesto sociale? Perché Rousseau potrebbe essere un riferimento primario dell’intera filosofia classica tedesca?
Proprio Francesco Moiso spiegava che libertà e perfettibilità sollevavano l’uomo al di sopra di una condizione naturale, animalesca, di dipendenza meccanica dalla presenza materiale dell’oggetto e dall’istinto corporeo legato all’autoconservazione, di sottomissione alle leggi naturali date, e gli consentivano di esprimere la cultura, la Bildung: l’insieme degli oggetti, delle produzioni materiali e spirituali, delle relazioni che formano una civiltà storicamente determinata. L’uomo entra nella storia universale, che è una sua creazione sociale e collettiva e che procede secondo un modello olistico, antitetico a quello meccanico, pensato alla base della natura dalla filosofia del seicento e dallo stesso Rousseau. Con ciò l’uomo cambia anche l’insieme dei suoi comportamenti e delle sue abitudini di vita. Sorge l’idea che egli sia una soggettività attiva, libera e creativa, in grado di determinare se stesso, creando nel contempo, in una dimensione sociale e socialmente condizionata, un livello di oggettività non dato in natura, che da lui dipende e che costituisce il suo mondo, il suo habitat di vita, la sua cultura nel senso più ampio del termine: la società, le istituzioni, la storia.
Un’idea che nasce nel Rinascimento, ma che si generalizza proprio nella filosofia tedesca e che Moiso, giustamente, poneva in stretta relazione con i concetti di Ich in Fichte, e di Geist in Hegel, di cui non mancava di ricordare il radicamento nel lavoro umano. E’ facile intuire che, su questa linea di pensiero, si arrivi al materialismo storico di Marx. Superfluo citare i noti passi dei Manoscritti e dell’ Ideologia tedesca!
L’uomo, con la libertà, può porre uno spazio di riflessione razionale fra l’affezione dell’ istinto e la reazione ad esso; l’imput che si riceve dall’istintività fisico-corporea è sospeso ed è possibile decidere razionalmente, scegliere con atto di volontà cosciente se assecondarlo o reprimerlo, e come modulare la risposta. Se l’animale, con necessità meccanica, grida quando ha sensazioni di dolore, si getta sul cibo quando ha fame, aggredisce quando è offeso, l’uomo può sospendere questi imput che vengono dall’impulso, differire, studiare, definire coscientemente la risposta ad esso, anche con il semplice atto di trattenere l’urlo del dolore, o di cuocere il cibo. Ciò si accompagna ad un perfezionamento dell’insieme delle sue abilità e facoltà fisiche e intellettuali, sconosciuto al resto del mondo animale, che ci consente di cercare intelligentemente il cibo, poi di produrlo, per passare a cuocerlo, a conservarlo, ecc.
Con questi comportamenti, come argomenta il Discorso sull’origine della disuguaglianza, gli uomini entrano in stabili rapporti sociali le cui strutture e norme diventano sempre più condizionanti per chi nasce, si forma e vive al loro interno, prefigurando ruoli, caratteri e modelli, come nel caso della famiglia per l’uomo e per la donna. L’uomo si instrada a diventare soggetto creatore di se stesso e del proprio mondo, emancipato rispetto a condizionamenti e leggi naturali, nel quadro della società e della storia universale che, come accennato, si fondano sul modello olistico-totalizzante. Infatti proprio il modello teorico olistico-totalizzante, come modello strutturante le società umane e la storia, è alla base delle filosofie dell’idealismo tedesco, del pensiero marxista, come del neoidealismo del secolo testé concluso.
E’ possibile raccogliere e radicare queste riflessioni in un unico nodo teorico, per vederne lo sviluppo fra Fichte, Hegel, Marx e oltre, ponendo Rousseau all’origine della linea di pensiero dialettica prefigurata e in antitesi alle filosofie giusnaturalistiche e razionalistiche dominanti nel sei-settecento?
Noi crediamo fermamente di sì! Questo nodo teorico nasce dal rifiuto della nozione meccanicistica e materialisticamente intesa della libertà, nata con Hobbes, e riproposta dall’Illuminismo settecentesco, per identificarla in un atto interamente spontaneo del volere, inteso quale facoltà dell’anima, con cui l’uomo diventa il soggetto spirituale, creatore di sé e del proprio mondo oggettivo socialmente e storicamente condizionato. Una nozione spiritualistica, antimeccanicistica di libertà, dalla quale nasce l’Ich di Fichte, il Geist di Hegel, la Lebenstätigkeit umana di Marx, in netta antitesi con l’Illuminismo.
Questo nodo teorico per altro è già stato messo in luce in un recente studio di R. Wokler, che traccia una rapida ma originale sintesi dell’intero pensiero rousseauiano. In esso si legge che, a differenza degli animali, “sempre schiavi dei propri appetiti”, “gli uomini sono dotati di libero arbitrio o, per lo meno, hanno la naturale prospettiva di essere loro i responsabili di come vivono”. Un’idea legata alla tradizione metafisica e spiritualista dell’ Europa antica e medioevale, pagana e cristiana, che venne rifiutata radicalmente da Hobbes, a favore di un’antropologia materialistica e meccanicistica già funzionale a giustificare il nascente uomo borghese, ripiegato sull’interesse egoistico, sulle materialità di vita, sulle attività economiche. Scrive R. Wokler:
“Già Hobbes aveva respinto questa antica concezione della libertà, che Rousseau resuscitava distinguendo l’azione coattiva da quella deliberata. Secondo Hobbes, gli animali non sono schiavi dei loro appetiti, perché questi sono per loro motivazioni, non costrizioni, in quanto costituiscono la causa che li spinge ad agire, e non freni che li ostacolano; l’idea di una libertà del volere sarebbe assurda, perché soltanto i corpi possono essere liberi o ostacolati nei loro movimenti, ma la volontà, non essendo soggetta al movimento, non può avere alcun impedimento esterno che la arresti”. (Leviatano, cap. 21).
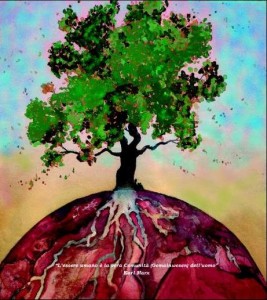 Rousseau, che su questo punto è debitore di una tradizione della filosofia classica che Hobbes aveva posto in discussione, è convinto invece che la natura eserciti una costrizione interna sul comportamento animale, e che i nostri antenati, potendo sempre soddisfare i propri impulsi naturali in modi diversi, non siano stati vincolati dagli istinti che spingono e danno ordini a tutte le altre creature. (Scritti politici, p. 299).
Rousseau, che su questo punto è debitore di una tradizione della filosofia classica che Hobbes aveva posto in discussione, è convinto invece che la natura eserciti una costrizione interna sul comportamento animale, e che i nostri antenati, potendo sempre soddisfare i propri impulsi naturali in modi diversi, non siano stati vincolati dagli istinti che spingono e danno ordini a tutte le altre creature. (Scritti politici, p. 299).
Ogni membro della specie umana che non sia infermo di mente, secondo Rousseau, è capace di governare se stesso”.[4]
Come abbiamo cercato di argomentare in un saggio sull’ antropologia dei diritti naturali dell’uomo, pubblicato in due diverse edizioni da Noctua, Hobbes pone alla base del comportamento umano la stessa meccanica degli istinti che muove gli animali, che a sua volta richiama i principi della meccanica di Newton.[5]
Cosa può significare, infatti, che “soltanto i corpi possono essere liberi o ostacolati”? Nient’altro che concepire e spiegare l’intera vita naturale, uomo compreso, secondo il principio del moto rettilineo uniforme: può dirsi libero un corpo in grado di mantenere il proprio originario stato meccanico (di quiete o di moto rettilineo uniformemente accelerato) senza che un altro corpo lo urti o lo ostacoli. L’uomo è un ente fisico, un corpo fra i corpi, sostanzialmente pensato, come pone in luce anche Macperson, sul modello di una macchina semovente, mossa da stimoli esterni costituiti dagli istinti ed impulsi della sensibilità corporea, fondata sull’istinto autoconservativo, a perpetuare il proprio movimento, come nell’esempio meccanico appena citato.
In modo più preciso, gli istinti, per Hobbes, sono un insieme di desideri e di avversioni che proiettano con necessità meccanica –la stessa necessità della spinta impressa esteriormente ad un qualsiasi corpo inerte- l’uomo, o l’animale al possesso di un oggetto dato, materialmente presente di fronte a noi e ai nostri sensi, rappresentato empiricamente e percepito emozionalmente come utile, o, all’allontanamento da esso, quando, al contrario, è sentito come dannoso. La presenza materiale dell’oggetto, l’interazione fra essa, la sua rappresentazione sensoriale, il riferimento di essa all’istinto autoconservativo, che la carica di emotività positiva o negativa, sono fattori meccanici che sospingono esteriormente il soggetto umano –o, per meglio dire, in questo caso, l’ ente oggettivo uomo- verso determinati comportamenti.
A questi condizionamenti meccanici l’animale non può certamente sfuggire e, in modo sostanziale, neppure l’uomo. Infatti -come abbiamo spiegato analiticamente ne Il Busto di Giano- Hobbes riduce l’atto della volontà cosciente alla deliberazione di un appetito -desiderio o avversione-, da assecondare, dopo che la mente, in cui sono impresse e in cui scorrono come i fotogrammi di un film al rallentatore tutte le rappresentazioni empiriche con relative emozioni associate, comparandolo con gli altri appetiti, ne ha valutato importanza e realizzabilità. Scrive Hobbes, nel De Homine, che “la volontà stessa è un appetito”, più precisamente l’ultimo appetito che si presenta nel corso della deliberazione; quello “che produce immediatamente l’azione o l’ omissione”.
“Nel corso di questa deliberazione (…) si manifesta e si rifugge alternativamente, finché (…) l’ultimo appetito, sia di fare sia di tralasciare, che produce immediatamente l’azione o l’omissione, vien detto volontà”[6]
Questa capacità di calcolo e di discernimento sulle emozioni, sullo stimolo meccanico dell’ impulso –capacità che compete alla materialità del cervello funzionante e che, dunque, non è, nella maniera più assoluta, espressione di alcun principio spirituale- è l’unica forma di libertà riconosciuta all’ uomo, e che lo differenzia –per altro solo quantitativamente- dall’ animale. Ciò significa che l’antropologia materialistica, che proprio a partire da Hobbes sta alla base delle dottrine giusnaturalistiche, comprese quelle che si orienteranno in senso liberale e si travaseranno nell’ambiente illuminista, pensa la libertà dell’uomo unicamente nel contesto della meccanica degli istinti, come forma di relativa autonomia dai loro condizionamenti più pressanti. L’ uomo rimane sostanzialmente vincolato al determinismo meccanico della natura.
In Rousseau la volontà ridiventa una componente dell’ anima, infusa dal Creatore nel corpo umano, entro un dualismo antropologico, che ha la sua origine più diretta in Condillac, ed un orientamento coerentemente spiritualistico che sospinge il Ginevrino ad un rifiuto non solo politico ma anche religioso della società del “bourgeois”. Ne sono una chiara dimostrazione il pensiero e la politica di Robespierre e del gruppo dirigente giacobino dell’ anno II che attorno a lui converge più coerentemente, sino alla tragedia del 9 e del 10 Termidoro, ispirandosi proprio a JJ. Rousseau.[7]
L’ atto assolutamente libero del volere, quale facoltà spirituale, può sottrarre interamente l’ uomo alla necessità espressa dalla meccanica degli istinti, consentendogli i processi di perfezionamento di sé e di socializzazione citati e, nel loro contesto, la creazione di un mondo artificiale, quello della cultura e della storia. Superamento della necessità meccanica dell’ istinto, socialità –che significa anche intersoggettività- e creazione dell’ oggettività delle istituzioni e della storia universale, strutturate secondo il modello olistico-totalizzante, sono anche, in un quadro categoriale molto più sofisticato, gli elementi concettuali entro cui si collocano lo Ich di Fichte e il Geist di Hegel: la libertà deve emancipare l’ uomo dalla necessità naturale e meccanica, che opera in lui attraverso gli istinti; non solo consentirne un determinato grado di controllabilità.
La questione è etica nel senso più hegeliano e tradizionale del termine: non solo relativa al comportamento individuale, ma anche a quello collettivo, sociale e pubblico. E’ questione morale –se mi si consente un uso molto elastico e molto poco dialettico del termine- e nel contempo questione politica. L’ uomo che si emancipa dalla necessità meccanica dell’ istinto è uomo che rompe con le chiusure egoistiche del “bourgeois”, che si apre alla dimensione comunitaria e fraternalistica del “citoyen” che anima l’intera componente umanistica della Goethe-Zeit, entro la quale –continuando ad ispirarci a Lukàcs- noi collochiamo la fase jenese di Ficthe e la filosofia di Hegel.
E’ necessario, a questo punto, entrare maggiormente nel dettaglio delle categorie concettuali fichtiane e hegeliane citate, soprattutto per quanto riguarda Fichte, sulla cui filosofia non ci siamo mai soffermati organicamente nei nostri saggi. Mentre, per quanto concerne il pensiero di Hegel e i suoi rapporti con Rousseau, ci siamo già abbondantemente dilungati, a partire dal nostro Hegel critico dell’ autoritarismo.
Come noto l’ idealismo trascendentale della prima fase fichtiana nasce come filosofia della libertà in rapporto ad una pluralità di istanze, sul cui grado di importanza si può discutere all’ infinito. Tuttavia, soprattutto se si prendono in considerazione gli scritti politici del 1792-1793, nessuno può negare che determinante sia l’ interazione con gli eventi rivoluzionari francesi e l’esigenza di definire una linea di pensiero che legittimi i processi politici in corso, che vedono una soggettività collettiva emanciparsi da una tradizione data, per procedere liberamente e coscientemente a ricreare se stessa e le istituzioni del paese, a forgiare faustianamente il mondo a propria immagine e somiglianza. Una filosofia idealistica deve giustificare questa libertà, che sta nascendo in Francia con l’Assemblea Costituente e con la Convenzione Nazionale.
Su simili basi l’idealismo avrà il compito di procedere ad una costruzione trascendentale della coscienza quale soggettività libera, rimanendo sempre nei limiti della sua determinatezza finita e proponendo questi limiti come condizione irrinunciabile della sua libertà. Scriveva Pareyson che l’ idealismo trascendentale “spiega il sapere umano all’ uomo”; è “spiegazione del sapere finito, dal punto di vista del finito e col sapere finito, a noi esseri finiti” [8]. Con ciò la libertà della coscienza non pretende l’ assolutezza demiurgica stürmeriana e romantica, né si fonda sulla deduzione dell’oggetto da una soggettività assoluta; è una libertà che si esprime nella subordinazione dell’ oggetto o Non-Io alle leggi pratiche dell’Io, per consentirgli una continua emancipazione rispetto all’ oggettività data che lo determina e una continua rideterminazione, secondo finalità coscienti, dell’ agire individuale, sul piano morale, dell’agire collettivo, su quello politico.
Una filosofia idealistica di questo tipo, come scrive chiaramente Fichte nella Dottrina della scienza del 1794, potrebbe anche essere definito un realismo critico, in quanto esso non deve tanto ricavare teoricamente il Non Io dall’ Io –questione presentata per altro come indimostrabile entro i limiti della razionalità teoretica, analitica, ereditata da Kant e dall’ Illuminismo- ma semplicemente connettere il primo al secondo in modo che gli sia subalterno e che funga da condizione di libertà in quanto limite superabile e rideterminabile dalla coscienza.
 Da un lato la coscienza deve confrontarsi con un Non-Io esteriore e indipendente –vale a dire con un’oggettività- che la limita e la finitizza, facendone un agire determinato e ben visibile, quello dell’uomo che non si perde in una tormentata e irrealizzabile Sehnsucht all’assolutezza demiurgica; e la sensibilità –come meglio vedremo- è veicolo di questa determinazione meccanica dell’oggetto sull’ interiorità del soggetto. Dall’altro lato la coscienza deve, come indicato, sottometterlo a sé, farne la condizione visibile della sua libertà ed operatività ricostruendo l’oggettività che la determina, conferendole nuove forme, come nella vita morale kantiana, come nella vita politica della Francia rivoluzionaria.
Da un lato la coscienza deve confrontarsi con un Non-Io esteriore e indipendente –vale a dire con un’oggettività- che la limita e la finitizza, facendone un agire determinato e ben visibile, quello dell’uomo che non si perde in una tormentata e irrealizzabile Sehnsucht all’assolutezza demiurgica; e la sensibilità –come meglio vedremo- è veicolo di questa determinazione meccanica dell’oggetto sull’ interiorità del soggetto. Dall’altro lato la coscienza deve, come indicato, sottometterlo a sé, farne la condizione visibile della sua libertà ed operatività ricostruendo l’oggettività che la determina, conferendole nuove forme, come nella vita morale kantiana, come nella vita politica della Francia rivoluzionaria.
Non si tratta dunque di ricavare l’oggetto dal soggetto assoluto, come intende fare l’idealismo dogmatico, né di postularne l’indipendenza originaria, secondo il punto di vista del realismo dogmatico. Nella prospettiva dell’idealismo trascendentale della fase jenese idealismo e realismo si fondano in un “ideal-realismo” che è una spiegazione trascendentale della libertà e della superiorità della coscienza rispetto ad una realtà esterna che la delimita –una delimitazione di cui per altro essa ha necessità per essere la coscienza di un uomo concreto che agisce concretamente nella realtà concreta- e che deve essere funzionale al proprio agire: condizione kantiana di possibilità di esso. Il nuovo idealismo, che si erige a filosofia della libertà e a giustificazione teorica della Rivoluzione giacobina, deve semplicemente riconoscere che la realtà indipendente delle cose –qualunque sia la sua origine- sta per la coscienza e in funzione del suo libero agire: essa può dunque emanciparsi completamente dalla natura meccanica per creare, in un’intersoggettività, l’oggettività dialettica –che definiamo come tale, in quanto obbedisce al modello olistico totalizzante- della cultura, delle istituzioni e della storia universale e muoversi in essa.
Scrive Fichte, quasi a conclusione della Dottrina della scienza del 1794:
“La dottrina della scienza è perciò realistica. Essa mostra che la coscienza delle nature finite non si può affatto spiegare se non si ammette una forza presente indipendentemente da quelle, a esse interamente opposta e da cui quelle, secondo la loro esistenza empirica, sono dipendenti. Ma essa non afferma anche nient’altro se non una tale forza opposta, che dagli esseri finiti è solamente sentita, ma non conosciuta….
Nonostante il suo realismo, questa scienza non è però trascendente, ma rimane trascendentale nelle sue più intime profondità. Essa spiega assolutamente ogni coscienza in base ad un qualcosa presente indipendentemente da ogni coscienza; ma non si dimentica che anch’essa, in questa spiegazione, si conforma alle sue proprie leggi e appena riflette su ciò quel qualcosa di indipendente diviene ancora una volta un prodotto della sua propria forza di pensare, perciò qualcosa di dipendente dall’Io, in quanto deve esistere per l’Io (nel suo concetto). Ma per la possibilità di questa nuova spiegazione di quella prima spiegazione è già presupposta la coscienza reale e per la possibilità di questa ancora quel qualcosa da cui l’Io dipende: e se ora proprio quello che prima è stato posto come un che di indipendente è divenuto dipendente dal pensare dell’Io, allora non per questo è soppresso l’indipendente, ma solo posto più in là, e così si potrebbe procedere illimitatamente senza che quello venga soppresso. Tutto, secondo la sua idealità, è dipendente dall’Io, ma dal punto di vista della realtà l’Io stesso è dipendente; tuttavia non c’è niente di reale per l’Io senza che sia anche ideale; pertanto in esso il fondamento ideale e quello reale sono una e la stessa cosa e quell’azione reciproca tra l’Io e il Non-Io è insieme un’azione reciproca dell’Io con se stesso. Esso non può porsi come limitato dal Non-Io in quanto non riflette sul fatto che è esso stesso a porre quel Non-Io limitante; può porsi come limitante esso stesso il Non-Io in quanto riflette su ciò.
Questo fatto, che lo spirito finito deve porsi necessariamente qualcosa di assoluto fuori di sé (una cosa in sé) e tuttavia dall’altro lato deve riconoscere che quello stesso esiste solo per lui (che è un noumeno necessario), è quel circolo che esso amplia all’infinito, ma da cui non può mai uscire….
La dottrina della scienza tiene precisamente il mezzo tra i due sistemi ed è un idealismo critico che si può chiamare anche real-idealismo o ideal-realismo…Solo in quanto qualcosa viene riferito alla facoltà pratica dell’Io ha realtà indipendente, in quanto viene riferito a quella teoretica, è compreso nell’Io, contenuto della sua sfera, sottomesso alle sue leggi di rappresentazione…Questo è il circolo da cui lo spirito finito non può uscire, né può volerlo senza rinnegare la ragione e richiederne l’annientamento”.[9]
Da un precedente passo si comprende ancor più chiaramente che, per consapevole intendimento fichtiano –e non per un errore tecnico, come penserà Hegel, accostandosi tardivamente alla Dottrina della scienza, condizionato da Schelling- non ci troviamo di fronte ad una teoria dell’ assoluto, fondamento reale originario comune dell’ Io e del Non-Io, della coscienza e della realtà naturale, sul modello di Urtheil und Sein di Hoelderlin e del Sistema dell’ idealismo trascendentale di Schelling.
“E così l’idealismo critico, che domina nella nostra teoria, è esposto in modo determinato. Esso è dogmatico contro l’idealismo dogmatico e il realismo, in quanto dimostra che né la mera attività dell’Io è il fondamento della realtà del Non-Io, né la mera attività del Non-Io è il fondamento della passività nell’Io; ma in riferimento alla questione su quale sia allora il fondamento della reciprocità posta fra i due, rispondere a cui è obbligato, esso si accontenta della sua ignoranza e mostra che la ricerca a questo proposito si situa oltre i limiti della teoria. Nella sua spiegazione della rappresentazione esso non parte da un’assoluta attività né dell’Io né del Non-Io, ma da un essere determinato che è insieme un determinare, poiché nella coscienza non è contenuto immediatamente null’altro, né può essere contenuto”[10]
 Siamo dunque in presenza di una dottrina trascendentale della coscienza finita che, proprio come insisteva Francesco Moiso, deve spiegarne e spronarla ad una libertà umanamente intesa, come indipendenza razionale rispetto al condizionamento meccanico della natura attraverso i sensi, con la quale l’uomo entra necessariamente in una intersoggettività che rimuove e riplasma l’oggettività data. Come l’Io (Fichte parla di “spirito finito” e dunque ci si potrebbe qui riferire all’Io finito, salvo essere smentiti da altri passi, nei quali si afferma che è l’Io puro a opporre all’Io finito il Non-Io, ma per il momento lasciamo stare!) possa opporre a sé una realtà oggettiva indipendente, che lo affetti attraverso la meccanica degli istinti della sensibilità fisico-corporea, e poi riconoscere che essa esiste solo per lui e per consentirgli di essere concretamente libero e attivo nel superarne le forme immediatamente date, trasformandole e, come tale, ricreando coscientemente questa stessa realtà, è una problematica dichiarata esplicitamente al di fuori dei limiti e della possibilità della razionalità analitica.
Siamo dunque in presenza di una dottrina trascendentale della coscienza finita che, proprio come insisteva Francesco Moiso, deve spiegarne e spronarla ad una libertà umanamente intesa, come indipendenza razionale rispetto al condizionamento meccanico della natura attraverso i sensi, con la quale l’uomo entra necessariamente in una intersoggettività che rimuove e riplasma l’oggettività data. Come l’Io (Fichte parla di “spirito finito” e dunque ci si potrebbe qui riferire all’Io finito, salvo essere smentiti da altri passi, nei quali si afferma che è l’Io puro a opporre all’Io finito il Non-Io, ma per il momento lasciamo stare!) possa opporre a sé una realtà oggettiva indipendente, che lo affetti attraverso la meccanica degli istinti della sensibilità fisico-corporea, e poi riconoscere che essa esiste solo per lui e per consentirgli di essere concretamente libero e attivo nel superarne le forme immediatamente date, trasformandole e, come tale, ricreando coscientemente questa stessa realtà, è una problematica dichiarata esplicitamente al di fuori dei limiti e della possibilità della razionalità analitica.
Una problematica che tuttavia, nel quadro della nostra argomentazione, dobbiamo toccare, in quanto la coscienza e la sua libertà sono fondate trascendentalmente su una complessa dialettica di illimitato-limitazione-limite, che va studiata intersecando tutte tre le parti dell’opera del 1794 e quest’ultima con il testo del 1798 e che inevitabilmente sospinge lo studioso a tentare una qualche forma di chiarimento sulla genesi del Non-Io a partire dall’Io.
Punto di partenza è l’agire assoluto dell’Io puro. Le sue caratteristiche sono precisate non tanto nella formulazione del primo principio –dove il discorso rimane sempre schematico con contorni vaghi- , ma all’interno della parte pratica della Dottrina della scienza del 1794. L’agire assoluto è un’attività reale di autoposizione che procede all’infinito: un moto di espansione creativa infinito e illimitato, che è centripeto e vorticoso e, nel contempo, centrifugo e lineare. Due direzioni in sé inscindibili, che possono essere scisse e poste in contraddizione solo dalla riflessione analitica dell’intelletto, che si è già visto inadeguata a comprendere le strutture dialettiche della coscienza e del suo mondo. Due direzioni che sono, nell’Io puro, il fondamento delle due attività finite su cui verrà costruita la coscienza reale: l’attività reale, che ne costituisce il moto espansivo, vitale, creativo verso l’esterno –l’Entselbsten- e l’attività ideale, che ne rappresenta invece i moti interiori, teoretici e pratici –il Verselbsten[11]-, vale a dire la riflessione intellettuale e i sentimenti.
La prima direzione dell’agire assoluto è raffigurabile empiricamente come una vorticosità; metafora sulla quale insisteva molto pareynsonianamente il prof. Moiso a lezione. Essa è rappresentabile come un’attività talmente identica a sé, che riporta immediatamente e continuamente a sé le sue determinatezze, annullandole altrettanto continuamente in sé, come se producesse continuamente le luci per diradare la “notte nera in cui tutte le vacche sono nere” e porre in evidenza il mondo e immediatamente le spegnesse, tornando a oscurarlo, per non spezzare l’assolutezza e la perfetta identità del suo buio pesto. E’ dunque un’attività che, in sé, secondo il suo principio e la sua struttura, ritorna continuamente su di sé, costituendo un vortice che centrifuga a tale livello tutto ciò che contiene da non far trasparire nulla: c’è tutto ma non si vede nulla! Di fatto non si presenta e non esiste niente, né la coscienza né la natura! C’è solo il divino, il luminoso, l’oscuro abisso nella sua assolutezza che non consente a nulla di distinguersi e di fuoriuscirne: tutto vi è creato, trattenuto, annientato, ri-creato per essere ri-trattenuto e ri-annientato, ecc., continuamente e all’infinito. Spietatamente!
Questa attività centripeda e vorticosa è anche centrifuga e lineare, assumendo l’aspetto –sul quale successivamente insisterà Schelling, già nella Naturphilosophie- di un’espansione vitale illimitata che non lascia mai taccia concreta. L’agire assoluto si espande illimitatamente e infinitamente, ad una velocità illimitata e infinita che strutturalmente –in quanto non si ferma mai, non ha mai un momento di “quiete”- non lascia traccia; non può mai produrre nulla, come una macchina che produce a tale velocità, con tali ritmi, da non consentire alle sue produzioni di uscirne, ma distruggendole sempre in se stessa senza però mai imballarsi. L’espansione dell’ agire assoluto è talmente assoluta e priva di ogni momento di riduzione d’intensità, da continuare a non produrre nulla di concreto, come non lo produce il vortice in precedenza descritto.
In entrambi i casi l’agire assoluto –ovvero, il primo principio- non è in grado di produrre alcunché: essa è la radice dell’agire razionale, autocreativo e creativo, della coscienza, che non riesce però concretamente a far germogliare. Se l’uomo, paradossalmente, si attenesse ad essa nella sua vita ed attività, cercasse, nella sua hybris, l’identità demiurgica con essa, si disperderebbe nevroticamente nei suoi interessi e nelle sue variegate azioni, senza soffermarsi analiticamente su nulla, senza creare nulla in tutti i campi dell’agire umano, senza essere nulla –né umanista, né scienziato, né fisico, né chimico, ecc.-, come pone in luce Hegel nei passi della logica dedicate ai lati della logicità.
Fichte pone ben in evidenza che non è contraddittorio rappresentare l’attività reale come un vortice e come un’espansione illimitata e infinita. Le due direzioni si connettono come la forza interiore al corpo che essa anima e in funzione del quale essa pulsa. La direzione centripeda è principio di vita e di coscienza, per la vita e la coscienza che, nella loro assolutezza, costituiscono un’attività “centrifuga all’ infinito”; un “quanto infinito”; l’interiorità profonda di una cosa e la sua espressione esteriore. La vorticosità è l’in sé, il principio che assume l’aspetto esterno e concreto di un’espansione che non lascia traccia, che potrebbe avere il suo riscontro ancor più concreto in una coscienza umana che volesse essere tutto, disperdendosi in una pluralità di interessi e di attività necessariamente superficiali, in cui costruisce alcunché, rimanendo vuota e superficiale.
“Pertanto la direzione centripeda e centrifuga dell’attività sono entrambe fondate allo stesso modo nell’essenza dell’Io; sono entrambe una e la stessa cosa e sono distinte solo in quanto si riflette si di esse come distinte”[12]
In conclusione, nell’agire assoluto dell’Io tutto dovrebbe prodursi ma nulla nasce concretamente. Tutte le determinatezze create sono riafferrate e annichilite nel vortice, in un’energia in continua, massima, esasperata espansione che non lascia alcuna traccia. Affinché nascano le determinatezze della coscienza e del mondo il vortice deve essere spezzato; l’attività infinita deve essere bloccata. Da qui la necessità di un urto assoluto che l’arresti, che la necessiti a rimbalzare molto meccanicamente all’indietro, riflettendo/ritornando su di sé e, con ciò, sopprimendo momentaneamente, con la prospettiva di frenarlo in continuazione, il suo moto espansivo.
“Ora però l’attività dell’Io che procede all’infinito deve essere urtata in un qualche punto e deve essere spinta all’indietro in se stessa e l’Io non deve perciò riempire l’infinità. Che ciò accada, come fatto, non può assolutamente dedursi dall’Io, come più volte abbiamo ricordato, ma si può certamente mostrare che deve accadere, se una coscienza reale deve essere possibile”[13]
Dunque l’agire assoluto dell’Io puro deve ricevere una limitazione-qui presentata come un vero e proprio urto meccanico-, affinché possa produrre, o meglio diventare una coscienza reale, dotata dell’ impulso, della possibilità e della capacità di sottrarsi continuamente al determinismo meccanico, autodeterminandosi coscientemente e codeterminando il proprio mondo. Per tentare di capire questa dialettica –che poi altro non è che la concretezza del movimento di passaggio al secondo principio in funzione del terzo, con il quale il filosofo costruisce per sé, in una estrema sintesi logico-trascendentale, proprio la coscienza reale e concreta dell’uomo- occorre intersecare le pagine, da cui sono tratte le ultime citazioni, con passi della parte teoretica.
Nella categorie di causalità l’urto assume l’aspetto di una cessazione dell’ attività dell’Io, o quanto meno di una riduzione della sua intensità, paragonabile a quella con la quale la luce lascia spazio ad una zona di oscurità.
“Se nello spazio continuo A ponete nel punto m la luce e nel punto n l’oscurità, allora, dal momento che lo spazio è continuo e che tra m e n non c’è nessun iato, tra i due punti deve necessariamente esserci un qualche punto o che è allo stesso tempo luce e oscurità, il che è contraddittorio. Ponete fra i due un termine medio, il crepuscolo. Se esso va da p. a q, allora il crepuscolo confinerà in p con la luce e in q con l’oscurità. Ma con ciò avete guadagnato solo una proroga; la contraddizione invece non è stata risolta in modo soddisfacente. Il crepuscolo è la mescolanza della luce con l’oscurità. Ora in p la chiara luce può confinare col crepuscolo solo per il fatto che il punto p è insieme luce e crepuscolo; infatti il crepuscolo è distinto dalla luce solo perché esso è anche oscurità, perché è insieme luce e oscurità. Proprio così anche nel punto q. Di conseguenza la contraddizione non è altrimenti risolta che con ciò: luce e oscurità non sono in generale opposti, ma solo da distinguere in base ai gradi. L’oscurità è semplicemente una piccolissima quantità di luce. Esattamente così stanno le cose fra l’Io e il Non-Io”.[14]
Questo “minore quanto di attività” rappresenta la sua passività, che viene quasi automaticamente riferita ad una realtà esterna indipendente –il Non-Io-, cui l’Io stesso, con questa sua vera e propria autolimitazione, comunica attività. Con questo arresto dell’Io –che può dirsi un suo atto con cui si apre ad una determinazione esteriore- nasce, mediante la sua passività, un opposto a sé riferito, che l’affetta meccanicamente attraverso i sensi, frenandone costantemente la tendenziale corsa all’infinito e, con ciò, consentendogli di scorrere a velocità rallentata –come scriverà Schelling nel 1799, a proposito della produttività assoluta della natura.
L’urto necessario all’agire assoluto potrebbe essere dunque un suo atto di autolimitazione nella forma di un arresto brusco della propria corsa a velocità infinita, ovunque riferito immediatamente ad una realtà esteriore destinata ad affettare la coscienza. Comunque sia, con un simile urto/autonomo arresto, l’attività dell’Io è costretta a flettere e a ripiegare su di sé. Si tratta di una riflessione permanente che Fichte chiama attività ideale, che non costituisce altro che la tendenza introspettiva della coscienza, la quale riflette costantemente su di sé, per sentirsi e per sentire l’esteriorità del mondo in rapporto a se stessa, per meditare sui propri passi e calcolarli.
L’attività ideale/riflessione/ripiegamento introspettivo e meditativo dell’agire dell’Io su di sé è, nell’Io, strutturale e permanente come la sua tendenza all’espansione creativa al di fuori di sé. Si desume con ciò che l’attività ideale freni costantemente l’attività reale –sempre però facendo riferimento alla realtà esterna e limitante del Non-Io- consentendole quella operatività concreta, cosciente e meditata in cui si esplicano la libertà e la creatività dell’uomo. Siamo allo snodo centrale dell’idealismo trascendentale: l’agire assoluto del primo principio, attraverso l’urto espresso dal secondo principio, si scinde in un’attività reale e in un’attività ideale dalla cui dialettica sorge l’Io reale e finito, rappresentato dal terzo principio.
Questa dialettica -come si evince certamente dal linguaggio utilizzato per esplicarla- non può prescindere dal riferimento dell’Io al Non-Io e, dunque, dallo scottante problema della sua origine a partire dall’Io che deve essere determinante su di esso.
Fichte afferma che il Non-Io è opposto a sé dall’Io mediante l’attività ideale, quando essa a sua volta riflette, cioè ritorna verso l’urto da cui è sorta, verso quella che potremmo definire la misteriosa zona di confine della coscienza finita, ove nasce la sua interazione con il Non-Io. Meglio sarebbe dire però che l’attività ideale pone il solo riferimento necessario dell’Io al Non-Io, la percezione –sul piano teoretico e su quello pratico- di un limite esterno, cui l’Io e l’urto che lo scinde devono far riferimento, per poter scendere nella concretezza empirica entro cui vive la coscienza. L’ambiguità di linguaggio è qui una necessità a fronte della complessità del problema, che del resto Fichte stesso, ad un dato momento -come visto-, dichiara incomprensibile per la ragione. Infatti, a nostro giudizio, nei testi del 1794 e del 1798, di esso sono chiari solo due aspetti. Il primo è l’esigenza idealistica che il Non-Io nasca dall’Io, affinché ne possa essere determinato e dominato. Il secondo è il movimento in base al quale l’Io, mediante la sua attività ideale, produce la semplice percezione della realtà esterna indipendente.
Questo secondo punto diviene ancor più chiaro se si fa riferimento alla dialettica di attività e passività, argomentata nella deduzione delle categorie: l’Io sopprime da sé la sua stessa attività e ne sorge di conseguenza una passività che viene semplicemente riferita alla realtà esterna e indipendente del Non-Io. Difficile dire di più, cioè aggiungere la seguente esplicita frase: dall’autosoppressione dell’attività dell’Io nasce il Non-Io.
La percezione di una realtà esterna limitante sorge, nelle facoltà teoretiche, dall’immaginazione produttiva che genera immagini di ancora vaghi e indefinibili ostacoli esteriori al suo slancio, nelle facoltà pratiche, dal sentimento che sente sopravvenire dall’esterno un impedimento all’ impulso egotico all’espansione continua.
Sul piano teoretico, Fichte deduce dall’immaginazione produttiva l’attività dell’intelletto, con cui sorge il concetto di un oggetto determinato che solidifica la sua quasi incerta e precedente immagine, che consentiva ancora alla facoltà immaginativa di fluttuare troppo liberamente oltre gli ostacoli oggettivi che essa incontra. L’intelletto fissa nel concetto il prodotto dell’immaginazione produttiva che, con ciò, diviene reale. Nel senso che il concetto produce demiurgicamente il suo oggetto?
“L’immaginazione produce realtà, ma in essa non c’è alcuna realtà; solo mediante la comprensione e il cogli mento dell’intelletto il suo prodotto qualcosa di reale. Noi non attribuiamo realtà a ciò di cui siamo coscienti come di un prodotto dell’immaginazione, l’attribuiamo invece a ciò che troviamo contenuto nell’intelletto, al quale non attribuiamo nessuna facoltà di produzione ma semplicemente di conservazione”[15]
Il concetto non produce l’oggetto; attribuisce chiara e distinta realtà alle produzioni inconsce dell’immaginazione che sembrano però essere semplici fantasie! Come sia possibile passare concretamente dalla coscienza alla realtà, senza ricadere nel realismo dogmatico e senza porsi sul piano dell’idealismo assoluto o dogmatico, continua essere un problema insoluto per la ragion teoretica.
Sul piano pratico, a fondamento dell’Io, è posto un impulso alla continua e illimitata attività di autoposizione; uno slancio creativo radicato nell’agire assoluto. Dato che esso, per diventare agire determinato di una coscienza concreta, esige sempre un urto che lo spezzi e istituisca l’equilibrio dialettico di attività reale e attività ideale, di Entselbsten e di Verselbsten, di cui si è parlato, l’ impulso può tradursi in un’attività umana solo se viene impedito, se viene trattenuto nella sua tendenza ad un’assolutezza che abbiamo visto essere la “notte nera” hegeliana. Questo impulso trattenuto si accompagna sempre e necessariamente al sentimento interiore di una coazione esteriore, riferita ad una realtà indipendente che affetta e limita l’Io. Si tratta del sentimento di ogni essere passivo e agito dall’esterno, che sta a fondamento di tutti i moti affettivi che condizionano meccanicamente la coscienza in rapporto alla presenza di oggetti e di situazioni esteriori.
Anche in questo caso, essendo il sentimento uno stato soggettivo della coscienza, dall’ urto sembra procedere la semplice percezione soggettiva del limite esterno, non il limite nella sua materialità e concretezza empirica. In moltissimi passi si ricava l’impressione che Fichte si ponga su di un piano realistico e consideri il Non-Io una realtà originaria rispetto all’Io finito, una posizione assoluta dello stesso livello dell’Io puro, che la dialettica illimitato/limitazione/limite deve, a partire dall’Io puro, rapportare in modo subordinato all’Io finito stesso.
Proprio in apertura della parte pratica, il discorso viene riaperto in un tentativo estremo di chiarimento, che forse chiarisce solo la contraddittorietà e la provvisorietà del pensiero fichtiano di questa fase.
Il Non-Io nasce dall’autolimitazione dell’Io Puro, con il cui atto esso, contemporaneamente, si realizza concretamente ed empiricamente in qualità di Io finito con un agire limitato e determinato. Con questo solo atto, dall’Io puro procedono sia il Non-Io che l’Io finito. Non a caso, proprio Francesco Moiso poneva sempre in luce la funzionalità del secondo principio al terzo, con cui appare, nella costruzione logico-trascendentale fichtiana -.ma a questo punto, è solo logico-trascendentale?-, la realtà della coscienza. L’Io puro o assoluto causa il Non-Io per poter causare mediatamente, cioè tramite il Non-Io stesso, l’Io finito e limitato.
Questi dubbi si potrebbero chiarire facendo riferimento alla versione del 1798, che presenta una più chiara teoria dell’immaginazione produttiva e un carattere metafisico immanentistico, in ombra nella costruzione volutamente logico-trascendentale del 1794; un carattere metafisico che, secondo Radrizzani, avrebbe potuto portare Fichte verso un idealismo assoluto di tipo hegeliano.[16]
L’opera, come noto, si articola in due serie: la prima è una deduzione delle condizioni trascendentali della coscienza reale, che ne costituiscono altresì la struttura metafisica; la seconda è una costruzione della coscienza reale stessa, in base ad esse, con cui si passa dal piano intelligibile a quello empirico.
Il concetto di Io –vale a dire la coscienza reale- è sempre costruita teoricamente in base alla dialettica illimitato/limitazione/limite enucleata, che ne pone a fondamento un volere puro che, arrestandosi, produce un oggetto mediante l’immaginazione produttiva e procede necessariamente a collocarlo nello spazio, attraverso una forza fisica. La coscienza, per sua struttura intelligibile, esige una dimensione fisico corporea, che non solo la limiti, ma che costituisca anche l’ambito e, nel contempo, lo strumento della sua azione reale. Essa può dunque agire solo entro la natura e attraverso un corpo, manovrato dalla volontà. L’oggettività reale nasce dalla sua utilizzazione, a partire dal lavoro –che Fichte, ne Lo stato commerciale chiuso, considera un fondamentale diritto e dovere sociale, che lo stato deve garantire al cittadino.
Nel passaggio al piano empirico, il volere puro si autocontrae, si scinde e si determina in una pluralità di uomini concreti, che vivono e operano in un contesto sociale, in una intersoggettività –in ombra nella Dottrina della scienza del 1794, dedotta chiaramente nella versione del 1798 e nella Dottrina del diritto che la precede. E’ sempre entro questa dimensione concreta e limitata che l’agire assoluto, che qui assume la forma di un volere puro proteso ad autosvolgersi molto hegelianamente, produce l’oggetto; ma ciò è possibile non per atto demiurgico originario, ma indirettamente, attraverso i limiti dell’ Io finito e del sua azione determinata e materiale, che si manifesta attraverso la forza corporea opportunamente manovrata, nel parlare come nel plasmare manualmente una materia prima. Sul piano empirico e concreto, che è l’unico piano in cui si realizza l’intelligibile, è l’Io finito a produrre Non-Io altrettanto finito, attraverso la sua componente naturale, dunque non egotica, animata e controllata dal principio assoluto che pulsa in lui.
In questo contesto diviene anche più chiara e concreta la funzione dell’immaginazione produttiva che immagina l’intelligibile –il volere puro e la sua dialetticità- nel tempo Essa spazia sull’intero campo delle sua possibilità di azioni, proiettandolo sulla forma temporale, frantumandolo, sensibilizzandolo, concretandolo in una pluralità di oggetti, di forze fisiche, di corpi in attività: nell’universo empirico organizzato. L’immaginazione produttiva è la facoltà con esso si costituisce in base alle strutture dell’intelligibile, che già però prevedevano che la volontà di accompagnasse ad una forza fisica, collocata in un corpo manovrabile, con il quale produrre un oggetto nello spazio. Tutto questo si concreta definitivamente in un complesso di coscienze umane operanti in una natura, ma che, unite in una intersoggettività, se ne emancipano per vivere in base a finalità coscienti e per creare un altro mondo, quello della cultura e della storia.
La coscienza umana e la sua libertà si fondano dunque su un’interazione dialettica fra l’oggettività della natura meccanica che l’affetta, mediante la sensibilità, e l’azione razionale che la protende costantemente ad emanciparsene. Quest’azione razionale nasce dalla sensibilità stessa, che assume un ruolo dialettico essenziale nella costruzione trascendentale della coscienza concreta. Infatti, la sensibilità è fondata sul sentimento di un impedimento esteriore all’attività reale di autoposizione dell’Io; impedimento pensato come condizione trascendentale del suo concretarsi in termini finitamente umani. Essa è dunque una fonte di condizionamento meccanico e di limitazione dell’Io, sorta unicamente per consentirne l’emancipazione razionale. Il sentimento e la sensibilità consentono di fatto all’ impulso -fichtianamente inteso, proprio quale tensione ad autoprodursi quale coscienza finita e determinata; “forza interiore che determina se stesso alla causalità”- di manifestarsi nell’azione pratica dell’Io, dal livello più elementare dell’Io bisognoso a quello più elevato dell’imperativo categorico. L’attività dell’Io, infatti, “può essere posta come ristabilita solo in quanto lo è come arrestata”; e noi sappiamo che dall’arresto procede il sentimento e la sua materializzazione in un oggetto naturale, attraverso l’immaginazione produttiva. La sensibilità stimola quindi la coscienza ad emanciparsi, a gradi crescenti, rispetto ai condizionamenti meccanici dell’ambiente oggettivo di vita.
Ciò è evidente sin dal desiderio, che protende l’Io, che ne è affetto e sente dolore, verso un qualcos’altro, “opposto a quanto è presente”, cioè alla situazione reale di mancanza che causa il bisogno. L’Io bisognoso, a questo punto, immagina un oggetto ideale che manca ed esce fuori di sé per crearlo realmente, soddisfacendo il bisogno. Una dialettica simile a quella del lavoro, presentata da Hegel nella teleologia finita, ma che non confina mai la coscienza umana in una pura dimensione economica, e meno che mai utilitaristica. Essa costituisce il punto di partenza di uno slancio verso l’imperativo categorico, che prescrive, razionalmente e coscientemente, all’uomo una vita di impegno razionale e cosciente ad emanciparsi costantemente da ogni condizionamento meccanico, per estendere costantemente le proprie capacità teoretiche e pratiche.
In conclusione la naturalità meccanica è il punto di partenza necessario e ineliminabile dell’esistenza umana, ma entro una costruzione trascendentale della stessa che le conferisce la possibilità di fuoriuscirne costantemente: da questa fuoriuscita nasce una nuova realtà oggettiva –quella della storia- nella quale noi uomini possiamo esercitare la nostra indipendenza razionale, di giudizio e di comportamento, rispetto ai riflessi meccanici che ci detta l’istinto –seguendo con ciò la legge morale kantiana-, e siamo chiamati a vivere in un contesto sociale totalizzante che, proprio in quanto tale –per coerenza fra la sua struttura e il nostro stile di vita-, esigerebbe comportamenti comunitari e solidaristici antitetici alla civiltà del “bourgeois”.
Questa dialettica dell’Io, a nostro giudizio, si inscrive nel nodo teorico illustrato, che ha il suo punto di partenza nel pensiero di J.J. Rousseau, nella sua nozione di libertà come emancipazione dal determinismo meccanico della natura. Per molti aspetti ne è la prima formulazione in termini rigorosamente categoriali e ne fa già emergere, con necessità, un’essenziale corollario politico, che diviene ancor più chiaro, se guardiamo, all’intero quadro della Goethe-Zeit: muoversi in società secondo principi di assoluta indipendenza individuale, che sono una permanenza del mondo meccanico della natura nel mondo olistico-totalizzante della cultura e della storia, crea le contraddizioni laceranti del mondo sociale del “bourgeois”; la sua realtà illiberale, alienata e alienante, che lo proporne come una “seconda natura” del tutto incontrollata dai soggetti collettivi umani, storicamente condizionati, che l’hanno generata.
 L’unico critico che ha visto, in modo chiaro, questa relazione fra Rousseau e l’Io di Fichte, è stato M. Rang che nota nella sua antropologia una dualismo corpo e spirito, passività e attività, sensibilità e razionalità, che le consente di passare da un originaria ispirazione cartesiana ad un soggettivismo di tipo fichtiano.[17]
L’unico critico che ha visto, in modo chiaro, questa relazione fra Rousseau e l’Io di Fichte, è stato M. Rang che nota nella sua antropologia una dualismo corpo e spirito, passività e attività, sensibilità e razionalità, che le consente di passare da un originaria ispirazione cartesiana ad un soggettivismo di tipo fichtiano.[17]
Ultima e fondamentale conseguenza è la tendenza quasi unanime –ereditata dalle migliori culture politiche del novecento- a proporre l’autenticità della libertà dell’uomo, nel quadro di mentalità, di comportamenti, di rapporti sociali comunitari e solidaristici, tesi sempre a valorizzare gli interessi e i momenti collettivi della vita umana e quel “qualcosa di più” dell’uomo –un “qualcosa di più” variamente inteso, perché in questa linea di pensiero vogliamo far rientrare anche Marx e il marxismo di impronta cominternista: ben altra cosa rispetto a quello gaudente alla Danton dei Centri Sociali e dello spinello libero!- che lo differenzia radicalmente dall’animale e che gli impedisce di soddisfare se stesso nelle banche, nei ludi vacanzieri di ferragosto e nello sperpero delle tredicesime natalizie!
Un’autentica libertà dell’uomo, proprio a partire da Rousseau e dal secondo Discorso, è pensabile e proponibile entro un modello sociale e politico armonicistico, a tratti organicistico, che segue i principi del modello teorico olistico-totalizzante, fondante sin dall’inizio le forme di socialità e la storia universale, che nascono dalla libertà dell’uomo. Per essere ancor più chiari, riproponiamo e riformuliamo, in questo nuovo contesto, le riflessioni sul problema, già presentate nel nostro Hegel critico dell’autoritarismo.[18]
Il filosofo ginevrino, nel Discorso sull’origine della diseguaglianza, delinea un percorso, storico fenomenologico, con cui l’uomo esce dall’ipotetico stato di natura ed entra in una stabile condizione di vita sociale, fondata su principi individualistici. L’analisi rousseauiana fa emergere nitidamente il carattere alienante e liberticida di questo modello sociale individualistico, che è la sostanza dei processi di modernizzazione capitalistici e liberali, già in atto in Nord America e in Europa: in esso l’ “essere” della persona umana è ridotto ad “apparenza” e sorgono, ad ogni livello, rapporti autoritari, che negano dal profondo ogni tipo di autentica libertà dell’uomo. Questa società è in sé contraddittoria: infatti, da un lato, essa nasce dalla libertà dell’uomo e dalla sua emancipazione rispetto ai condizionamenti meccanici della natura, dall’altro lato, essa degenera in un corpo estraneo, dispotico, profondamente illiberale. Essa si erge a nuova e “seconda natura” determinante, in modo quasi totalitario, mentalità, comportamenti e relazioni degli uomini associati, che l’hanno generata ma ne hanno perso completamente il controllo.
Una società individualistica –per essere più precisi, la società del “bourgeois”- è innanzitutto conflittuale: dato del resto che emergeva nitidamente dall’intero individualismo possessivo del secolo precedente, da Mandeville e dall’Illuminismo liberale.
Le pagine del secondo Discorso sulla conflittualità sociale sono troppo note, perché ci si soffermi qui in modo analitico. Più opportuno, a venti anni di distanza dalla pubblicazione del nostro Hegel critico dell’autoritarismo, è tornare a porre in rilievo il nesso che vi compare fra individualismo sociale/alienazione/autoritarismo politico, che riconferma l’idea del carattere dispotico di una società individualistica e alienante: dispotica sul piano culturale, economico-sociale e politico.
Lo stato sociale individualistico si forma quando più complessi si fanno i bisogni degli uomini e il relativo lavoro sociale necessario a soddisfarli, con beni non più offerti spontaneamente dalla natura. Sorge la divisione del lavoro e si formano i primi nuclei famigliari. L’uomo che entra in una simile condizione sociale è mosso dall’ “amor proprio interessato”: il suo solo “movente” è l’ “amore del benessere”. Nel solco della tradizione individualistico-possessiva, il rapporto sociale ha un carattere puramente strumentale: è il mezzo cui l’uomo deve ricorrere per soddisfare i propri bisogni, nel quadro di una vita economica che diviene sempre più complessa.
La società che si forma, con un simile processo di fuoriuscita dallo stato di natura, si fonda sui principi dell’individualismo possessivo di Locke, riproposti in chiave organicamente sociale da Mandeville: l’individuo si socializza per meglio appagare se stesso e i propri istinti utilitaristici; il contesto sociale deve garantirlo nella sua attività economica mercantile. La proprietà privata diviene naturalmente il pilastro delle istituzioni sociali, inscindibilmente connessa alla libertà individuale.
Un simile processo di socializzazione genera una crescente spersonalizzazione/alienazione della persona umana, funzionale alla ricerca della ricchezza economica e del potere.
“Ecco dunque tutte le nostre facoltà sviluppate, la memoria e l’immaginazione all’opera, l’amor proprio interessato, la ragione resa attiva. Ecco messe in atto tute le qualità naturali, e il rango e la sorte di ciascuno stabiliti … anche in base all’intelligenza, alla bellezza, alla forza o alla destrezza, al merito o alle capacità; e poiché queste sono le uniche in grado di procurare stime, ben presto bisogna averle o simularle. Per il proprio tornaconto, fu necessario mostrarsi diversi da come effettivamente si era. Essere ed apparire divennero due cose del tutto diverse; e da questa distinzione scaturiscono il fasto che abbaglia, l’astuzia che inganna, e tutti i vizi che ne formano il seguito”.[19]
Una società, sorta su presupposti individualistici e utilitaristici, esige che l’uomo entri nella considerazione altrui come dotato di tutte quelle qualità ritenute necessarie ad assicurargli successo e benessere economico. Se non le ha deve fingere di averle, con un processo di profonda spersonalizzazione, che significa automaticamente omologazione agli stereotipi dominanti, in linea con la contemporanea società dello spettacolo. Nasce la grande tematica dell’alienazione sociale! Ma cos’è questa omologazione se non il totalitarismo subdolo e nascosto della società capitalistica e liberale sin dalle sue origini? Una società che, per far funzionare a ritmi sempre più spasmodici i meccanismi di accumulazione privata, precostituisce mode e bisogni, inventandone di totalmente artificiali, se non innaturali, come, a pochi anni di distanza dalla pubblicazione delle opere di Rousseau, segnalerà con chiarezza la Rechtsphilosophie hegeliana.[20] Anche il “bourgeois” più opulento, che crede di essere libero nel suo benessere ostentato, conduce una vita di continue, nascoste imposizioni sociali.
L’analisi di Rousseau si sviluppa successivamente sul piano economico-sociale, ponendo in evidenza come lo stato sociale individualistico si rovesci in un sistema di dipendenze reciproche, in cui il povero dipende dai servigi del ricco e il ricco dai servigi del povero. Altro che libertà individuale nella ricerca dell’utile materiale! Ogni singolo individuo dipende dal meccanismo economico-sociale complessivo e ne è subordinato. Le relazioni economiche stesse sono coattive e illiberali, contraddittorie rispetto ai loro postulati di partenza, che volevano l’individuo libero di badare a se stesso con le proprie forze e la propria attività lavorativa. L’indipendenza si rovescia in una completa dipendenza reciproca.
Il discorso rousseauiano prosegue con il patto sociale iniquo, imposto dai ricchi, con il quale nascono le istituzioni politiche da loro egemonizzate e finalizzate a tutelarne le ricchezze. Si giunge ad un terzo livello di coazione: quella politica, rappresentata dal potere di istituzioni statali controllate dalle classi possidenti, contro chiunque voglia ridiscuterne il potere sociale.
Rousseau ci dice che “tutte le magistrature all’inizio erano elettive”, ma nel corso della storia esse tesero a diventare ereditarie, e a configurarsi come un patrimonio privato dei ceti più abbienti, con il consenso dell’intero corpo sociale. Per spiegare i motivi di questa deriva oligarchica ed autoritaria dei rapporti politici, Rousseau riprende il modello storiografico di Polibio, ponendovi alla base le crescenti disparità di ricchezze e la cultura del “bourgeois”, che affetta ricchi e poveri, come il consumismo più becero dei giorni nostri. Il “bourgeois” di ogni condizione sociale è talmente ripiegato sulla propria sfera materiale e privata di vita da considerare, come nella Roma repubblicana opulenta del II, I secolo a.C., la partecipazione alla gestione politica dello stato una pura perdita di tempo.
“…il popolo, già abituato alla subordinazione, al riposo e alle comodità di vita, e ormai non più in grado di spezzare le proprie catene, acconsentì, pur di assicurarsi la tranquillità, a lasciar aggravare la propria servitù; ed è così che i capi, diventati ereditari, s’abituarono a considerare la magistratura come un bene di famiglia, a considerare se stessi come i proprietari dello Stato, di cui all’inizio erano soltanto i funzionari.”[21]
Il modello sociale individualistico nega ad ogni suo livello i presupposti di libertà, da cui parte la condizione umana per emanciparsi dalla natura ed entrare nella storia universale. L’uomo può sottrarsi ad una simile condizione contraddittoria, solo se accetta di socializzarsi completamento, per diventare il “citoyen” del Contratto sociale e per vivere secondo valori e strutture solidaristiche e comunitarie. Ne nascerebbe un modello sociale armonicistico, i cui principi di priorità del tutto rispetto alla parte, sarebbero in sintonia con le strutture generali olistico-totalizzanti della vita sociale in sé e della storia. Si porrebbe con ciò fine alle laceranti contraddizioni di una società che, da un lato, non vorrebbe riconoscere la realtà e la validità di simili strutture, liberando l’individualismo più spettacolare e appariscente, e, dall’altro lato, le fa operare in modo immediato, incontrollato e subdolamente totalitario. La via di un’autentica libertà dell’uomo, nella sfera politica, è la costruzione di armonie sociali, ispirate di fatto al mondo classico greco, in alternativa alla società lacerata e conflittuale della borghesia liberale. La libertà esige il superamento della lacerazione sociale!
Su questa linea, l’influsso di Rousseau e, nello specifico, del secondo Discorso, sull’intera classicità tedesca è diretto e decisivo; ne sono testimonianza un frammento hegeliano del 1795 e la VI lettera sull’educazione estetica di Schiller. Hegel, ad esempio, vi descrive il processo di decadenza della polis con uno schema concettuale polibiano, del tutto simile a quello utilizzato dal Ginevrino. Non ci soffermiamo sullo scritto in questione, perché da noi ampiamente trattato altrove. Torniamo solo a metterne in luce le conclusioni convergenti con quelle rousseauiane. L’individualismo sociale si accompagna alla lacerazione, alla conflittualità e ad una crescente apatia politica che agevola la trasformazione in senso oligarchico e autoritario dello stato: L’autoritarismo politico è dunque consequenziale ai meccanismi profondi di una società lacerata e alienante e della sua cultura individualistica e utilitaristica. Nel contesto di una società individualistica non trova mai spazio la libertà autentica dell’uomo, quale emancipazione dal condizionamento meccanico dello habitat oggettivo di vita.
Schiller riprende la problematica, connettendo con organicità lo stato di lacerazione interiore della soggettività umano, alla lacerazione di un corpo sociale, frantumato atomisticamente: lacerazione soggettiva e lacerazione sociale.
Facendo riferimento alle Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, nello specifico alla VI lettera, la lacerazione soggettiva appare come il principio culturale dominante della società moderna; il presupposto logico e storico di un processo di disgregazione che la trasforma in un puro e semplice aggregato meccanico, all’interno del quale individualità e gruppi sociali, sono animati da finalità particolari e conflittuali. Scrive Schiller:
“Infatti noi vediamo non solo singoli soggetti, ma intere classi di uomini, sviluppare solo una parte delle loro attitudini, mentre le altre, come nelle piante deformi, sono appena accennate con deboli tracce.”[22]
Su simili basi si giunge al modello sociale individualistico che, con un necessario movimento logico e storico, si trasforma nel citato meccanismo oggettivo estraneo e coattivo. Le conseguenze politiche sono le stesse poste in evidenza da Rousseau e da Hegel: nasce uno stato dominato da una ristretta oligarchia, che governa in modo autoritario, senza più legami con l’interesse pubblico.
“E così poco a poco viene distrutta la singola vita concreta, affinché il tutto astratto possa conservare una vita insufficiente, e lo stato rimane sempre estraneo ai suoi cittadini, perché il sentimento non riesce mai a trovarlo…la classe governante finisce col perdere di vista l’umanità stessa, confondendola con un semplice prodotto dell’intelletto; e il governato non può che ricevere con freddezza le leggi, così poco direttamente rivolte a lui…la società positiva si dissolve moralmente in uno stato di natura…nel quale il potere pubblico è soltanto un partito di più, odiato e ingannato da colui che lo rende necessario, e rispettato soltanto da chi potrebbe farne a meno.”[23]
Prima e fondamentale lacerazione, che si apre storicamente nel processo di passaggio dalla civiltà greca alla civiltà moderna, è quella fra ragione e sensibilità, cui segue la divisione fra le varie facoltà e “attitudini” umane. Nasce la divisione del lavoro e si giunge ad uno sviluppo culturale e materiale fondato sulla specializzazione delle competenze e dei ruoli. Si passa da una società armonica e libera, come quella della polis greco-classica, ad una società individualistica, disgregata atomisticamente e illiberale.
“Quella natura di polipo propria degli stati greci, in cui ogni individuo godeva di una vita indipendente e, se necessario, poteva diventare un tutto, fece posto ad un artificioso congegno, in cui dall’accozzamento di particelle infinite ma inanimate, si forma nel tutto una vita meccanica…Eternamente legato solo ad un piccolo frammento del tutto, l’uomo stesso si forma solo come frammento…anche la scarsa relazione che unisce ancora i singoli membri al tutto non dipende da forme che essi si diano liberamente (poiché come si potrebbe affidare alla loro libertà un meccanismo tanto artificioso e pauroso della luce?), bensì viene loro prescritto con scrupoloso rigore da un formulario, in cui si tiene legata la loro libera intelligenza.”[24]
In modo più specifico, tre sono i nessi logici, con cui si passa dalla lacerazione soggettiva a quella sociale:
1) la divisione fra le facoltà e le attitudini del soggetto determina uno sviluppo sociale fondato sulla specializzazione, con la conseguenza di irrigidire progressivamente individualità e gruppi sociali entro interessi e competenze particolari, allentandone i legami reciproci e distruggendo il sentimento di appartenenza comunitaria;
2) in base a questa cultura della specializzazione, che si esaspera nella modernità capitalistica, anche la ragione si sviluppa astrattamente rispetto alla sensibilità, con la quale originariamente era in perfetta sintonia; ne nasce una razionalità astratta e analitica, incapace di sintetizzare la vita individuale e collettiva e, quindi, di proiettare l’uomo verso le armonie comunitarie;
3) la scissione, qui delineata, fra razionalità e sensibilità ha l’estrema conseguenza di abbandonare quest’ultima esclusivamente agli istinti materiali ed egoistici della sua dimensione fisico-corporea; con ciò la razionalità astratta e analitica e la cultura della specializzazione si connettono sempre più strettamente alla cultura egoistica del “bourgeois”.
Un simile contesto sociale e culturale ha necessariamente delle conseguenze politiche autoritarie: come, nella soggettività scissa kantiana, la legge morale deve essere imposta alla sensibilità, così, in una società composta da individualità-atomo, che tendono a sfuggire al dovere civico, la legge deve essere applicata con la forza di polizia e lo stato diviene –come nel liberalismo di Locke- un meccanismo autoritario. La lacerazione soggettiva, che parte dalla scissione fra ragione e sensibilità –tematica per altro presente, anche nell’opera di Rousseau, in particolare nella Nuova Eloisa-, si lega organicamente alla lacerazione individualistica del corpo sociale, costituendone di fatto, nell’analisi schilleriana, il fondamento logico e storico.
A questo punto, la ricerca di uno stato sociale, che sia condizione oggettiva e stimolo di libertà autentica dell’uomo, deve porsi al di fuori dell’individualismo sociale del “bourgeois” e caratterizzarsi in senso armonicistico. Solo una comunità armonica e sinfonica, come la musica della nona sinfonia di Beethoven –che culmina non casualmente nell’ “Inno alla gioia” di Schiller- può consentire all’uomo di muoversi in autonomia rispetto ai condizionamenti meccanici dell’ambiente e dell’istinto e di ricostruire le armonie della sua stessa soggettività: argomento, quest’ultimo, tipicamente schilleriano, ma che trova anch’esso radici profonde nel pensiero di J.J.Rousseau.
In questo contesto, come accennato, è lo stesso concetto hegeliano di Geist –quale “più alta definizione dell’assoluto”- a rivelarsi in sintonia con la nozione di libertà rousseauiana.
Questa la definizione, che si trova nell’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:
“L’essenza dello spirito è pertanto, sotto il profilo formale, la libertà, l’assoluta negatività del concetto come identità con sé. Secondo questa determinazione formale, esso può astrarre da ogni cosa esterna e dalla propria esteriorità, dal proprio essere determinato; esso può sopportare la negazione della propria immediatezza individuale, il dolore infinito, vale a dire, esso può, in questa negatività, conservarsi in maniera affermativa ed essere identico per sé. Questa possibilità è la sua universalità entro sé, astratta e per sé essente.”[25]
Sostanza dello spirito è la libertà, che richiama la struttura del “concetto” logico, in quanto unità negativa a sé, vale a dire negazione della negazione: un principio dinamico di autosvolgimento, inteso nella sua piena effettualità e concretezza. Questa effettualità viene anche indicata con il termine “dasein”, tradotto nell’edizione UTET della Grande Enciclopedia con “essere determinato”.
Per comprendere pienamente queste affermazioni, è inevitabile far riferimento all’apparato categoriale, che sta a fondamento della definizione dell’assoluto e della Scienza della logica. La negazione della negazione è principio di autosvolgimento controllato, in base al quale ogni aspetto particolare della realtà spirituale –uomo, istituzioni, storia universale, cultura- riflette sulla propria immediatezza, la nega e passa ad altro e, nel contempo, riflette sul proprio riflettere, nega il proprio negarsi e ritrova la propria identità nell’altro in cui si è posto. E’ quel “movimento del porre se stesso”, della “mediazione del divenire-altro-da-sé con se stesso”, con il quale Hegel definisce sinteticamente la struttura dell’assoluto nella “Vorrede” alla Fenomenologia dello spirito.
Ogni determinatezza, in cui si articola il mondo dello spirito –uomini, popoli, civiltà, sistemi concettuali- in sé e per sé stessa tende a mutare radicalmente il proprio aspetto, ad evolversi bruscamente, con il rischio di non riconoscersi più nelle forme assunte, ma anche con l’essenziale capacità di controllare questi mutamenti e di ritrovarvi la propria identità. Il modello di riferimento potrebbe essere un popolo che progredisce, esprime rapporti economici, sociali, politici, ecc. completamente diversi, rispetto a quelli originari, senza però stravolgere la propria identità culturale e i propri valori, mantenendo nell’individualismo moderno il tradizionale sentimento di appartenenza comunitaria.
Prendiamo la crescita della persona umana, che è investita, soprattutto nel passaggio dall’infanzia alla maturità, da convulsi cambiamenti, che rischiano spesso di lacerarne la soggettività, di porre in crisi l’insieme delle relazioni famigliari ed amicali dei primi anni di vita. Si tratta di una negazione della propria immediatezza infantile, cui deve seguire logicamente il negare la negazione e il ritrovamento di sé nelle nuove vesti di adulto e nelle altrettanto nuove relazioni affettive e sociale, che l’individuo in crescita ha espresso: il controllo dei cambiamenti, la continuità del suo carattere, la riconferma, su di un piano di maggiore maturità, degli affetti familiari, ecc. Se questo non succede, il processo di crescita diviene una crisi lacerante, che rischia di creare drammi personali e familiari di cui sono piene le cronache contemporanee.
Precisato questo, mettiamo in rilievo due altri aspetti del concetto di Geist: il suo rendersi effettuale nel Dasein e la definizione della libertà, che ne costituisce la sostanza come “il non dipendere da altro” –“das Nichtabhängigsein von einem Anderen”-, “il rapportarsi a se stesso” –“das Sichaufsichselbstbeziehen”. Lo spirito è principio di autosvolgimento dialettico, potenzialmente controllabile, che vive in un Dasein, in un esser determinato, che deve giungere ad una condizione di libertà che è un non dipendere da un’alterità, un rapportarsi sempre a sé nella propria esistenza senza alcun condizionamento decisivo che sopravvenga meccanicamente dall’esterno. Si tratta di una condizione di autodeterminazione, che deve caratterizzare ogni manifestazione particolare dello spirito, dalle individualità umane ai popoli, che si emancipa dal meccanismo imperante in natura, e che si concreta sempre in un sistema complesso e totalizzante di relazioni: la società per gli individui, la storia universale per i popoli.
La dialettica del Geist è qui da leggersi in base a due movimenti dialettici intrecciati, che stanno proprio alla base della categoria logica di “Dasein”, come di quella di “concetto”: il movimento del particolare autosvolgentesi e il movimento del ritorno di questo particolare autosvolgentesi all’universale. In modo più concreto, abbiamo sempre una determinatezza particolare che si deve autosvolgere e autodeterminarsi, in condizioni di libertà e di autocontrollo, in un sistema complesso e totalizzante, entro il quale deve consolidare dialetticamente –in linea con la categoria di Aufhebung- la propria autonomia e la propria originalità individuale.
Diviene a questo punto indispensabile una breve digressione sulla logica, nello specifico sulle prime quattro categorie della logica dell’essere: “essere”, “nulla”, “divenire” ed “essere determinato”. Ivi i movimenti dialettici che s’intrecciano sono tre: il primo è la dialettica universale/particolare, con cui si passa dall’ “essere” all’ “esser determinato”, e i due movimenti dialettici già citati, la dialettica del particolare autosvolgentesi e la dialettica particolare/universale, con cui esso ritorna all’universale e in esso si muove organicamente; questi ultimi due movimenti riguardano proprio l’ “essere determinato”, o “Dasein”, e, da questo momento logico in avanti, la struttura stessa dell’assoluto e della realtà effettuale che dall’assoluto procede.
L’ “essere”, inteso come puro essere, è l’assolutamente indeterminato, privo di qualsiasi contenuto: In questa sua assoluta assenza di determinazioni trapassa nel “nulla”, seconda categoria della logica, inteso non come il non esistente, ma come quella stessa indeterminatezza che costituisce il vuoto “essere”. Su queste basi, “essere” e “nulla” trapassano immediatamente e continuamente l’uno nell’altro; e questo loro movimento del trapassare –il “divenire”, terza categoria- costituisce la verità di entrambi. Il “divenire” è unità di “essere” e “nulla”: entrambi si tolgono nella loro reciproca indipendenza e si pongono come momenti di una relazione assolutamente e immediatamente dinamica, che li accomuna. In quanto essi, in questo loro “divenire” dileguano altrettanto immediatamente l’uno nell’altro, dilegua anche il “divenire” stesso, che ne costituisce la citata relazione unitaria. Nella Grande Enciclopedia, il “divenire” è paragonato ad un fuoco che brucia gli elementi che lo alimentano, sino ad estinguersi. Da esso risorge l’unità quieta, nelle vesti di un “esser determinato”: il “Dasein”.
N.Hartmann, proprio ponendo in luce come dal “divenire” scaturisca ogni determinatezza particolare, afferma che esso sta a fondamento di ogni realtà.
Con la dialettica di queste prime categorie, si è passati dall’universale al particolare: l’unità immediata originaria, per sua intrinseca necessità si è lacerata in una molteplicità di particolarità, che altrettanto necessariamente si pongono in un sistema complesso di relazioni, non foss’altro che per il fatto l’una è un limite per lo sviluppo di tutte le altre.
All’inizio della logica, Hegel stabilisce l’articolazione dell’assoluto, e dunque della realtà che ne è l’autosvolgimento effettuale, in una molteplicità di singoli caratteri particolari entro una totalità relazionale; cioè a partire dai singoli uomini, chiamati ad esprimersi, con vocazioni, interessi differenti, ecc., entro i rapporti sociali e politici delle comunità nazionali di appartenenza .
Dunque, non ritornando più il “Dasein” all’unità immediata e originaria dell’ “essere”, l’universo, per sua struttura razionale ontologica, è una pluralità organizzata e interdipendente di determinatezze, esistenze particolari, in sé dinamiche; e non possono più essere pensate e tollerate strutture totalizzanti che esigano la completa omogeneità, sul modello della categoria dell’ “essere”, che sta ormai, irreversibilmente alla spalle del movimento di autosvolgimento dell’assoluto.
Riteniamo che, per sua intrinseca necessità, il “Dasein” potrebbe già innescare gli altri due movimenti dialettici, e proporsi in veste di individualità particolare che si autosvolge e si autodetermina, in modo controllato, entro un sistema totalizzante sempre più complesso e avvolgente, che essa stessa contribuisce a creare, interagendo con ogni altra individualità.
Il “Dasein” è infatti definito in termini di unità di affermazione e di negazione. Come negazione, esso riflette sulla propria immediatezza e la nega, assumendo altri caratteri, esattamente come il bambino nella sua crescita, come un popolo che progredisce nella storia. Come identità è in grado di riflettere sul suo riflettere, di negare il suo negarsi, ritrovando la propria identità qualitativa nell’alterità cui è passato e, dunque, controllando il proprio processo di cambiamento., come il bambino e il popolo, progredendo, possono mantenere inalterati i caratteri essenziali, il loro “DNA” specifico.
Abbiamo succintamente descritto un autosvolgimento dialettico controllato del particolare, che è in grado di erigerlo a soggetto individuale e personale libero, nel contesto totalizzante in cui si radica, interagendo con tutti gli altri processi di crescita individuali o di gruppo. Il sistema di appartenenza condiziona certamente le determinatezze che ne fanno parte –gli uomini associati; i popoli nella storia universale, ecc.-; ma un soggetto libero, individuale e collettivo, è in grado di rielaborarli criticamente, facendone uno stimolo autonomo e coscientemente elaborato al proprio sviluppo.
Il “Dasein”, in questa prima fase della logica, ha solo potenzialmente in sé le due citate dialettiche, che partono dal particolare, nella sua intrinseca negatività riferita a sé. Per il resto, inscrivendosi nella logica dell’essere, ove è dominante l’identità affermativa ed immediata con sé, rimane fissato su se stesso dall’elemento logico intellettuale, esposto a condizionamenti esteriori. Nel corso del movimento logico dell’assoluto, altre categorie porteranno lentamente a maturazione le due dialettiche, dal “vero finito” alla “Wirklichkeit”, sino a proporre nel concetto un principio soggettivo, di autonomo autosvolgimento nel quadro di un sistema crescentemente complesso di relazioni, definito da Hegel stesso come “Io”. La sua effettualità si trova proprio nel Geist, la cui “universalità è anche il suo esser determinato”. Hegel non usa mai i termini a caso, per cui siamo legittimati a pensare che si riferisse al “Dasein”, che, scaturendo direttamente dall’originaria lacerazione dell’unità immediata in una molteplicità dinamica e interagente, pone le strutture razionali e dialettiche fondamentali della realtà: determinatezze particolari che sono soggetti individuali liberi e creativi, entro sistemi totalizzanti, a partire dalla coscienza umana, chiamata fichtianamente alla libera autodeterminazione razionale e a creare, in uno sforzo collettivo potenzialmente e doverosamente armonioso, il proprio habitat di vita; la società, le istituzioni, la storia, la cultura.[26]
Il testo introduttivo alla filosofia dello spirito lo conferma analiticamente in molti punti; ne citiamo uno, in particolare, da cui si evince la dimensione concreta, corporea e finita, entro cui si manifesta lo spirito, sul modello dell’Io di Fichte.
“Lo spirito non è qualcosa di quieto, all’opposto è l’assolutamente inquieto, la pura attività, la negazione o l’idealità di tutte le fisse determinazioni intellettuali: non astrattamente semplice, ma, nella sua semplicità, al tempo stesso un differenziarsi da sé. Non un qualcosa di già compiuto prima del proprio manifestarsi, che se ne stia nascosto dietro la montagna dei fenomeni; al contrario, esso è veramente ed effettivamente reale solo mediante le forme determinate del proprio necessario manifestarsi; non è … un’anima-cosa in rapporto solamente esterno coi corpi, ma è legata intimamente con il corpo mediante l’unità del concetto.”[27]
 Di importante, nella citazione, per il discorso sin qui condotto, è la presa di distanza rispetto alla tradizionale psicologia metafisica: lo spirito non è un’anima separabile dalla corporeità in cui opera, né è la negatività immanente che nel corpo, nei limiti finiti, spazio-temporali, che esso determina, trova il suo unico luogo di residenza e di realtà, in consonanza con una teoria dell’assoluto coerentemente immanentistica, come ben evidenziato da Düsing e da Taylor[28], e in continuità con l’idealismo jenese di Fichte.
Di importante, nella citazione, per il discorso sin qui condotto, è la presa di distanza rispetto alla tradizionale psicologia metafisica: lo spirito non è un’anima separabile dalla corporeità in cui opera, né è la negatività immanente che nel corpo, nei limiti finiti, spazio-temporali, che esso determina, trova il suo unico luogo di residenza e di realtà, in consonanza con una teoria dell’assoluto coerentemente immanentistica, come ben evidenziato da Düsing e da Taylor[28], e in continuità con l’idealismo jenese di Fichte.
Rousseau si può dunque collocare alla base di un’articolata e possente corrente di pensiero, che va ben oltre l’illuminismo e che, per lo più, è critica nei suoi confronti, come Rousseau fu critico degli enciclopedisti.
Vi è un altro aspetto della filosofia rousseauiana, che ne conferma l’antitecità rispetto al razionalismo illuminista, a dispetto di Derathé[29] e dei suoi ancora numerosissimi seguaci, e che lo colloca all’origine della filosofia classica tedesca: l’estetica, come teoria del sentimento, e la connessa estetizzazione della politica. Ne facciamo un rapido cenno, avendola già trattata ampiamente in altri nostri saggi, cui facciamo riferimento in nota.
La fuoriuscita dell’uomo dallo stato di natura, descritta dal secondo Discorso, è un processo di socializzazione e di crescita culturale distorto, che muta l’originaria natura umana e che sfocia nella società alienata e illiberale del “bourgeois”. Questo processo acquista i caratteri citati, perché l’uomo perde l’istinto alla “pietà”, con il quale l’aveva creato Dio: un istinto di carattere superiore a quello materiale e radicato nell’anima umana, con il quale egli poteva comportarsi spontaneamente in modo altruistico e buono.
Una problematica in linea –come abbiamo cercato di dimostrare- con la linea metafisica dell’ estetica britannica del “sentimento”, espressa dalla filosofia di Shaftesbury; autore, cui prima Cassirer, poi Derathé, negano a torto dirette influenze sul pensiero rousseauiano, legandolo piuttosto a Diderot, che ne tradusse, all’epoca, l’opera in francese.
Rousseau ne ripropone l’estetica, storicizzandone il problema e traendone le conseguenze politiche: l’uomo l’ha persa la dimensione istintiva dell’anima in un dato processo storicamente determinato che ha condotto ad una condizione sociale, culturale e politica, da lui considerata negativamente. Dunque l’alternativa alla società del “bourgeois” –vale a dire la società del “citoyen”- si deve fondare sulla ricostruzione di questa istintività spirituale, simpatetico-altruistica. La questione sta al centro dell’Emilio.
Non si può, a nostro giudizio, non vederne l’affinità con la problematica estetica schilleriana, che ha già in sé –come pone anche in luce la Siefert[30] – un aspetto politico, poi esaltato da Hegel; aspetto politico che certamente non si poteva trovare nel pensiero di Shaftesbury.
Ancora una volta Rousseau si rivela un punto di riferimento prioritario, ineludibile per la filosofia classica tedesca, sottovalutato da chi si ostina a collocarlo in coda all’Illumismo, riservandogli alcuni magri paragrafi dei manuali scolastici.
Il ruolo specifico di Rousseau non è solo da valorizzare al massimo livello, in rapporto alla filosofia tedesca, ma anche nel più ampio contesto della storia della cultura europea, e non solo relativamente al sette-ottocento. Fra sei e settecento, in stretta interdipendenza con l’avanzata delle forze produttive e dei rapporti sociali di produzione capitalisti, diventano egemoni linee di pensiero e valori utilitaristici e individualistici, che entrano in profonda contraddizione con una tradizione a carattere etico e comunitario, che costituisce il sostanziale metastorico dell’Europa; una tradizione che dalla classicità greco-romana, al cattolicesimo medioevale, sino all’umanesimo del quattrocento, ha sempre pensato l’uomo radicato nella comunità politica di appartenenza, proiettato verso l’universale, orientato nell’esistenza verso valori sovramondani. Rousseau, in uno dei momenti storici di più alta tensione di questa contraddizione ha ripensato l’uomo moderno e i suoi rapporti politici sulla base di questa tradizione, e con ciò ha dato precise indicazioni su come ripensare i processi di modernizzazione, in atto in Occidente, su basi dialettiche, in conformità con i valori profondi della nostra storia.
In questo senso Rousseau costituisce un vero e proprio heideggeriano Ereignis, che getta luce sulle radici più autentiche di una civiltà, erigendosi a faro per chi vuole conservarle, muoversi e progredire in base ad esse, senza quegli strappi devastanti che stanno alla base di paesi senza storia, forti materialmente ma deboli spiritualmente, come gli Stati Uniti d’America. Su simili basi, nell’immediato, è nata la corrente giacobina della modernità, caratterizzata da una profonda anima etico-comunitaria e spiritualista, in base alla quale è entrata in contraddizione ideologica e strategica con l’alta borghesia illuminista della Rivoluzione francese, sino a bloccarne , nell’autunno del 1793, –come porrà in luce indispettito lo storico liberale Michelet- l’opera di distruzione del cattolicesimo in Francia[31]. Più in generale, nasce un’intera linea di pensiero che si dipana da Fiche a Hegel, da Marx a Gentile, orientata a criticare dialetticamente la modernità liberale e illuminista e a ripensarla in forme conformi e adeguate alla tradizione europea[32].
[1] Per una ricostruzione della fortuna di Rousseau in Germania, nell’età considerata, si veda soprattutto R.Trousson, J.J.Rousseau et son ouvre dans la presse periodique allemande de 1750 a 1800, in “Dix-huitième siècle” 1 (1969), pp. 289-310 (I) e 2 (1970), pp. 227-264 (II). Una riflessione cricita più analitica e aggiornata dei rapporti fra la sua filosofia e la cultura tedesca, con riferimenti specifici alle interazioni con Lessing e Wieland, si trovano nel volume collettivo Rousseau in Deutschland. Neue Beitraege zur Erforschung seiner Rezeption, a cura di Herbert Jaumann, Walter de Gruyten, Berlin-New York, 1995.
[2] in “Das Neueste aus dem Reiche des Witzes”, aprile 1751.
[3] Ch.Jamme, Ein “ungelehrtes Buch”. Die philosophiesche Gemeinschaft zwischen Hoelderlin und Hegel in Frankfurt 1797-1800, “Hegel-Studien” Beiheft 23, Bonn 1983.
[4] R.Wokler, Rousseau, Il Mulino, Bologna 2001 (I edizione Oxford-New York 1995)
[5] Sull’antropologia materialistico-meccanica di Hobbes, si veda F. Ingravalle-R. Pallavidini, Il Busto di Giano, Noctua, Torino, 2001 p. 63 e seg.
[6] T.Hobbes, Opera latina, Scientia Verlag. Adlen Germany 1966 (I edizione London 1939), vol. II, pp. 95-96.
[7] Sul rapporto Rousseau-Robespierre, rimandiamo ancora a Il Busto di Giano, cit., pp. 105-106.
[8] L. Pareyson, Fichte. Il sistema della libertà, Mursia, Milano 1950, p. 127
[9] J.G.Fichte, Sämtliche Werke, cit., vol. I, p. 274.
[10] J.G.Fichte, op. cit., p. 240
[11] Espressioni queste –Entselbsten e Verselbsten-, utilizzate da R. Bodei, nel suo saggio Scomposizioni, Einaudi, Torino 1987.
[12] J.G. Fichte, Sämtliche Werke, cit., vol. I, p. 274.
[13] J.G.Fichte, op. cit., p. 279.
[14] J.G. Fichte, op. cit., pp. 144-145.
[15] J.G.Fichte, op.cit., pp. 233-234.
[16] I.Raddrizzani, Vers la fondation de l’intersubjectivité chez Fichte, Libraire philosophique J.Vrin, Paris 1993
[17] M. Rang, J.J. Rousseaus Lehre vom Menschen, Göttingen, 1959
[18] R.Pallavidini, Hegel critico dell’autoritarismo. Il confronto critico con la Rivoluzione francese alle origini dei modelli teorici del giovane Hegel, Arnaud, Firenze 1993.
[19] J.J. Rousseau, Ouvres complètes, Galimard, Paris 1967, vol. III, p. 232.
[20] Si veda, ad esempio, il modo in cui Hegel inquadra dialetticamente il problema delle mode e dell’artificialità dei bisogni, indotti dall’industria capitalista, per esigenze di continua espansione della produzione, che compare già negli scritti di Jena e successivamente nelle Rechtsphilosophien berlinesi: S. Avineri, La teoria hegeliana dello stato, Laterza, Bari 1973 (I edizione, Cambridge 1972); R. Pallavidini, Hegel critico dell’autoritarismo, cit.; F.Ingravalle-R.Pallavidini, Il Busto di Giano, cit.
[21] J.J.Rouseeau, Ouvres complètes, cit., vol. III, p. 241.
[22] F. Schiller, Über Kunst und Wirklichkeit, Leipzig 1975, p. 271
[23] F.Schiller, op. cit., p. 278.
[24] F.Schiller, op. cit., pp. 276-277.
[25] G.W.F.Hegel, Werke, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, vol. 10, pp. 25-26.
[26] Su queste tematiche logiche, si vedano R.Pallavidini, Hegel critico dell’autoritarismo, cit. e Introduzione alla Filosofia Classica Tedesca, Noctua, Torino 1999.
[27] G.W.F. Hegel, Werke, cit., pp. 11-12.
[28] K.Düsing, Das Problem der Subjektivität in Hegels Logyk, Hegel-Studien, Beiheft 15, 1976 e Ch.Taylor, Hegel e la società moderna, Il Mulino, Bologna 1984 (I edizione Cambridge 1979).
[29] R.Derathé, Le rationalisme de J.J.Rousseau, Presses universitaires de France, Paris 1948 e J.J.Rousseau et la science politique de son temps, Libraire philosophique J.Vrin, Paris 1950 (traduzione italiana a cura di Nicola Matteucci, Bologna, Il Mulino 1994).
[30] A.G.Siefert, Hegel-Studien, Beiheft 25 1984.
[31] Il giudizio di Michelet e la componente religiosa della personalità e dell’opera di Robespierre –componente scolorita da Mathiez e dalla storiografia marxista, in un generico deismo razionalista- sono stati riproposti da H.Guillemin, Robespierre politico e mistico, Garzanti, Milano 1989 (I edizione, Edition du Seuil 1987).
[32] Chiudiamo questo saggio con un’osservazione in nota che fuoriesce dal suo argomento specifico. Raccontava Moiso che Pareyson scrisse il suo fondamentale saggio su Fichte, quando egli prestava servizio al Liceo classico di Cuneo. Nell’ambito del liceo gentiliano un insegnante era considerato e voluto come uomo di grande cultura, impegnato a costruire autonomamente cultura, non didattica con cui divulgare, a sempre più infimo livello, idee altrui, acquisite in corsi di aggiornamento e tramite manuali sempre più semplificati, come succede oggi nella scuola berlingueriana. Il suo tempo lavoro era stato sapientemente costruito, da quel grande pedagogo, che rispondeva al nome di Giovanni Gentile, per consentirgli un lavoro di costante approfondimento dei classici della filosofia, della storiografia, ecc. In questo quadro, Luigi Pareyson ebbe tutto il tempo e tutti gli stimoli, che egli necessitava per studiare Fichte e scrivere un testo critico, che è stato una pietra miliare nella storia della critica fichtiana. Ma che cosa sarebbe successo, se gli fossero state imposte le 80 ore, i corsi di aggiornamento, i pagellini per le famiglie, e tutte le altre idiozie pietistico-burocratiche, che hanno declassato la classe docente italiana e rovinato la nostra scuola di ogni ordine e grado?