A novanta anni dalla morte di Lenin (1924 – 2014)
gen 22nd, 2014 | Di Costanzo Preve | Categoria: Teoria e critica|
Riproponiamo un vecchio Articolo di Costanzo Preve a 90 anni dalla morte di Lenin A ottanta anni dalla morte di Lenin (1924-2004)
|
Lenin è morto ottanta anni fa (1924-2004). Ottanta anni sono un buon periodo storico per fare un bilancio. Inoltre, la mummia di Lenin non è ancora stata seppellita, ma Lenin ha da tempo cessato di essere il Grande Ideologo della legittimazione del Socialismo Reale. I sacerdoti, dopo aver bruciato sul rogo per settanta anni i dissenzienti, i pagani e gli eretici, sono passati dall’altra parte a celebrare i riti di nuove divinità vincitrici. Classico. Come Marx, Lenin è oggi “inattuale”. Anzi, lo è ancora di più, perché Marx può sempre prestarsi a chiacchiere generiche sull’emancipazione umana o sullo scandalo del divario fra ricchi e poveri, e diventar così un testimonial prestigioso ed innocuo del movimento No Global. Lenin no. Lenin è uno che ci ha provato, e non si è limitato ad operazioni mediatiche ed a proclamazioni testimoniali.
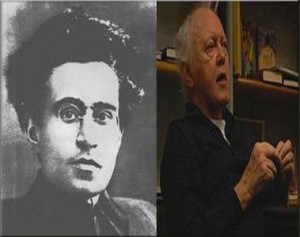 Per questa ragione Lenin è particolarmente odiato. Lenin è uno che ci ha provato, e per questo la sua memoria deve essere diffamata ed esecrata. Le considerazioni che qui svolgo sono già da me state svolte in altri contesti. Ma qui vengono riepilogate, riformulate e riproposte in modo sistematico, cosa che probabilmente il lettore dotato di spirito critico apprezzerà.
Per questa ragione Lenin è particolarmente odiato. Lenin è uno che ci ha provato, e per questo la sua memoria deve essere diffamata ed esecrata. Le considerazioni che qui svolgo sono già da me state svolte in altri contesti. Ma qui vengono riepilogate, riformulate e riproposte in modo sistematico, cosa che probabilmente il lettore dotato di spirito critico apprezzerà.
La “leggenda nera” di Lenin, simbolo di un secolo diabolico da cui congedarsi
Gli storici definiscono “leggenda nera” (leyenda negra) la teoria per cui gli spagnoli avrebbero di fatto genocidato i popoli amerindi dell’America Latina. Non sono uno specialista di quella storia, e quanto dico deve essere preso con beneficio d’inventario. A me sembra che gli spagnoli volevano prima di tutto sottomettere e schiavizzare, mentre gli anglosassoni intendevano invece sgomberare il terreno e quindi direttamente genocidare. Se sbaglio mi si corregga. D’altra parte, poiché una immagine vale spesso più di mille pagine di teoria, basta guardare le facce di George Bush e di Hugo Chavez per sapere quale dei due modelli coloniali ha saputo integrare di più i dominati. Ancora adesso chi guarda i telefilm americani vedrà negri in tutte le salse, negri poliziotti, negri pompieri, persino negri dirigenti, ma non vedrà mai coppie miste di neri e di bianchi. Ci si chieda il perché, e si comincerà a capire qualcosa di più del mondo contemporaneo a direzione ideocratica imperiale americana.
Oggi Lenin è il protagonista principale, insieme a Hitler e Stalin (i poveri Mao e Mussolini sono obbligati a sedere in seconda fila!), della “leggenda nera” del novecento, secolo diabolico in cui l’utopia della virtù si è rovesciata in terrore (Hegel, Merleau-Ponty, Furet, eccetera), ed in cui il comunismo non è stato che l’applicazione politica del livellamento fordista al mondo sociale. Poiché noi italiani ci distinguiamo sempre per essere feroci e buffoni (ma spesso non sappiamo che gli altri se ne accorgono, e se non lo dicono è solo per educazione!), questa teoria è italiana come la pizza e l’alta moda, ed ha trovato in Marco Revelli il suo esponente più determinato. Il “pentimento” degli ex Lotta Continua, questo sgradevole fenomeno sociologico, morale ed editoriale, ha evidentemente una durata di molti decenni.
In realtà il novecento non può essere seriamente staccato dai secoli precedenti. Il seicento ha cominciato a proporre un modello di razionalità scientifica (Galileo) e filosofica (Spinoza), certo pieno di difetti per il suo inevitabile meccanicismo, ma comunque pieno di promesse. Il settecento ha esteso ed applicato questo modello di razionalità cercando di mediarlo con la conoscenza storica. L’ottocento, bene o male, ha prodotto per la prima volta una teoria emancipativa universalistica, piena di comprensibili difetti economicistici, storicistici ed utopistici, ma nello stesso tempo suscettibile di essere migliorata in un secondo tempo (Marx). Il novecento, infine, non è stato solo il secolo di Auschwitz e di Hiroshima, ma è anche stato il secolo “in cui ci si è provato” a cambiare il mondo (Lenin). Questo primo tentativo di cambiamento è storicamente fallito, ma non per questo deve essere anche filosoficamente delegittimato.
Ancora una volta ripeto la vera ragione dell’odio verso Lenin. Lenin deve essere maledetto perché ci ha provato. Certo, le “anime belle” che non si sporcano mai le mani non commettono mai errori o crimini. In proposito, la gente che si crede “colta” non capisce assolutamente la natura delle proposte apocalittiche alla Marco Revelli, e crede che si tratti solo di un “congedo” filosoficamente elaborato dal solo novecento fordista-comunista. Errore. Ciò da cui si vuole prendere congedo non è il solo novecento fordista-comunista, ma è l’intero progetto conoscitivo-emancipativo della modernità europea. Il “pentimento” della povera banda di Lotta Continua (Adriano Sofri, Marco Revelli, eccetera) è solo il punto di infiammazione patologica di una epidemia molto più diffusa, l’irrazionale congedo dall’intero progetto moderno, un progetto ad un tempo conoscitivo ed emancipativo.
Questo progetto è un progetto pratico, e la pratica è un’attività trasformatrice. Chi trasforma, dunque, deve a volte distruggere per ricostruire. Chi parla solo di frittata non deve rompere nessun uovo, ma chi vuole veramente cucinare una frittata deve necessariamente rompere le uova. Non ci si inganni sull’attuale retorica della Non-Violenza. E’ evidente che in linea di principio la Non-Violenza è meglio della Violenza. Bella scoperta! Fare l’amore è meglio di soffrire di un tumore! Una carezza è meglio di un colpo di scure! Convincere tutti è meglio di incarcerare anche solo una minoranza riottosa! E così potremmo continuare in una sagra delle banalità.
La retorica della Non-Violenza, oggi, al di là di essere un evidente segnale di integrazione simbolica nel sistema politico delle oligarchie finanziarie attuali, rappresenta il trionfo della “teoria parlata” sulla “pratica giocata”. Finalmente si può parlare di frittata senza dover anche spiacevolmente rompere le uova. Chi non capisce che siamo di fronte ad una crisi epocale della razionalità moderna, e ritiene che si tratti soltanto di un tragicomico momento congiunturale che caratterizza i codici di riconoscimento di gruppi relativamente esigui (anche se sovrarappresentati mediaticamente) di politici, giornalisti ed accademici, non coglie adeguatamente i tratti del tempo presente. Niente di nuovo. Tipico della “sinistra” è non cogliere mai il senso tragico della storia. Ci deve sempre essere un “lieto fine”, sempre una “proposta”, sempre una “soluzione”.
Ebbene, si ritorna sempre al punto di partenza, come nei giochi di dadi in cui si viene puniti perché si è capitati nella casella sbagliata. Lenin ci ha provato, dunque deve essere demonizzato. Marx ha solo scritto, ma non ci ha veramente provato. Fra i due demoni, dunque, Lenin è il peggiore.
 2. Un legittimo dubbio iperbolico: esiste veramente il “leninismo”?
2. Un legittimo dubbio iperbolico: esiste veramente il “leninismo”?
E’ filologicamente accertato senza ombra di dubbio che ad un certo punto Marx scrisse che era sicuro di una cosa sola, e cioè di non essere “marxista”. Non ricordo esattamente il contesto preciso di questa affermazione, ma il significato è chiaro: tutti gli “ismi” che vengono confezionati in mio nome, e che certamente ancor più verranno confezionati dopo la mia morte, devono essere presi con beneficio di inventario.
La stessa cosa, ovviamente, può essere detta per Lenin. Personalmente, non credo neppure che esista una cosa univocamente definita chiamata “leninismo”. Mi è noto, ovviamente, e lo farò io stesso nei prossimi paragrafi, che si possono facilmente elencare alcune soluzioni date da Lenin a problemi teorici e politici (lo sviluppo del capitalismo in Russia contro i populisti, la teoria del partito politico contro i menscevichi, la teoria delle alleanze di classe contro gli operaisti “luxemburghiani”, la teoria dell’imperialismo contro le definizioni date da Kautsky e da Bucharin, la teoria del materialismo dialettico contro l’empiriocriticismo, eccetera). Per chi conosce la storia del marxismo, elencare queste soluzioni ed organizzarle in un sistema teorico coerente è un gioco da ragazzi. Ma, appunto, è sempre pericoloso trasporre i giochi da ragazzi nella teoria politica e filosofica. In proposito mi limiterò a segnalare solo due punti principali.
In primo luogo, è storicamente e filologicamente accertato che il termine di “leninismo” è ovviamente posteriore al 1924, anno della morte di Lenin. Che cosa fosse il “leninismo” è oggetto di lotta politica fra Stalin, Trotzky e Zinoviev, ognuno dei quali definisce il leninismo a suo modo. La definizione storicamente accettata dal movimento comunista è ovviamente quella di Stalin, che la espone in due opere successive, pubblicate rispettivamente nel 1924 e nel 1926. Si apre una divaricazione fra il cosiddetto “marxismo-leninismo”, sintesi accettata prima da Stalin e poi da Mao, ed il cosiddetto “marxismo rivoluzionario”, termine che indica in realtà il trotzkismo. In quanto Padre Fondatore del Comunismo, Lenin diventa la posta in gioco di una guerra ideologica senza quartiere.
In secondo luogo, Lenin fu il massimo esponente di una concezione teorica in cui le scelte politiche e ideologiche erano fatte caso per caso sulla base di una valutazione legata all’analisi concreta di una situazione concreta. Il contrario, quindi, degli “ismi” (di tutti gli ismi), che invece deducono la scelta politica o teorica da un corpus dottrinale precedente. Chi ha conoscenze della storia delle filosofia occidentale sa bene che questo approccio individualizzante alla scelta pratica non risale affatto ad un fantomatico “materialismo”, ma risale ad Aristotele ed alla sua teoria della cosiddetta “deliberazione” (boulesis). Mentre nelle scelte teoriche si ha a che fare con canoni formali e regolari (quelle che oggi chiamiamo le “leggi scientifiche”), nelle scienze pratiche, e quella di Lenin è chiaramente una scienza pratica della rivoluzione, si ha a che fare con una saggezza (sophrosyne), che a differenza della semplice sapienza (sophia), consiste nella capa\cità di fare la scelta giusta caso per caso (boulesis).
La scelta rivoluzionaria dell’ottobre 1917, ad esempio, è un caso tipico di “arte dell’insurrezione” che non può essere dedotta da nessun “ismo”, tanto meno poi dall’“ismo” per cui la rivoluzione non si può fare più nei cosiddetti punti alti dello sviluppo capitalistico (corruzione delle aristocrazie operaie a causa della distribuzione dei sovraprofitti imperialistici, ed altre “sciocchezze” del genere, mi si scusi per l’espressione volutamente un pò volgare), e bisogna allora farla negli anelli deboli della catena mondiale imperialistica. Questo argomento è una tipica “razionalizzazione a posteriori” di un fatto portato a termine in una congiuntura irripetibile che non si può dedurre da nessun “ismo” (e tantomeno dal cosiddetto “leninismo”), e che è invece compiuto da una “deliberazione” (boulesis) attuata non in base alla sapienza marxista ma in base alla saggezza politica pratica.
Per queste ragioni, e per altre che qui trascuro per brevità, ho forti dubbi che si possa parlare sensatamente di “leninismo”. Parlerò invece di Lenin, o più esattamente del modo concreto e specifico in cui Lenin ha affrontato questioni teoriche e pratiche.
3. Il rapporto controverso di Lenin con Marx. Ortodossia teorica, revisionismo pratico e falsa coscienza necessaria
Per affrontare in modo serio la questione cruciale del rapporto di Lenin con Marx bisogna prima di tutto staccarsi dalla leggenda edificante che vi è stata costruita sopra dalla dottrina ideologica del defunto comunismo storico novecentesco (1917-1991). Secondo questa leggenda edificante vi sarebbero stati prima i grandi marxisti rivoluzionari Marx e Engels, poi sarebbero venuti i perfidi revisionisti Bernstein e Kautsky, ed infine sarebbe venuto Lenin a restaurare la vera dottrina rivoluzionaria perduta, ricollegando il comunismo pratico del 1917 con il comunismo teorico del Manifesto di Marx ed Engels del 1848.
Lenin fu ovviamente un “revisionista” molto più grande di Bernstein e di Kautsky, perché “revisionò”, e cioè rinnovò radicalmente, l’originaria teoria di Marx e anche la sua sistemazione fatta da Engels. Tuttavia, questa revisione radicale fatta da Lenin venne presentata nella forma di una “restaurazione” dello spirito rivoluzionario originario nel frattempo perduto e corrotto. Ci si può allora porre la domanda legittima se questo rinnovamento radicale presentato nella forma di una restaurazione sia stato dovuto ad un “vincolo ideologico esterno”, perché il movimento marxista del tempo non avrebbe sopportato una revisione radicale presentata per quello che era, e cioè appunto una revisione radicale, oppure sia stato dovuto ad una forma di “falsa coscienza necessaria” di Lenin, per cui quest’ultimo era soggettivamente convinto di stare soltanto restaurando, mentre stava in realtà proponendo una revisione radicale delle tesi di Marx (e anche di Engels).
Che dire? In prima approssimazione, entrambe le cose. Kautsky aveva potuto far passare la sua egemonia teorica nella forma della fedeltà “ortodossa” a Marx e Engels. Come documenta bene Erich Matthyas, il kautskismo era diventato l’ideologia di legittimazione della pratica opportunistica della socialdemocrazia tedesca, così come più tardi, in un altro contesto storico e politico, lo divenne il togliattismo nel PCI di Palmiro Togliatti e di Enrico Berlinguer. Lenin era allora di fatto costretto a giocare con le regole imposte da altri. Nello stesso modo, più di mezzo secolo dopo, dovettero giocare con le regole della “sacralizzazione” di Marx, da tener fuori religiosamente da ogni “peccato” di revisione, sia Althusser (contrapposizione fra un giovane Marx, cattivo, ed un Marx maturo buono) sia Lukács (contrapposizione fra un Marx tutto perfetto e senza errori ed un Engels ammirabile e stimabile, ma con errori deterministici e meccanicistici).
In seconda approssimazione, però, credo che Lenin si ingannasse (in buona fede, e nello stesso tempo in falsa coscienza) sul tipo di riforma cui stava sottoponendo la teoria originale di Marx. In altri termini, stava costruendo una teoria originale, completamente nuova, mentre era convinto di stare solo restaurando la vera teoria marxiana originaria.
La mia è un’affermazione impegnativa. Per poterla argomentare con un minimo di serietà devo ora passare a discutere alcuni aspetti del pensiero di Lenin. Iniziamo, ovviamente, dalla sua teoria del partito politico.
 4. La teoria di Lenin del partito politico rivoluzionario
4. La teoria di Lenin del partito politico rivoluzionario
La teoria leniniana del partito politico rivoluzionario è considerata secondo l’opinione comune come il “pezzo” più importante, duraturo e pregiato del contributo di Lenin al marxismo. Non è questa la mia personale opinione. La mia opinione è che il “pezzo” più importante, duraturo e pregiato del contributo di Lenin sia la sua teoria dell’imperialismo, secondo una particolare accezione (il salto dall’eurocentrismo implicito marxiano alla vera mondializzazione) che cercherò di chiarire nel prossimo paragrafo. Ma per ora cerchiamo di ragionare in modo critico e spregiudicato sulla teoria leniniana del partito, la cui prima formulazione è nel Che fare? (1903), ma che poi si presenta in tutte le opere posteriori di Lenin.
In primo luogo, bisogna dire ben chiaro e forte che la teoria leninista del partito è completamente assente in Marx e Engels. Il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels del 1848 è la dichiarazioni di intenti storica non di uno specifico partito politico (ed infatti Marx e Engels nel biennio 1848-49 si rifiutarono di aderire ai gruppi politici comunisti dell’epoca, ma aderirono invece a forze democratiche non comuniste), ma di una sorta di “partito-tendenza”, la cui natura era quella di coprire un’intera fase storica, e non quella di agire come gruppo organizzato in un panorama politico dato. E’ vero che nel corso delle battaglie politiche della cosiddetta Prima Internazionale (in realtà AIL, associazione internazionale dei lavoratori) Marx e Engels ebbero spesso accenti “partitistici” contro le posizioni anarchiche di Bakunin, ma questo non basta per farli diventare “partitisti” nel senso di Lenin.
E vi è per questo una ragione precisa. Se è vero, infatti, che per Marx il comunismo non è il prodotto politico dell’agire di un partito, ma è il prodotto storico della formazione di un lavoratore collettivo cooperativo associato, dal direttore di fabbrica all’ultimo manovale, alleato con le potenze scientifiche evocate dalla produzione industriale moderna e da Marx connotate con la parola inglese general intellect, ne consegue allora che in questo modello dialettico di costituzione di una nuova società non c’è veramente lo spazio teorico per il ruolo decisivo di un partito politico. Certo, Marx e Engels erano favorevoli alla cosiddetta “capacità politica della classe operaia”, in polemica con gli anarchici ed i sindacalisti puri, ma anche questa loro cristallina posizione non ha nulla a che fare con la teoria della decisività di un partito politico.
Risulta chiaro da un’onesta lettura filologica di Marx che per lui la “dittatura del proletariato” era concepita come una dittatura democratica delle maggioranze auto-organizzate in autogoverno politico ed in autogestione economica, e non come la dittatura di un partito inteso come il “rappresentante degli interessi storici” del proletariato. Che poi queste maggioranze auto-organizzate si rivelarono impossibili, impraticabili e del tutto “utopistiche” nella storia reale successiva alla morte di Marx (1883) è vero, ma di per sé questo non cambia di un grammo la posizione di Marx. In una parola, la teoria leniniana del Che Fare? è una revisione di Marx molto più grande di quelle coeve di Bernstein e di Kautsky.
In secondo luogo (e questo secondo punto è immensamente più importante del primo) la teoria leniniana del partito presenta a mio avviso una vera e propria contraddizione strutturale insanabile fra la sua concezione del marxismo come “scienza”, da un lato, e la concezione del “centralismo democratico”, dall’altro. Se il marxismo è concepito come scienza, infatti, non è possibile sostenere contemporaneamente che le decisioni “scientifiche” possano essere prese a maggioranza, in quanto per definizione la “scienza”, se è veramente tale, non procede a colpi di maggioranza e di sottomissioni disciplinate della minoranza. La cosa è intuitiva, ma è di tale importanza da meritare una analisi più dettagliata e approfondita.
Com’è noto, nel Che Fare? Lenin sostiene che la classe operaia, salariata e proletaria di per sé, nelle sue lotte economiche immediate, può soltanto maturare una visione limitata e sindacalistica, mentre per poter impadronirsi teoricamente dell’insieme dei rapporti sociali capitalistici di produzione deve poter giungere alla “scienza marxista”, che solo il partito nella sua collegialità può veramente acquisire. Di tutto questo, si noti bene, in Marx non c’è neppure l’ombra. Nello stesso tempo, a mio avviso, Lenin aveva completamente ragione, perché solo un cieco e/o un illuso può veramente pensare che da uno sciopero economico si possa risalire alla totalità dei rapporti di produzione. Non intendo certamente contestare Lenin su questo punto. I cosiddetti “spontaneisti” possono restare tali solo perché non ragionano e non intendono ragionare e prendere atto dell’evidenza. Da tempo mi sono reso conto che la confusione non è un argomento razionale.
L’insieme dei rapporti sociali di produzione in una formazione economico-sociale è dunque un oggetto scientifico che deve essere analizzato con un metodo scientifico. Trattandosi di una scienza sociale (più esattamente di una ontologia dell’essere sociale), è a mio avviso del tutto erroneo e fuorviante cercare di applicarvi l’oggetto ed il metodo di una scienza naturale. Su questo punto, il mio disaccordo con Lenin è radicale, così come con tutti coloro che ritengono che le scienze naturali e quelle sociali abbiano un oggetto omogeneo ed un metodo simile. Ma in questa sede questo problema, pur così cruciale, è un semplice dettaglio secondario. Eguale o diverso che sia il metodo ed il suo oggetto, in ogni caso la “scienza” non può essere decisa con il metodo delle maggioranze e delle minoranze.
Il principio del “centralismo democratico”, invece, sostiene di fatto proprio questo. Questo principio sostiene che ci si può dividere fra maggioranze e minoranze nel momento preliminare della presa delle decisioni, ma poi, una volte prese le decisioni, la minoranza dissenziente deve impegnarsi a portare avanti la “linea” presa dalla maggioranza.
Tutto questo è compatibile con una bocciofila o con una industria automobilistica, ma non con un’organizzazione che pretende di basarsi sulla “scienza” marxista. Una bocciofila può dividersi se investire in nuovi campi da bocce o in corsi di bocce per adolescenti. Un’industria automobilistica può dividersi sulle scelte di nuovi modelli. In entrambi i casi (ed in migliaia di casi analoghi che il lettore potrà facilmente fare) non si ha a che fare con una pretesa di “scienza”. Ma il partito di Lenin pretende di essere il titolare della “scienza” marxista. Ora, il solo titolare di qualsiasi scienza (naturale, sociale o filosofica che dir si voglia) è il libero convincimento del singolo scienziato. Tutta la teoria della filosofia occidentale, da Socrate in poi, si basa sul principio per cui la “verità”, ammesso che esista, non si decide a maggioranza, ma è oggetto di attività razionale autonoma. Se si fosse dovuto decidere a colpi di maggioranza e minoranza, oggi lo sappiamo bene, Copernico, Galileo e Darwin avrebbero certamente perso.
Questa contraddizione fra preteso carattere scientifico del marxismo, da un lato, e principio del centralismo democratico (in cui le minoranze si sottomettono alle maggioranze anche se non “convinte”) dall’altro, è assolutamente insanabile. O si abbandona la pretesa che il marxismo sia una “scienza”, e allora si possono accettare procedure consensuali di maggioranza e minoranza, oppure si tiene fermo al fatto che è in qualche modo una “scienza”, ed allora non esiste centralismo democratico che tenga. Per questa ragione, la concezione leniniana del partito contiene in sé in potenza il principio della scissione interminabile. Non si tratta di una patologia, ma di una fisiologia inevitabile. Se il marxismo è “scienza”, infatti, ci mancherebbe altro che io mi debba sottomettere ad una casuale maggioranza. Solo la mia coscienza è sovrana indivisibile sulla mia “scienza”. Tutti i fuochi di sbarramento ideologici approntati in un secolo per nascondere questo fatto incontrovertibile, e cioè che la “scienza”, se è scienza, non si sottopone al principio di maggioranza (centralismo democratico), perché se no non è scienza, ma un’altra cosa, rivelano il loro carattere strumentale e miserabile (individualismo piccolo-borghese, anarchismo piccolo-borghese, liberalismo piccolo-borghese, e via farneticando). E’ evidente che qui la “piccola borghesia” diventa una categoria demonologico-inquisitoria per esorcizzare il diritto indiviso del soggetto autonomo moderno ad affrontare la filosofia filosoficamente e la scienza scientificamente.
In terzo luogo, per finire, il partito di Lenin è uno stato in miniatura, una sorta di “socialdemocrazia emergenziale militarizzata”, e più esattamente uno “stato ideologico in potenza”. Non uso queste espressioni per criticarlo o per liquidarlo sommariamente. Al contrario. Uso queste espressioni per segnalare come già Marx, in polemica con Lassalle, aveva escluso che lo stato, sia pure riformato o “operaio”, potesse essere lo strumento politico per il superamento del capitalismo. Lo stato, infatti, incorpora nella sua struttura differenziali di sapere e di potere che non possono essere neutralizzati “ideologicamente”. Su questo punto è permesso, naturalmente, criticare Marx per “utopismo”, riaffermare la validità dello stato democratizzato e soprattutto considerare insostenibile la teoria dell’estinzione dello stato. Chi scrive, tra l’altro, pensa proprio questo. Ma allora bisogna avere il coraggio di essere apertamente “revisionisti”, perché Karl Marx, il fondatore della ditta, non pensava questo, ma pensava il contrario.
Concludiamo sul punto del partito. Accusare Lenin non ha senso, perché egli non ha fatto altro che prendere atto radicalmente di un dato già allora visibile (ed oggi incontrovertibile), cioè l’assoluta incapacità della classe operaia, salariata e proletaria, presa nella sua immediatezza sociologica, di operare “spontaneamente” un superamento del capitalismo. Ci voleva comunque un rimedio, e Lenin propose un nuovo tipo di partito rivoluzionario “integrale”, una sorta di ordine religioso anti-capitalistico. Non ha funzionato. Mai fidarsi di preti e sacerdoti. Tradiranno il messia prima che il gallo abbia cantato tre volte. Non c’è bisogno per questo di rivolgersi a Roberto Michels o a Leone Trotzky. Ma di fronte alla miseria intellettuale dei cosiddetti “spontaneisti” (ultima versione, la più grottesca di tutte, il lottacontinuismo italiano degli anni 1969-1976), Lenin fa la figura di un gigante.
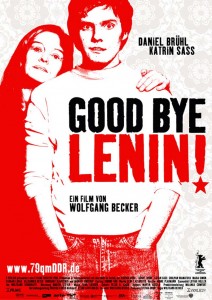 5. La teoria di Lenin dell’imperialismo
5. La teoria di Lenin dell’imperialismo
Marx scrisse la maggior parte delle sue opere nel ventennio 1850-1870. Si tratta proprio del ventennio del libero scambio, quello che Hobsbawn chiama “l’età della borghesia”. A quel tempo regnava il colonialismo imperialistico inglese, che Marx combatteva (scritti sull’Irlanda e sull’India, eccetera), ma non c’era ancora il vero e proprio imperialismo. Il vero e proprio imperialismo nel senso di Lenin è un prodotto storico posteriore al 1873, e cioè alla cosiddetta Grande Depressione.
Marx non ha dunque nessuna colpa per non averne parlato, mentre Kautsky ha le sue colpe per aver ingenuamente immaginato una sorta di consorzio capitalistico imperiale unificato, il famoso Super-imperialismo, in cui i capitalisti si mettono pacificamente d’accordo per spartirsi consensualmente il mondo. Kautsky dimenticava così che per il suo maestro Marx non ci poteva essere un tale capitalismo unificato “concordatario”, in quanto il capitalismo esiste solo nella forma obbligata della concorrenza strategica fra numerosi capitali antagonistici. Errare è umano. Ma perseverare è diabolico, e tutto l’orrendo “operaismo” si è ideologicamente costruito su questo errore kautskyano, fino all’ultima concezione di impero di Toni Negri. L’operaismo è, teoricamente parlando, una sorta di “anarchismo kautskyano”. Il capitale si unifica in un gigantesco super-imperialismo imperiale, e contro di esso si muovono, senza alcun bisogno di partito leninista “autoritario”, le masse luxemburghiane ridefinite in termini di moltitudini spinte da flussi desideranti di tipo teurgico (sic!).
Anche l’idiozia può attingere vette sublimi.
Da quasi novanta anni si discute sulle famose cinque caratteristiche che secondo Lenin caratterizzano l’imperialismo, e che qui non ripeto per ragioni di spazio. Su questo punto rimando ai recenti scritti sull’imperialismo di Gianfranco La Grassa, che fanno un bilancio storico critico di queste cinque caratteristiche, e di fatto ne ritengono attuale solo una, mentre le altre quattro in qualche modo sono state “smentite” o “assorbite” nell’ultimo secolo. Qui però intendo svolgere il mio ragionamento in una diversa prospettiva.
Prima di tutto, una constatazione storica elementare. La differenza fra la socialdemocrazia ed il comunismo dopo il 1917 non è stata quella della vittoria o della sconfitta dei loro progetti (per ora, in questo 2004, entrambi i progetti sono stati sconfitti totalmente, con la sola parziale eccezione della benemerita socialdemocrazia radicale e coerente di Chavez in Venezuela). La differenza fra socialdemocratici e comunisti si è situata nel diverso atteggiamento verso il colonialismo imperialistico e verso la legittimità o meno degli interventi militari imperialistici, fino naturalmente alla Jugoslavia 1999 e l’Irak 2003. I socialdemocratici sono stati generalmente favorevoli (con benemerite eccezioni) ed i comunisti generalmente contrari (con spregevoli eccezioni). Tutto questo si deve anche a Lenin, e possiamo anche dire, soprattutto a Lenin.
In questo modo Lenin superava di fatto in modo positivo l’eurocentrismo che inevitabilmente l’originario programma di Marx portava in se (esemplarità del modello capitalistico inglese, eccetera). Lenin non è stato il “secondo” a mondializzare il marxismo, ma è stato in un certo senso il “primo”. Credo che questo impegnativo e prestigioso riconoscimento gli debba essere dato, anche se ovviamente ogni innovatore radicale si porta sempre con se anche residui della vecchia concezione (meccanicismo, teoria dei cinque stadi, sostanziale disconoscimento del modo di produzione asiatico, eccetera). Ma si tratta di dettagli. Il punto essenziale sta nel superamento di fatto dell’eurocentrismo, espresso bene dal titolo della sua opera “L’Europa arretrata e l’Asia avanzata”.
La teoria leniniana dell’imperialismo, che personalmente approvo integralmente (con fisiologiche obiezioni di dettaglio frutto del bilancio dell’ultimo secolo di storia, i cui ultimi ottanta anni non sono stati vissuti da Lenin), fa di Lenin il più grande marxista del novecento. Per questo egli è tanto odiato, nell’epoca dell’impazzimento interventistico dell’impero militare americano e dell’impunità vergognosa di cui gode il sionismo.
6. La teoria di Lenin delle alleanze di classe
“Gli a solo della classe operaia si trasformano in cerimonie funebri”. Cito a memoria, ma il lettore può darmi fiducia: la citazione è una citazione originale di Marx. E’ strano che su questa citazione, che non è che un bilancio storico meditato di tutti i tentativi ottocenteschi della classe operaia e proletaria di sollevarsi da sola senza alleanze sociali, si sia fatto un grande silenzio per quasi un secolo.
Se infatti questa posizione di Marx fosse stata adeguatamente conosciuta, sarebbero cadute tutte le infondate mitologie minoritarie, bordighiste, trotzkiste, operaiste, eccetera, sul fatto che sia il “marxismo” che il “leninismo” consistono, in ultima istanza, nel punto di vista operaio, e cioè nell’operaismo puro.
Naturalmente, con questo non intendo dire che non esista un legittimo punto di vista operaio puro. Esso esiste, e riguarda cose come il lavoro notturno, la nocività in fabbrica, i ritmi insostenibili di lavoro, l’insufficienza dei salari, eccetera. Qui esiste ovviamente il punto di vista operaio “puro”, di cui chi scrive è sostenitore inveterato da almeno quarant’anni, senza ripensamenti, senza se e senza ma.
Ma che il punto di vista operaio puro sia l’essenza del marxismo lo hanno potuto dire solo tipi alla Adriano Sofri prima di passare al servizio dei bombardatori americani del Kosovo del 1999 e dei massacri sionisti fatti da Israele, definito da Sofri come “un paese che bisogna amare”.
Dal momento che Lenin non era solo un allievo di Marx, ma era anche una persona intelligente e dotata di buon senso realistico, la sua concezione della politica si basava sulla teoria e sulla pratica delle alleanze di classe, e nella fattispecie di tre classi, gli operai, i contadini e gli intellettuali (categoria grande-magazzino in cui finiva con il mettere tutti quelli che non facevano lavori manuali, e dunque dagli impiegati agli artisti).
Possiamo discutere se e fino a che punto questa tripartizione fosse adeguata oppure no. Ma la grandezza di questa concezione risalta ancora di più se la paragoniamo a vertici della confusione a lui contemporanea, come la teoria operaistica delle “masse” di Rosa Luxemburg, per cui ci sono solo i proletari, ed i contadini, gli intellettuali, la questione nazionale, eccetera, non esistono neppure. Non dimentichiamoci mai che l’attenzione di Lenin alle alleanze di classe lo faceva situare addirittura a “destra” dei puri dell’epoca, sognatori di una impossibile “rivoluzione proletaria pura”.
Eppure, anche nella teoria di Lenin delle alleanze di classe c’era una contraddizione insanabile, che alla fine poi è esplosa. In poche parole, Lenin chiedeva alle altre classi “progressiste” di allearsi alla classe operaia e di accettarne l’egemonia, ma solo in via provvisoria e temporanea, in attesa della loro progressiva sparizione, in vista della finale “proletarizzazione universale”. Ora, c’è qualcosa di contraddittorio nel chiedere alla gente il suicidio o meglio l’eutanasia. Da un lato, si propone l’alleanza di classe. Dall’altro, si tiene fermo che alla fine del processo ci sarà una sorta di inevitabile globalizzazione proletaria universale in una società nuova senza classi caratterizzata dalla omogeneizzazione proletaria.
Siamo talmente abituati da una scolastica marxista secolare ad identificare la possibilità di una società senza classi con l’avvenuta proletarizzazione unica ed omogenea universale che non ci viene generalmente in mente che ci potrebbe essere in futuro in via di principio una società senza classi senza che questa si identifichi con una società proletarizzata omogenea globalizzata. O meglio, non viene in mente a quasi nessuno, ma rivendico il fatto che a me questa idea è almeno venuta in mente. La “proletarizzazione forzata” implica necessariamente resistenza, e questo non soltanto da parte degli egoisti borghesi sfruttatori del sangue proletario.
Possiamo allora chiederci in questo paragrafo il perché del fatto che Lenin da un lato sostenesse le alleanze di classe e dall’altro annunciasse la proletarizzazione universale incitando all’eutanasia di tutti i gruppi sociali non ancora “proletarizzati”. In proposito il discorso sarebbe lungo, perché dovrebbe investire il nucleo delle filosofie messianiche della fine della storia (da Stalin a Fukuyama), e la teoria della proletarizzazione finale della storia mondiale è una variante economicistica delle teorie della fine della storia. Per il momento mi limito a due soli ordini di osservazioni.
La teoria della proletarizzazione universale come coronamento sociologico della fine comunista della storia, dato e non concesso che risalga a Marx e/o a Lenin (su questo non posso discutere qui per ragioni di spazio), è un mito monistico-sociologico, o se vogliamo un mito ispirato al monismo sociologico, che rivela una mancata assimilazione della dialettica, ed in particolare della dialettica di Hegel. Proletariato e Borghesia, infatti, sono concetti e realtà unicamente relazionali e complementari, e non esistono e non possono esistere indipendentemente ed isolatamente. L’unità storica e dialettica consiste esclusivamente nella loro relazione. Il mito della cosiddetta “proletarizzazione” è solo l’altra faccia del mito opposto del cosiddetto “imborghesimento”. In particolare oggi, almeno in molti paesi cosiddetti “avanzati” i processi complementari di proletarizzazione e di imborghesimento hanno portato ad una sorta di capitalismo post-borghese e post-proletario, e continuano a non capirlo solo quelli che pensano che Berlusconi con la bandana da pirata sulla testa sia ancora un “borghese” e che Bertinotti rappresenti i “proletari”.
Questa è la prima osservazione, ma la seconda è ancora più importante. Da dove tira fuori Lenin l’idea che una proletarizzazione universale sia una cosa buona da favorire in tutti i modi? Bisogna distinguere, a mio avviso, due aspetti del problema, uno in negativo e uno in positivo. In negativo, lo sorregge la profonda convinzione della cosiddetta “decadenza” della borghesia come classe sociale, decadenza che a sua volta comprenderebbe due aspetti, un aspetto di “stagnazione” e putrefazione delle forze produttive e un aspetto di “imbarbarimento” nei rapporti sociali, politici e militari. Da questo punto di vista “negativo” Verdun e il Carso, Hiroshima e Auschwitz, Palestina e Bagdad sono lì per ricordarci che la diagnosi di imbarbarimento era semmai fin troppo ottimistica, laddove la diagnosi di “stagnazione” era invece errata, dal momento che il capitalismo si è rivelato capacissimo di sviluppare continue innovazioni di processo e soprattutto di prodotto fino a sbaragliare sul campo lo stagnante ed inefficiente socialismo reale (e la Cina è solo l’eccezione che conferma la regola, avendo prima fatto una sorta di accumulazione industriale primitiva in forma “socialista” ed avendo poi intrapreso in un secondo momento un decollo capitalistico in piena regola).
In positivo, la teoria della proletarizzazione positiva di Lenin si basa su di un presupposto umano oggi dimenticato, il lavoratore consapevole erede della filosofia tedesca, detto in lingua tedesca bewusste Arbeiter. Questa figura, a mio avviso, è una pura costruzione mitologica, ed in realtà non è mai veramente esistita, al di là di alcune migliaia di lavoratori manuali di fabbrica che nel tempo libero leggevano Kant, Darwin, Marx ed addirittura Hegel, oltre ovviamente ai grandi romanzieri classici (Balzac, Tolstoj, eccetera). Questo mito fu creato da Engels attraverso la figura del proletariato erede della filosofia classica tedesca. Questo proletario era del tutto inesistente, mentre invece erano esistenti, anche se non molto numerosi, proletari (soprattutto tedeschi e scandinavi) che si informavano invece su sintesi positivistiche elementari.
Questo bewusste Arbeiter socialista è una figura ultraminoritaria, ma esistente nel trentennio 1880-1910, mentre il suo successore, il bewusste Arbeiter comunista, è anch’esso una figura ultraminoritaria, ma esistente, del trentennio 1920-1950. Io stesso, ad esempio, ne ho incontrati alcuni esemplari a Torino, a Parigi, ed a Atene, le sole città in cui abbia vissuto. Soprattutto a Torino, questo bewusste Arbeiter univa genuino interesse per la cultura con penosi riduzionismi collaterali della cultura a ideologia ed a forma di lotta per la cosiddetta gramsciana “egemonia”, che nessuna persona lucidamente consapevole può veramente proporre come modello culturale ed umano realmente riproponibile oggi.
In questo modo, Lenin poteva realmente conciliare l’accettazione piena e sincera delle alleanze di classe con il monismo sociologico proletario, o più esattamente con il mito della omogeneizzazione proletaria finale dell’intera popolazione mondiale. In proposito, lascerò parlare al mio posto il benemerito presidente venezuelano Hugo Chavez (cfr. “Il Manifesto”, 18-8-04): “Non credo ai dogmi della rivoluzione marxista. Non penso affatto che stiamo vivendo in un’epoca di rivoluzioni proletarie. Tutto questo deve essere ripensato. La realtà ce lo dice ogni giorno”.
Ci vuole un creolo mezzo indio e mezzo nero per dire certe ovvietà che tutti i marxisti sofisticati non hanno ancora capito. Lenin, se fosse vivo, lo avrebbe certamente approvato, ed avrebbe parlato di “Europa arretrata e di Venezuela avanzato”. Ma i leninisti senza Lenin sono come gli aristotelici senza Aristotele ai tempi di Galileo. Da tempo ho smesso di sperare che comincino a capire qualcosa.
 7. La teoria di Lenin sul materialismo dialettico, sulla filosofia e sull’ideologia
7. La teoria di Lenin sul materialismo dialettico, sulla filosofia e sull’ideologia
Ho cercato fino ad ora nei tre precedenti paragrafi di dare una lettura “aporetica” di Lenin, di mostrare cioè le contraddizioni interne di teorie che i nemici e gli amici presentano in generale come semplicemente “tetiche”, cioè organicamente compiute, per i nemici completamente cattive e per gli amici completamente buone. A mio avviso, però, i “veri amici” sono quelli che segnalano i difetti, ed in questo caso non ho certamente paura a definirmi un vero amico di Lenin.
A proposito della teoria dell’imperialismo, ho detto che essa è buonissima e pienamente valida anche oggi (sia pure con ovvie correzioni di bilancio storico), ma bisogna pure aggiungere che essa non risolve e non può risolvere il problema cruciale dell’individuazione delle forze sociali e storiche strategiche capaci di un superamento della produzione capitalistica, che invece la teoria marxiana originaria in qualche modo segnalava, sia pure in base ad ipotesi scientifiche errate (classe operaia e proletaria, lavoratore collettivo cooperativo associato, general intellect, eccetera).
A proposito della teoria del partito politico, ho affermato che a mio avviso la sua contraddizione principale sta in ciò, che da un lato afferma che il partito è titolare della scienza sociale marxista della rivoluzione, e dall’altro lato questa presunta “scienza” è affidata al gioco delle maggioranze e delle minoranze di un comitato centrale, il cosiddetto “centralismo democratico”, laddove ovviamente la scienza, se è veramente scienza, non procede mediante il gioco casuale delle maggioranze e delle minoranze che vi si sottomettono.
Io posso proceduralmente sottomettermi come cittadino italiano a Berlusconi, Prodi o D’Alema, per me tutti “alieni” e nemici, ma questa sottomissione è integralmente “procedurale” e dovuta alla mia accettazione del principio democratico delle maggioranze elettorali, ma non posso certo “sottomettermi” alle opinioni di Armando Cossutta o Fausto Bertinotti, se le ritengo scientificamente errate e talvolta (come nel caso di Bertinotti) addirittura demenziali. A proposito infine della teoria delle alleanze di classe, ho sostenuto che esse sono molto sagge, e che lo stesso Marx lo aveva a suo tempo capito quando aveva sostenuto che “gli a solo della classe operaia si trasformano in cerimonie funebri” (verità autoevidente per tutti, al di là delle scolastiche settarie di vario tipo), ma che questo riconoscimento poteva entrare in rotta di collisione con quel monismo sociologico largamente mitico definito “proletarizzazione” universale e globale.
Toccando ora il quarto tema della cultura e della filosofia mi soffermo in quello che è di fatto il mio “specialismo”, il che non significa ovviamente che io abbia ragione, ma semplicemente che si tratta di questioni cui ho dedicato maggiore studio ed attenzione da almeno quaranta anni. Anche qui siamo di fronte a mio avviso ad una contraddizione. Da un lato, apprezzo molto il fatto che Lenin, mostrando qui un saldo orientamento culturale, abbia sempre esplicitamente rifiutato le teorie dicotomiche sulla contrapposizione di una scienza borghese ad una scienza proletaria, di un’arte borghese e di un’arte proletaria, ed infine di una letteratura borghese e di una letteratura proletaria.
Con sicura e sostanzialmente corretta intuizione, pur non avendo mai studiato sistematicamente il problema, Lenin capisce l’essenziale, e cioè che la scienza, l’arte e la letteratura non sono né borghesi né proletarie, ma semplicemente sono o non sono. O meglio, è ovvio che la loro genesi psicologica e sociale ed anche il loro consumo sono fortemente influenzati dal classismo antagonistico, ma la loro validità scientifica, artistica e letteraria produce alla fine un risultato universale. E’ vero che Lenin non ha incertezze solo sulla scienza, mentre per quel che riguarda l’arte e la letteratura a volte ha oscillazioni. Ma in generale egli tiene fermo su questa corretta impostazione.
Dall’altro lato, e non posso nasconderlo, e desidero anzi “denunciarlo” con particolare veemenza, il giusto atteggiamento “universalistico” che Lenin riconosce alla letteratura, all’arte e alla scienza non viene sciaguratamente riconosciuto alla filosofia, che Lenin considera una forma di “ideologia”, ed a cui non è pertanto disposto a riconoscere uno statuto “universalistico” concesso giustamente alla letteratura, all’arte ed alla scienza. Su questo punto cruciale il mio dissenso con Lenin è massimo ed incomponibile. Non si tratta però solo di una questione di “gusto personale”. Penso invece che, l’identificazione di fatto dello spazio filosofico con lo spazio ideologico, con la successiva nefasta definizione del “materialismo dialettico” come filosofia identitaria del partito comunista, eccetera, sia stata una delle malattie inguaribili ed incurabili del movimento comunista novecentesco nel frattempo defunto (1917-1991).
Occorre partire dall’inizio, anche a costo di ripetermi e di essere noioso, perché qui si gioca una partita culturale decisiva. Lo statuto filosofico originario di Karl Marx era una variante dell’idealismo classico tedesco, e più esattamente una libera reinterpretazione di temi tratti da Fichte e da Hegel, mentre invece non era per nulla un “materialismo” nel senso di Feuerbach o un “criticismo” nel senso di Kant. Il fatto che fosse indubbiamente una filosofia dell’attività, della prassi e della trasformazione non ne fa affatto un “materialismo”, perchè tipico del materialismo è semmai il sopportare la situazione presente (Epicuro, Leopardi, eccetera).
E’ semmai tipico dell’idealismo, che cerca di conciliare il “reale” con “l’ideale”, spingere ad una filosofia della prassi. L’unico sensato significato di “materialismo” che può essere dato alla filosofia di Marx è quello di ateismo o se vogliamo di critica della “alienazione religiosa”, ma il dire che al mondo c’è solo la “materia” come oggetto di conoscenza è una tesi scientifica, non filosofica, e meno si confondono i due piani e meglio è.
L’appartenenza integrale di Marx (o almeno del Marx filosofo) alla tradizione idealistica (Platone, Proclo, Fichte, Hegel, con tutte le differenze che qui devo ovviamente trascurare) è stato riconosciuto in Italia da almeno due notevoli filosofi, Giovanni Gentile e mezzo secolo dopo Lucio Colletti. Il fatto che uno sia diventato fascista e l’altro berlusconiano non cambia di un grammo l’esattezza della diagnosi, e non cambia nulla il fatto che ciò che per Colletti è un male e la prova provata della non-scientificità di Marx, per me invece è un bene e la prova provata della discendenza di Marx dalla grande tradizione filosofica greca (Platone e Aristotele) e tedesca (Fichte e Hegel). Inoltre chi scrive non è né fascista né berlusconiano ma si considera un comunista critico indipendente, e sarebbe lieto che questo gli fosse anche riconosciuto.
Ritorniamo a noi. Marx dopo un certo periodo non si occupa più di filosofia.
Sarebbero bastate due settimane nel 1875 per scrivere cento pagine per chiarire le sue posizioni, ma non lo ha fatto. Non è certamente perché “gli mancava il tempo” (ho dovuto leggere anche questa idiozia), ma probabilmente perché non lo riteneva più necessario. Egli credeva, ritengo, che la sua filosofia fosse stata ormai interamente “metabolizzata” nella sua ipotesi scientifica anticapitalistica, e non ci fosse allora bisogno di “raddoppiare” l’oggetto già studiato e scandagliato. Ma questa posizione, per cui la filosofia è inutile perché ormai “assorbita” nella scienza, in filosofia ha un nome, e si chiama positivismo. L’ultimo Marx, al di là di fatue frasi sul “rovesciare Hegel dalla testa sui piedi”, frasi che non significano assolutamente niente e vengono ripetute da tutti i dilettanti del mondo che le ripetono solo perché non sanno neppure cosa significano, è un filosofo positivista implicito.
Proseguiamo. L’amico Engels, in questo sostanzialmente fedele a Marx, decise di occuparsi sistematicamente di filosofia con un volenteroso dilettantismo degno di miglior causa. Egli fu il “traghettatore” dal positivismo implicito al positivismo esplicito. Come tutti i dilettanti, iniziò con una confusione fra ontologia e gnoseologia, cioè fra teoria dell’essere e teoria della conoscenza, e definì allora il materialismo e l’idealismo (che sono posizioni ontologiche) in termini gnoseologici, cioè nei termini della teoria gnoseologica del “riflesso” (Wiederspiegelung), per cui il materialista era colui che “rifletteva”, o meglio rispecchiava, la realtà, mentre l’idealista era quello che la costruiva arbitrariamente. Il generoso dilettante metteva così le basi di una confusione destinata a durare almeno un secolo.
E siamo allora giunti finalmente al nostro Lenin. Lenin era convinto che il “materialista” è colui che rispecchia scientificamente la realtà che esiste indipendentemente da noi, e che per esempio non può rispecchiare Dio, perché Dio non esiste, e solo la “materia” (metafora per indicare sia la natura che la società) esiste. Egli si imbestialiva in modo indecente, ed assai poco filosofico, nei confronti degli oppositori (in proposito, tristi ed esilaranti sono soprattutto le memorie di Valentinov, un intelligente empiriocriticista con cui Lenin ruppe una vecchia amicizia per esclusive ragioni “filosofiche”), per un fatto non difficile da segnalare. La parola chiave è “realtà indipendente dalla nostra coscienza”. Lenin pensava infatti che la tesi fondamentale del marxismo fosse appunto che il passaggio dal capitalismo al socialismo fosse qualcosa di indipendente dalla nostra coscienza, e cioè necessaria, oggettiva, scientifica, simile alle leggi delle scienze naturali (naturmässig). Questa è la ragione per cui si imbestialiva tanto con gli “idealisti”, e vedeva il diavolo “idealista” in tutto, perfino nella fisica di Mach e Poincarè.
Si tratta di una sciocchezza. Anche le aquile a volte volano più in basso delle galline. Lenin era un’aquila, ma in filosofia volava più in basso delle galline. Il passaggio dal capitalismo al socialismo, ammesso che in futuro possa compiersi (e lasciando comunque in sospeso per ragioni di spazio il problema di che cosa significhi), non è assolutamente qualcosa di oggettivo, necessario, scientifico e conforme alle leggi naturali (naturmässig). Il carattere omogeneo delle leggi della natura e delle leggi sociali è una stupidaggine condivisa dai positivisti e dall’idealista meno intelligente, e cioè da Schelling, e poi dai suoi seguaci utopico-messianici-confusionari, come il pur simpatico Ernst Bloch. Il pensiero non può allora “rispecchiare” questo processo, dal momento che questo processo senza intervento umano cosciente semplicemente non esiste.
Parlare di cose che non esistono ha un nome, e si chiama religione. La concezione del passaggio necessario e “rispecchiato” dal pensiero dal capitalismo al socialismo è una religione pura. Più esattamente, è una pseudo-scienza ed una quasi-religione. Le religioni normali sono tuttavia molto migliori (e prego il lettore di interpretare letteralmente), perché sono immensamente più comprensive della totalità dell’esperienza umana, prendono in considerazione anche l’amore coniugale, la malattia, la morte, eccetera. Qui Lenin prende un abbaglio grande come la catena degli Urali.
Questo errore se ne porta dietro anche un altro, quello imperdonabile della riduzione della filosofia a ideologia. Ora, è chiaro che qualcosa chiamato “ideologia” esiste, e non solo esiste ma non è neppure eliminabile, a meno di prospettarsi una impossibile “trasparenza” della capacità umana di conoscenza. Solo Dio, infatti, se esistesse, sarebbe del tutto non-ideologico (cosa per altro già genialmente anticipata da Aristotele con la sua teoria dell’Atto Puro e del Pensiero del Pensiero). Nello stesso tempo, però, la riduzione della filosofia ad ideologia, più esattamente dello spazio filosofico pubblico a spazio ideologico di partito, ha conseguenze fatali e catastrofiche, ed è questa la ragione della mia insistenza. Se infatti pensassi che la cosa non è poi così decisiva, non insisterei tanto.
Indipendentemente dalla questione della riduzione indebita della filosofia ad ideologia, la “filosofia” di Lenin era comunque cattiva. Il discorso sarebbe lungo e specialistico, ma possiamo compendiarlo qui in tre punti.
Primo, di tutte le filosofie possibili entro le quali può essere pensata l’espressività del materialismo storico di Marx, il cosiddetto “materialismo dialettico” è indubbiamente la peggiore. Ed è la peggiore per una ragione semplicissima. Chi prende la via della omogeneizzazione categoriale, logica ed ontologica, delle cosiddette “leggi” della natura e della società, commette un errore fatale, perché fa pensare che la società si muova o si possa muovere secondo “regolarità” estratte dal modello delle scienze della natura moderne. Ora, tutto questo è falso, e non è falso solo in parte, ma è completamente falso. Se proprio si vuole una filosofia adatta al materialismo storico, si elabori allora una ontologia dell’essere sociale integrata da una critica delle ideologie, e soprattutto delle ideologie grandi-narrative.
Secondo, il prendersela tanto con Dio e con la religione, come fa Lenin, è del tutto fuori tempo e fuori misura. Sono le società precapitalistiche che utilizzano la religione come ideologia di legittimazione delle disuguaglianze sociali (che si pretende volute da Dio), mentre nel capitalismo tutto questo tende a sparire. Se osserviamo come stanno le cose oggi, vediamo che persino un’organizzazione corrotta, integrata e burocratizzata come la chiesa cattolica romana è mille volte meglio del laicismo alla Pannella-Bonino, in quanto non è disposta a mercificare integralmente la “vita” ed a ridurre la stessa “natura” ad opinione sociale elettiva (come fa il femminismo anglosassone detto di “genere”). In base alla filosofia di Lenin tutto questo è letteralmente inconcepibile, e questo significa che la filosofia di Lenin non è più una bussola adeguata per muoversi nella post-modernità.
Terzo, ed ultimo, indubbiamente Lenin ha di buono che cerca di capire Hegel ed ammette addirittura che un idealismo intelligente è meglio di un materialismo stupido. Ma la sua interpretazione di Hegel è del tutto fuori bersaglio. Per Lenin Hegel è una sorta di seguace di Eraclito, per cui tutto si muove, tutto scorre e niente rimane uguale perché si rovescia nel suo contrario. Ma Hegel non è Eraclito. Per Hegel la filosofia si occupa di ciò che è, ed è eternamente. In questo Essere, evidentemente, esiste una dialettica fra Permanenza e Mutamento. Ma chi pensa che la dialettica sia solo mutamento fa diventare Hegel un nichilista, e questo è sbagliato.
Il discorso sarebbe lungo, e non è questa la sede per condurlo analiticamente. Ciò che conta è ribadire il punto essenziale: la filosofia è come la scienza, l’arte e la letteratura. Indubbiamente, la sua genesi è storicamente determinata anche da una struttura classista della società, ma non può essere ridotta ad essa, come invece è il caso della ideologia. Il corollario storico e giuridico di questa comprensione comporta, ovviamente, la sua integrale libertà di pratica, di dialogo e di esecuzione.
 8. Brevi considerazioni conclusive su Lenin
8. Brevi considerazioni conclusive su Lenin
A Lenin bisogna perdonare molto, perché senza il suo decisivo intervento la rivoluzione del 1917 ce la saremmo sognata. Chi pensa che il 1917 sia stato una sorta di miracoloso prodotto delle “masse in movimento” ha completamente perduto il senno. Le masse in movimento hanno come caratteristica quella di produrre una situazione caotica destinata ad implodere ed a crollare su se stessa senza l’intervento di una volontà politica strutturata in azione politica coerente. E qui da un lato abbiamo i confusionari, e dall’altro Lenin, espressione della vittoria eterna della forma sul caos.
La teoria e la pratica di Lenin contenevano allora “in potenza” Stalin e lo stalinismo? Ecco un problema non solo insolubile, ma addirittura insensato, in quanto la storia non è un gomitolo che si srotola partendo da un rocchetto, ma un insieme di atti specifici sempre nuovi, e sempre indeducibili dal cosiddetto anello iniziale della catena. Dopo la morte di Lenin (1924), e fino all’implosione dissolutiva dell’Urss (1991), si ebbero migliaia di atti politici “originali” che non potevano assolutamente dedursi meccanicamente da un “ismo originario” (magari diabolico, vedi Furet, Revelli, ed altri confusionari alla moda), chiamato “leninismo”.
Essendo il presunto “leninismo” non un corpo dottrinario formalizzato, ma un insieme di scelte ispirate alla saggezza pratica del caso per caso (boulesis), dopo il 1924 avremmo potuto avere sia una pianificazione imperativa sia una pianificazione orientativa, sia un’economia statalizzata sia un’economia mista (NEP prolungata), eccetera. Nessuna delle scelte fatte poi da Stalin, Trotzky, Bucharin, Krusciov, Breznev, Gorbaciov, eccetera, possono essere dedotte da un corpus chiamato “leninismo”. Ognuno è responsabile integralmente solo per le scelte che fa, o che contribuisce a fare avallandole. Si può sempre decidere di bruciare gli eretici sul rogo, ma Gesù di Nazareth non c’entra. Ed è particolarmente vergognoso che gente che ha alle spalle un passato di roghi di eretici, dica poi che nel “leninismo” era già compreso in potenza lo stalinismo. Vergogna, e nello stesso tempo, ridicolo.
A proposito dell’attività storica e politica di Stalin (1924-1953) si può avere un’ampia gamma di posizioni, che vanno dall’incondizionatamente negativo all’incondizionatamente positivo. La mia personale posizione che ho maturato in proposito è fortemente negativa, anche se non è motivata dallo stesso apparato argomentativo dei sostenitori della teoria del “totalitarimo”, che in genere retrodatano a Lenin il loro orrore metafisico per Stalin. Certo, conosco abbastanza bene tutte le motivazioni (in massima parte di tipo storicistico, emergenzialistico e congiunturalistico) dei difensori di Stalin, e sarebbe strano se non le conoscessi, dal momento che sono ormai decenni che mi capita di essere invischiato in discussioni su Stalin, in cui per forza di cose il repertorio è ormai fisso, ed i dialoganti potrebbero limitarsi ad alzare cartelli numerati che segnalano argomentazioni collaudate (ad esempio 18, accerchiamento imperialistico, e 23, degenerazione burocratica, eccetera). La sola opinione stabile e sicura che ho maturato in proposito è che la cosa migliore è parlare pro e contro Stalin iuxta propria principia, cioè limitandosi all’arco storico dell’attività di Stalin (1924-1953), e lasciar invece completamente perdere non solo Marx, ma anche Lenin.
Questo vale ovviamente per grandi come Stalin, ed anche per piccoli come Togliatti. Esiste, naturalmente, un bilancio storico, ed esiste anche un bilancio teorico. Gli storicisti incalliti hanno difficoltà enormi a contare fino a due, e generalmente pensano che un bilancio storico sia anche automaticamente di per se un bilancio teorico. Non è così. Ad esempio, la questione teorica della natura sociale dell’Unione Sovietica e della Cina (a meno che la si consideri risolta dalle dichiarazioni ufficiali emesse dai loro governi, metodo che Marx non avrebbe certamente approvato) non è la stessa cosa della questione storica dell’adeguata comprensione dei grandi eventi via via succedutisi.
Lenin era capace sia di fare bilanci teorici sia di fare bilanci storici. Un’arte, oggi, largamente perduta. Un’arte che può però forse essere in parte recuperata, se eviteremo facili bilanci tetici o anti-tetici (leninismo “in positivo” o critica del leninismo), e ci abitueremo per un intero periodo storico a bilanci “aporetici”, come quello che ho cercato di proporvi qui.
