Editoriale – Comunismo e Comunità n° 5
mag 5th, 2011 | Di Redazione | Categoria: Primo Piano, Teoria e criticaIl quinto numero di Comunismo e Comunità è in uscita in versione cartacea. Presentiamo qui, come anticipazione, l’editoriale, sicuri che tutti gli amici ed i compagni rinnovino i propri abbonamenti e ne procurino degli altri, visto che si tratta di una rivista totalmente indipendente ed autofinanziata.
La Redazione
—
UI
(urla) Sangue! Ricatti! Furti ed assassinii! Arbitrii! Sparatorie in piena strada! Uomini che si recano al lavoro, cittadini pacifici che vanno in municipio per testimoniare, uccisi in pieno giorno! E cosa fa, io domando, il Consiglio comunale? Nulla! Perché codesti valentuomini debbono progettare certi affari poco puliti, e denigrar la gente onorata, invece di adottare delle misure!Bertold Brecht, “La resistibile ascesa di Arturo Ui”.
Per l’ennesima volta in un paio di lustri l’Italia si è impegnata in una guerra di aggressione imperialistica.
Dopo l’attacco alla Serbia in cui la nostra aviazione fu seconda solo a quella statunitense per missioni di attacco, dopo il corpo di invasione spedito in Afghanistan, dopo quello inviato attorno ai pozzi di petrolio a noi m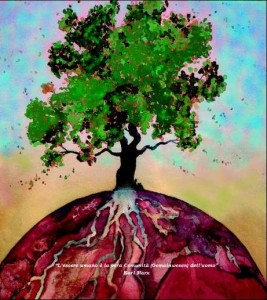 agnanimamente assegnati in Iraq dal nostro “maggior alleato” ora stiamo attaccando la Libia appena un anno dopo aver siglato con questo Paese un patto di amicizia e di reciproca non-aggressione. Giuda non avrebbe potuto fare di meglio.
agnanimamente assegnati in Iraq dal nostro “maggior alleato” ora stiamo attaccando la Libia appena un anno dopo aver siglato con questo Paese un patto di amicizia e di reciproca non-aggressione. Giuda non avrebbe potuto fare di meglio.
Non staremo a ripetere i perché della nostra avversione agli innumerevoli “bombardamenti umanitari”. I membri del nostro laboratorio politico li hanno discussi nel sito e su altre testate online, come Megachip.
Ciò su cui occorre invece riflettere è la tripla peculiarità di questa nuova impresa imperialistica.
1. La prima, di carattere internazionale, è che all’interno del fronte degli aggressori si sono sperimentati litigi rilevanti. La constatazione empirica è che nell’attacco alla Libia siano schierati in prima linea le vecchie potenze coloniali in Africa: Francia, Gran Bretagna e Italia, che insieme possono vantare il massacro di milioni di Africani (con record francese: quattro milioni di morti) mentre nella sola Libia il nostro Paese può rivendicare con orgoglio lo sterminio di un paio di generazioni (con orgoglio: infatti chiedere scusa di ciò, coi fatti e non con le parole, è stato considerato un atto di “incivile cortigianeria” da un ampio schieramento trasversale di forze politiche, dall’estrema destra all’estrema sinistra – con pochissime eccezioni – passando per quello che una volta si sarebbe definito “arco costituzionale”, e su ciò ritorneremo).
La Germania nelle avventure coloniali in Africa c’era e non c’era e ad ogni modo durò poco (ciononostante si fece notare dai patiti del massacro coloniale per il quasi totale sterminio degli Herero nell’attuale Namibia). E anche adesso la Germania c’è e non c’è, sottoposta a pressioni di vario tipo per dare il proprio contributo all’aggressione, pressioni tra le quali spiccano quelle politiche dei Verdi tedeschi e di alcuni settori della Socialdemocrazia. E anche su questo ritorneremo.
Gli USA in Africa invece non c’erano e anche oggi dopo che “il presidente Obama ha lanciato sulla Libia più missili di quelli lanciati da tutti i precedenti premi Nobel per la Pace messi assieme” (come è stato detto ad una radio statunitense) si sono messi a tirare le fila della vicenda da una posizione più decentrata lasciando il gioco sporco ai Paesi contractor europei e agli ascari mediorientali capeggiati dall’Arabia Saudita. Già il Segretario alla Difesa, Robert Gates, aveva infatti avvertito che avrebbe considerato demenziale un terzo maggior coinvolgimento diretto degli USA dopo l’Afghanistan-Pakistan e l’Iraq. Su questa prudenza comunque non ci giureremmo, perché ci sono variabili troppo importanti da controllare.
Ritorniamo ai litigi interni alla coalizione dei volenterosi. La Francia in questa vicenda ha giocato il ruolo di prima donna isterica. Il lato isterico gliel’hanno fornito due dame di compagnia dell’interventismo umanitario, cioè Bernard-Henri Lévy, un filosofo famoso non si sa per che cosa, ma comunque obbligatoriamente famoso per i media occidentali, e Bernard Kouchner che fu leader del Maggio Francese assieme a Daniel Cohn-Bendit, anch’egli ex contestatore libertario e da tempo embedded come i suoi amici nelle truppe della NATO e di Tsahal.
Ma se il lato isterico è questo, quello ragionato rivela almeno due cose: la volontà di neutralizzare la preferenza della Libia per l’italiana ENI nello sfruttamento degli idrocarburi fossili e quella più generale di ritornare nel gioco geopolitico africano e mediorientale da dove, assieme alla Gran Bretagna, fu brutalmente cacciata a calci nel sedere dagli USA durante la crisi di Suez del 1956.
Tutta la disquisizione NATO sì-NATO no nascondeva la volontà della Francia di avere mano libera e non essere irreggimentata dal patron dell’Alleanza Atlantica, cioè gli USA (una pretesa ragionevole dato che la Francia se la sta cavando bene nell’ingerenza omicida negli affari interni della Costa d’Avorio). In questa battaglia, così come in tutta la vicenda, è presumibile che sia la Francia sia la Gran Bretagna abbiano stretto speciali accordi con Israele per poter forzare i tempi e la mano di Obama. Formalmente la Francia ha perso la contesa e così oggi siamo di fronte ad una NATO che apparentemente stenta a capire come muoversi.
Di sicuro c’è un gran lavorio di servizi segreti, di mercenari, di forniture di armi. Occorre vedere dove si sta puntando.
Per andare avanti le potenze imperialistiche sembrano quindi costrette a ripercorrere vecchie strade. Se c’è un segnale di grossa novità in questa crisi è, paradossalmente, proprio la riesumazione del passato.
La Storia si ripete (e purtroppo non in farsa), una ripetizione che è idealmente iniziata con il ritorno di Sarajevo al centro di un conflitto europeo quasi novant’anni dopo l’attentato all’Arciduca d’Austria.
E 100 anni dopo anche noi ritorniamo all’avventura della “quarta sponda” festeggiata come evento umanitario dal Capo dello Stato e delle Forze Armate, come una sorta di appendice ai festeggiamenti dei 150 anni di unità d’Italia. Per ironia della sorte sul ponte di comando della Difesa abbiamo persino un ministro fascista. Il cerchio sembra chiudersi.
Nell’ambito del litigioso schieramento imperialistico, al lato opposto della superinterventista Francia troviamo la non-interventista Germania. Meno interessata direttamente al business del petrolio libico, la Germania prosegue nella sua Ostpolitik verso la Russia testimoniata dal gasdotto Northstream e dalla sua voglia di compartecipare anche al Southstream capeggiato da ENI. Forse l’entrata dei Tedeschi potrebbe sbloccare una situazione che sembra incartata. E qui siamo arrivati alle debolezze italiane.
2. Prima di passare a questo triste scenario, occorre però capire la seconda peculiarità, che sembra anch’essa paradossale: Barack Obama è il presidente nero che guida il tentativo imperialistico americano di ridefinire le aree di influenza proprio nel Continente Nero. Saranno contente quelle persone di sinistra che vedevano nel colore della pelle del candidato democratico una garanzia di riscatto. E riscatto infatti era: quello dell’imperialismo USA in Africa. D’altra parte anche quella illusione era una forma di razzismo, e soprattutto una suprema forma di incomprensione dei criteri con cui vengono scelti i candidati alla Casa Bianca. Ci voleva un’inchiesta giornalistica americana per scoprire che Obama viene da una famiglia con pedigree CIA (con tanto di madre che invece di essere una “figlia dei fiori”, come ama imbrogliare Mr President, era con tutta probabilità invischiata nel golpe di Suharto in Indonesia in cui furono sterminati i comunisti assieme alle loro famiglie. Si stima un milione di assassinati).
Soffermarsi esclusivamente sul petrolio in sé come fonte di arricchimento delle lobbies petrolifere rischia però di essere una forma di puro economicismo “di breve periodo”, con il quale si vuole dipingere non una coalizione di stati nazione capeggiati da uno stato nazione superpotenza che va all’attacco di altri stati nazione sovrani, per interessi in parte in condominio ma in parte contrastanti, bensì una coalizione di armigeri al servizio del potere economico, cioè al servizio del Capitalismo Uno, globalizzato e neoliberista, in crisi (talché si dice infatti che saremmo in presenza di una crisi del capitalismo tout court).
La realtà è che mettere le mani su Afghanistan e collegato Pakistan, su Libia e Iraq e nel futuro programmato su Libano, Siria, Somalia, Yemen e Iran ha per prima cosa un senso nella gestione del dominio, finalizzato al contenimento dei propri competitor internazionali, da parte del potere territoriale della potenza capitalistica che è stata egemone dalla fine della II Guerra Mondiale ad ora: gli Stati Uniti d’America.
Per far ciò è indispensabile un’alleanza del potere territoriale col potere del denaro, cioè col capitalismo nella sua forma industriale e soprattutto finanziaria e innanzitutto coi suoi settori dominanti.
Viceversa la crisi inasprisce i conflitti intercapitalistici e acuisce la necessità di emergere come capitale dominante, cioè capitale con un differenziale di potere rispetto al resto dei capitalisti. E tale lotta è condotta sul fronte economico con l’ausilio del potere del territorio, cioè del potere politico dei singoli stati nazionali capitalistici.
La progressiva perdita da parte degli Stati Uniti della capacità di coordinamento e di controllo dei meccanismi globali di accumulazione e dei conflitti che in essi si sviluppano, ha condotto, a partire dalla fine degli anni 1960, ad una crisi sistemica, che gli Stati Uniti hanno infine cercato di gestire con ciò che è stata chiamata “globalizzazione”, un logo suggestivo che nascondeva una varietà di strumenti economici, politici e militari per rallentare la perdita di egemonia degli Stati Uniti.
Questa crisi il cui aspetto finanziario ed economico è indissolubilmente intrecciato a quello politico-militare, è proprio ciò che ha condotto al Washington Consensus cioè, come è stato detto dall’economista statunitense Michael Hudson, alla “più grande rapina mondiale di ricchezza esistente mai avvenuta” e alla serie di guerre iniziate con Bush Senior, continuate sotto i mandati di Clinton, inasprite con Bush Jr e moltiplicate con Obama. Una serie che non si placa, che non può esaurirsi.
L’Africa è il nuovo obiettivo statunitense. Gli USA sanno che il controllo del Medio Oriente deve essere complementato da quello dell’Africa Orientale e del Maghreb. Conoscono a menadito le ricchezze africane e la loro localizzazione. Sanno che in Africa la Russia e soprattutto la Cina stanno erodendo terreno all’Occidente. Da qui le accuse, spesso ripetute dalla sinistra anticapitalistica “pura”, di “imperialismo cinese” anche se la Cina da tempo immemorabile praticamente non conduce guerre al di fuori dei propri confini.
Non è esagerato affermare che la crisi ci ha fatto entrare nella Terza Guerra Mondiale e le politiche non solo estere ma anche interne dei vari Paesi possono essere comprese solo se si parte da questo dato di fatto.
Ma è proprio rispetto alle caratteristiche di questa crisi sistemica che la sinistra europea, e specialmente italiana, ha perso la bussola quasi totalmente. E qui arriviamo all’ultima peculiarità.
3. L’attacco imperialistico alla Libia trova in Italia sostenitori una volta impensabili. Maître à penser come Rossana Rossanda, icone della cultura di sinistra come Dario Fo, grandi vecchi del pensiero anticapitalistico come Pietro Ingrao, sono le punte di un iceberg di sinistra immerso nel senso comune dell’avversario all’attacco.
Quasi volessero rendere involontario omaggio all’ironia della sinistra statunitense, che invece riempie le piazze in decine di manifestazioni contro la guerra libica, “Say no to war … unless a Democrat is President”, il fior fiore della sinistra italiana, così come gli ex sessantottini europei sopra citati, folgorato sulla via di Tripoli dal Nobel per la Pace, Barack Obama, probabilmente la più rapida beatificazione della storia umana, ha potuto dare libero sfogo alla sua incapacità di analisi marxista della realtà mettendola al servizio degli invasori.
Un’incapacità che come già succedeva con Kautsky ai tempi di Lenin deriva da un rimando ortodosso ad alcune formule marxiste che non confrontate con la realtà subiscono una mutazione genetica che dà luogo all’opportunismo e, nella fattispecie, all’interventismo.
Anche in questo caso assistiamo ad una riedizione della Storia: la votazione dei crediti di guerra per l’Impero Tedesco nell’agosto del 1914 da parte dei socialdemocratici tedeschi, i futuri assassini di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che questi crediti di guerra avevano tenacemente avversato.
Potremmo anche dire che la sinistra cento anni dopo si riscopre sinistra senza più nessuna ambiguità. Nel processo sono spariti i comunisti, senza nemmeno bisogno dei Corpi Franchi.
Senza più riscontri con la realtà, che era una realtà di rapporti tra organizzazioni anticapitalistiche nel mondo, l’internazionalismo proletario si è mutato in un vuoto ideale, poi in un vuoto pourparler e infine questo vuoto è stato riempito dai “diritti umani universali”, potentissimi transponder per i bombardieri dell’interventismo umanitario, ultima e micidiale metamorfosi opportunistica dell’ortodossia.
A sostegno di queste mutazioni di coscienza si è sviluppato tutto un apparato teorico che altro non è se non lo specchio “di sinistra” dell’ideologia capitalistica della globalizzazione. Laddove abbiamo la “mano invisibile del mercato”, qui è teorizzata la “fine degli stati-nazione”. Laddove abbiamo la “competizione globale”, qui troviamo il capitalismo uno e trino, la logica capitalistica “pura” deprivata di ogni forma di potere che non sia la biopolitica, pervasiva, invasiva, invisibile e letale come i radionuclidi sfuggiti da una centrale nucleare, perfetto contraltare alla “finanziarizzazione assoluta”, indicata come la prova provata della “fine della legge del valore” e del dominio del “capitalismo immateriale”.
Crediamo che l’esercizio di guardarsi il proprio ombelico probabilmente darebbe risultati più ragionevoli. Sicuramente meno deleteri, perché qui siamo di fronte all’invito a consegnare la sovranità di qualsiasi entità nazionale ai boia imperiali, perché in quanto capitalistici gli interessi nazionali non possono, non diciamo essere difesi, ma nemmeno essere menzionati.
Ma, sosteniamo noi, consegnare a poteri sovranazionali o non nazionali i propri interessi capitalistici non vuol dire essersene disfatti, ma vuol dire vederseli ripiombare addosso in una forma ancor meno contrastabile. La vicenda Marchionne-FIAT proprio questo dovrebbe avere almeno insegnato. E invece no.
Le nostre coscienze sono state così levigate come lo “spazio liscio” che il Capitale Uno avrebbe preparato per la rivolta delle moltitudini desideranti. E’ quindi logico che si trasalga con sorpresa ad ogni cannoneggiare imperiale. E questo trasalimento porta a due sole scelte: quella maggioritaria, ovvero negare che il cannoneggiamento abbia mire imperialistiche, perché l’imperialismo non esiste e se esiste è in secondo piano rispetto agli effetti benefici delle sue ogive (quest’ultimo è un ragionamento particolarmente caro alle grandi signore della sinistra sedicente comunista italiana, Rossana Rossanda e Lidia Menapace); e quella minoritaria, cioè prendere comunque posizione contro la guerra, perché la guerra soffoca le rivolte, perché serve a rapinare le risorse a favore del capitalismo, o perché la guerra è brutta e porta sofferenze. Una posizione più accettabile dove però si riconosce che qualcosa non funziona, ma non che cosa. Una posizione dove “imperialismo” diventa solo un altro termine per “espropriazione colonialistica a beneficio del Capitale Uno”. Una posizione che gira intorno al bersaglio senza mai centrarlo, perché ormai il bersaglio non si vede più, è sparito dai radar accecati.
Si passa con sorprendente disinvoltura dai “dividendi di pace” di un mondo ormai globalizzato alle “conquiste neocoloniali” di un mondo ancora da conquistare. Si passa dalla competizione internazionale alla sicurezza nazionale, dalla “fine della Storia” allo “scontro di civiltà” come se fossero la stessa cosa. Eppure il punto cardanico era stato spiattellato più di dieci anni fa dal noto columnist del New York Times, Thomas Friedman:
Perché la globalizzazione funzioni, l’America non deve aver paura di agire come la terribile superpotenza che essa è … La mano invisibile del mercato non funzionerà mai senza il pugno invisibile … e il pugno invisibile che mantiene sicuro il mondo per le tecnologie della Silicon Valley si chiama Esercito, Aviazione Militare, Marina Militare e Corpo dei Marines degli Stati Uniti.
Per riprendere le parole di Gianni Vattimo, “il concetto di sovranità è ancora più importante, ora che il mondo è globalizzato”. E lo è perché questo mondo ha globalizzato innanzitutto i conflitti.
Non abbiamo il culto di identitarismi di nessun tipo. Non ci piace il nazionalismo. Sono aspetti transitori di formazioni sociali create col capitalismo. Siamo anche convinti che l’esclusione sia una prerogativa intima di questo rapporto sociale (è anche per questo che ci suona strano, un po’ ossimorico, il termine “capitalismo globale”). Sappiamo però che le dinamiche transnazionali e sovranazionali sono quelle più favorevoli al capitale, che ha una grande mobilità, per sua natura. Perciò riconosciamo nello stato nazione la cornice più favorevole alle lotte delle classi subalterne per potere per lo meno interferire nei processi di accumulazione e di trasformazione della società. Il trucco di chi disdegna questo terreno, addirittura lo reputa innominabile, è quello di allontanare le istanze nazionali in qualche dimensione dominata da un dio remoto dalla volontà imperscrutabile: i mercati, le leggi “pure” dell’accumulazione; insomma rimandare tutto ad uno “spazio liscio” senza più nessun punto di riferimento strutturale o culturale per aggregarsi, in cui al più ci si può immaginare nomadi e alla fin fine unici nel senso di Max Stirner, non individui in una comunità come annunciava Marx.
Come ha detto Domenico Losurdo, “Tutti ricordiamo che in Italia (e in Occidente) una certa sinistra radicale ha lanciato a suo tempo la parola d’ordine del «ritorno a Marx» (espungendo indirettamente Lenin e la sua analisi dell’imperialismo). Ormai è sempre più chiaro che il presunto «ritorno a Marx» è in realtà un approdo a (Leonida) Bissolati, il socialista «riformista» che un secolo fa prese posizione a favore della missione civilizzatrice dell’Italia in Libia!”.
Sono parole che facciamo nostre, una per una. Non si può ritornare indietro ad un Marx supposto puro. Bisogna andare oltre Lenin e alla sua scienza politica, senza disperdere un solo atomo dell’esperienza del movimento comunista ottocento-novecentesco, senza ergerne nemmeno una parte a totem da venerare e senza trasformarlo in una sequenza di assiomi o peggio ancora di stanche litanie.
Il compito degli anticapitalisti, dunque, è oggi spingere per uno sganciamento dall’impero egemone in crisi e fucina di guerre. E’ quello di puntare ad una nuova Bandung, come afferma Samir Amin, alla quale associare gradualmente il proprio Paese, ben sapendo che “sovranità nazionale” per un Paese subimperialista come il nostro ha un significato ben diverso e implica un programma politico molto differente da quelli per un Paese asiatico invaso dalle armate imperialistiche, o per un Paese sudamericano minacciato tutti i giorni.
Il successo della Lega, partito politico dai tratti nazional-corporativi ritagliati su una piccola patria artificialmente definita, dovrebbe metterci tutti in guardia a non lasciare il terreno delle contraddizioni che nascono dal disfacimento del vecchio ordine mondiale alla mercé della resistibile ascesa di un novello Arturo Ui.
4. La questione della sovranità nazionale (trattata nella rivista dalla “Proposta di Tesi” e dall’articolo “Sinistra e Nazione”), quasi sempre schivata dall’attuale sinistra, è, quindi, centrale anche in un Paese come l’Italia. Lo svuotamento di sovranità (dall’alto tramite i vincoli europei e internazionali; dal basso tramite i federalismi e i separatismi simbolici e materiali interni) è oggi la vera arma d’attacco contro le classi subalterne, dal momento che le priva di quello spazio politico minimo per la propria lotta, anche solo rivendicativa (del federalismo tratta, in particolare, l’articolo “Federalismo: una risposta capitalistica alla crisi”).
La perdita della sovranità monetaria e fiscale da parte degli Stati europei, sancita con i trattati europei e con la liberalizzazione totale dei movimenti di capitale (e la conseguente ricattabilità e debolezza degli Stati stessi) non è soltanto il frutto di scelte del Capitale in generale, ma è l’esito dei precisi rapporti di forza intercorrenti tra la potenza finora egemone, gli Stati Uniti e gli Stati europei (da un lato) e tra Stati europei più forti e influenti (Francia e Germania) e Stati europei politicamente più deboli (tra cui la stessa Italia). Non a caso da un lato vediamo gli USA fare libero uso espansivo della propria politica monetaria in barba al monetarismo scolastico, dall’altro vediamo Francia e Germania violare allegramente i vincoli europei e proteggere senza ostacoli la propria industria nazionale di punta (in barba alle scolastiche direttive antitrust europee).
L’Unione Europea si configura quindi come organismo tecnocratico, istituzionalmente antidemocratico, con la precisa funzione di regolare (dietro ad un’apparente neutralità tecnica) i rapporti di forza intercorrenti tra Stati europei e tra questi e la potenza egemone USA. Il cosiddetto automatismo dei rapporti economici non è, quindi, altro che una tremenda ideologia (così forte da essersi strutturata nella forma mentis di milioni di cittadini occidentali) a copertura della sostanza inevitabilmente politica degli scontri intercapitalistici. Alla luce di tutto questo, la questione nazionale assume un’importanza centrale in termini di riappropriazione di uno spazio politico sovrano entro cui riconoscere e poi rendere efficace la propria prassi politica e la propria lotta.
5. Alla questione nazionale, intesa come uno dei campi di contraddizione espressi dal capitalismo e dall’imperialismo, si lega indirettamente la riflessione problematica, più generale, sul soggetto rivoluzionario, che è trattata all’interno della rivista sia dall’articolo “La Scuola di Marx” che dalla “Proposta di Tesi”.
Abbiamo più volte espresso la necessita di superare sia l’impostazione economicistica marxiana del soggetto “classe” in quanto soggetto intrinsecamente intermodale, sia l’impostazione sociologistica del concetto di soggetto marginale (migranti, poveri, esclusi e via dicendo) sia infine l’impostazione iperbolica negriana deterritorializzata, con il soggetto mondiale delle moltitudini subalterne contro l’Impero Unico del Capitale.
In particolare, pensiamo che la Storia non abbia suffragato l’ipotesi secondo la quale la classe in quanto tale possiede potenzialità rivoluzionarie derivate dal suo ruolo oggettivo nei rapporti di produzione capitalistici, né tanto meno che il capitalismo porti nel corso del suo sviluppo all’acuirsi e infine al dissolversi (in un nuovo modo di produzione post-classista) della contraddizione univoca tra capitale (unificato) e lavoro (unificato).
Tale contraddizione naturalmente esiste ed è all’origine logica e storica della stessa esistenza del rapporto sociale capitalistico e della produzione di surplus sociale (ogni negazione di questo fatto conduce a false e fuorvianti spiegazioni del capitalismo e, in molti casi, a tentativi moralistici e volontaristici di fuoriuscita da esso). Tuttavia è errato, dal nostro punto di vista, credere che il capitalismo produca da sé l’esasperarsi ineluttabile di tale contraddizione e il suo, altrettanto ineluttabile, superamento. Al contrario nella sua dinamica contraddittoria il capitalismo sviluppa, distrugge (nella crisi) e poi ricrea quello sviluppo delle forze produttive che non conosce in esso un ineluttabile progressivo degradarsi (da cui l’idea della contraddizione tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione capitalistici – Marx così enuncia la famosa contraddizione -) anche se esso progressivamente sviluppa contraddizioni effettivamente crescenti. La ricreazione continua di capacità produttiva è un fatto non esclusivamente economico, ma politico e militare, poiché il capitalismo reale si presenta come unità contraddittoria (questa unità è molto contraddittoria, sempre pronta a disarticolarsi, per via delle diverse logiche seguite dalle due parti) delle sue leggi economiche e della sfera politico-territoriale e militare di ancoraggio, protezione e salvataggio. Se di per sé il capitalismo non produce la stagnazione definitiva delle forze produttive, la divisione in classi (intese nel senso di Marx come salariati e capitalisti) non è destinata a dissolversi ineluttabilmente grazie all’acuirsi della contraddizione di classe.
Pertanto non è dall’interno (nell’intimo) delle relazioni capitalistiche, ma dall’esterno (da una strategia cosciente prodotta nella sfera politica e culturale) che può provenire la forza motrice per il superamento del modo di produzione capitalistico. Lo aveva capito benissimo l’eterodosso Lenin con la sua straordinaria teoria del Partito (e la teoria dell’Imperialismo), anche se Lenin cercò di salvare l’impianto teorico (l’aggettivo “teorico” è importante, perché con Lenin si consuma il divorzio tra teoria e politica, così che con Lenin la “teoria” può diventare “ideologia”, dove questo termine indica una funzione politica e non un inganno come in Marx) ortodosso dell’ineluttabilità dell’acuirsi della contraddizione tra capitale e lavoro, della decadenza nello sviluppo delle forze produttive e, quindi, del superamento del modo di produzione capitalistico come necessario esito.
La logica conseguenza della presa d’atto del carattere oggettivamente interno alle dinamiche capitalistiche della classe salariata e della sua subordinazione materiale e culturale ad esse, è la necessità di riconoscere che la forza rivoluzionaria e intermodale può solo venire dall’esterno, non soltanto per accelerare una dinamica sospesa che è comunque inevitabile (come nel tentativo di sintesi di Lenin), ma proprio per generare politicamente i presupposti e le condizioni di una rivoluzione anticapitalista, socialista e comunista niente affatto scontata.
A questo punto riemerge, sebbene in altri termini, il problema, ineludibile, del soggetto rivoluzionario, o meglio del soggetto sociale potenzialmente coinvolgibile in una pratica intermodale. Dal momento che va rifiutato un approccio volontaristico puro (ovvero di adesione al comunismo sulla base esclusiva di sentimenti ed idee, che pure contano, ma non bastano da soli) è lecito interrogatarsi (in ciò seguendo fedelmente il metodo marxiano) sugli interessi materiali e le molteplici contraddizioni (non solo strettamente economiche) che possono muovere un blocco sociale verso il superamento graduale del rapporto sociale capitalistico e la costruzione di relazioni sociali, economiche e politiche i cui cardini materiali siano la graduale dissoluzione della divisione in classi (e quindi dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo) e la cooperazione solidaristica (al posto della valorizzazione come fine e della concorrenza come esito).
Risposte univoche, per il momento, non ve ne possono essere. Di certo non sono una soluzione al problema né le teorie fideistiche sociologiche sulla centralità dei marginali e degli esclusi, né le fughe immaginifiche su improbabili ed inesistenti moltitudini desideranti. Risposte parziali e tentativi di ragionamento e di analisi sono invece al centro della nostra elaborazione politica. Elaborazione che vede come concetto cardine di riflessione quello di “comunità”, affiancato nella stessa denominazione della rivista e del laboratorio, a quello di “comunismo”.
6. Il concetto di “comunità” può avere, contestualmente tre diversi significati o accezioni: in primo luogo “comunità” come forza espressiva coagulante per la formazione di un blocco sociale di opposizione alle dinamiche capitalistiche, unito, oltre che da comuni condizioni di subalternità rispetto ai chi detiene il potere decisionale e i benefici economici, anche dalla critica della mercificazione delle relazioni sociali con conseguente necessità di riappropriazione della stessa natura sociale comunitaria (in senso strutturale e non puramente volontaristico e spontaneistico). Comunità quindi come forza per il rivolgimento della società capitalistica, che può essere costruita ed aggregata sulla base di criteri più vasti del puro criterio economico, anch’esso ovviamente decisivo (e comunque da reinterpretare in un senso più articolato rispetto alla pura e in un certo senso riduzionistica divisione capitale-lavoro); in secondo luogo il concetto di “comunità” può assumere il significato di critica ad ogni tentazione verso un comunismo individualistico e abolizionistico, inteso utopisticamente come soluzione finale della contraddizione tra Uomo e Uomo e riconciliazione tra Uomo e Natura (del comunismo pensato in termini non individualistici tratta l’articolo “Comunismo comunitario”). Comunità quindi come struttura (e non come aggregazione spontanea), base stessa della natura ontologica umana e intermediazione fondamentale tra particolare ed universale, tra persona e totalità (del rapporto tra comunitarismo e universalismo tratterà nella rivista parte dell’intervista a Costanzo Preve).
Su questa base sorge anche la necessità di una teoria dello Stato comunista-socialista (come esplicitato nell’articolo “Il problema dell’assenza di una teoria etico-politica del comunismo in Marx e l’utopia dell’estinzione dello Stato”) come elemento di intermediazione strutturale politica complessiva, dal momento che il comunismo non è riducibile alla semplice liberazione dalle relazioni produttive capitalistiche e il conseguente naturale instaurarsi di relazioni di cooperazione tra liberi produttori senza Stato, senza Politica, senza Diritto, in una parola senza strutture sistemiche (secondo l’idea insostenibile della pura “amministrazione tecnica delle cose” al posto del “governo sugli uomini”).
Infine “comunità”, va inteso, in quanto concetto, come un richiamo alle radici solidaristiche strutturali dell’ideale comunista, in contrasto con l’univocità esclusiva dell’idea di liberazione sociale dallo sfruttamento e dal bisogno materiale ed a partire da una concezione di libertà in quanto libertà per qualcosa ed in qualcosa. Sulla base di questa terza accezione si fonda la, già più volte espressa, critica delle concezioni sociali nichilistiche (anche se travestite da anticapitalismo), ovvero di tutti quegli orientamenti di pensiero che al disordine capitalistico oppongono un disordine “solidale” fondato sull’apologia dell’autodeterminazione individuale assoluta.
Sulla base di queste tre accezioni, si struttura quella che è la nostra riflessione politica sul concetto di “comunità” sia come tentativo di proporre una critica radicale del capitalismo ed un’ articolata riflessione sul significato ed il senso del Comunismo, sia come possibilità insieme simbolica e oggettiva di fuoriuscita (nella prassi) dal Capitalismo.

[...] editoriale della rivista Comunismo e Comunità [...]
[...] editoriale della rivista Comunismo e Comunità Share this:TwitterFacebook [...]